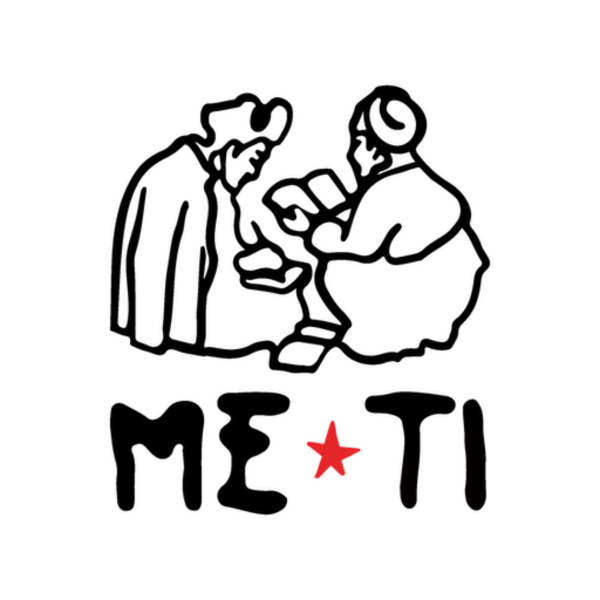La necessità di incorporare gli uomini nel femminismo non ha a che vedere solo con la difesa dei diritti. Ci riguarda anche perché vengono messi in discussione dei ruoli di genere che impongono agli uomini forme rigide e limitanti di esistere e di stare al mondo. (…) Sottolineare gli effetti negativi che questa idea di mascolinità ha sugli uomini non significa distogliere l’attenzione dalla disuguaglianza e dal maschilismo. Infatti, questi effetti sono proprio il prodotto della concezione maschilista e sessista della nostra società1
Negli ultimi giorni in rete non si fa che parlare di Adolescence, mini-serie britannica di 4 episodi uscita recentemente su Netflix, ideata da Jack Thorne e Stephen Graham e diretta da Philip Barantini.
La storia, probabilmente, la conoscete già: un ragazzino di 13 anni, Jamie è accusato di aver ucciso una sua compagna di scuola, Katie. Nel corso delle puntate (cerchiamo di evitare spoiler!) emergeranno, nell’indagare il rapporto tra i due ragazzini, il ruolo dei social, il mondo incel e la manosfera, le tensioni e l’odio di genere che fanno da sfondo alla vicenda. Gli inquirenti capiscono poco, i genitori ancora meno, gli insegnati proprio niente. Il mondo di Jamie, Katie e degli altri adolescenti è imperscrutabile e chiuso, fatto di codici e discorsi che restano incomprensibili agli adulti.
Si è detto che questa serie parla dell’incomunicabilità tra genitori e figli, di misoginia e, ovviamente, di violenza contro le donne. Tutto ok, tutto giusto. Quello che però non emerge dalle recensioni e critiche lette in rete su questo prodotto è la difficoltà del maschile.
Il tema è ovviamente delicato, scivoloso, e sembra che pochi vogliano “sporcarsi” le mani parlandone. Probabilmente c’è il timore, anche in parte fondato, che un discorso sulle difficoltà di un ragazzino che uccide perché ha paura di essere marchiato per sempre dall’infamia dell’indesiderabilità – in una società in cui essere desiderabili è tutto – rischi di essere giustificazionista, di far perdere di centralità alla questione della violenza di genere. Qui non si tratta però di giustificare, ma di capire, e soprattutto di capire cosa fare.
Ci sembra che le due questioni – Jamie che vuole uccidere, Jamie che si sente vittima – possano essere affrontate assieme. Anzi di più: che debbano esserlo. Perché provengono da una fonte comune, sono prodotti del patriarcato. Che non è una linea che spacca a metà il mondo, uomini cis (privilegiati) da una parte, e dall’altra tutto il resto. Ma che, esattamente come il sistema capitalistico col quale concresce, si intreccia e al quale è funzionale, avvantaggia pochissime persone e schiaccia tutte le altre.
Questo aspetto è messo a fuoco da Rita Segato nella sua riflessione sull’ingiunzione di mascolinità: “l’ingiunzione di mascolinità esige che l’uomo si affermi come uomo continuamente perché la mascolinità, a differenza della femminilità, è uno status, una gerarchia di prestigio che si acquisisce come un titolo e che si deve rinnovare e comprovarne la vigenza”2. Così lo stupro, e più in generale ogni forma di violenza, di abuso e rivalsa contro le donne ruota intorno a due assi: quello verticale che lega aggressore e vittima, attraverso il quale chi fa violenza mostra la sua capacità di essere spietato, di saper rispondere ai (presunti o veri) torti e offese subiti (Katie che sbeffeggia Jamie, che gli ricorda qual è la sua posizione nella gerarchia scolastica/sociale, quella dei perdenti). Questa risposta violenta non è rivolta però solo alle donne che la subiscono, ma passa anche per un altro asse, ci dice Segato, orizzontale, che ha a che fare con la relazione con gli appartenenti a un medesimo gruppo, con gli altri uomini (Jamie che diventa un simbolo in rete). Bisogna, attraverso la violenza – verbale, fisica, nelle sue diverse forme e gradi – affermare un legame, “dimostrare all’altro, al confratello, al complice che si è potenti per trovare nello sguardo di questo altro riconoscimento di aver portato a termine la richiesta dell’ingiunzione di mascolinità”3.
Se Jamie desidera cancellare dalla faccia della terra Katie, e con lei tutte le donne, se il maschio diventa psicopatico4 – e questo non significa che tutti lo siano, tendano a esserlo o siano destinati ad esserlo – è perché la funzione che gli è consegnata e imposta è quella del dominio, quando non riesce a imporla attraverso i suoi successi, affermando l’egemonia della propria posizione, quando fallisce, o si avvita su sé stesso oppure prova a distruggere l’altro.
Il punto allora non è (come voleva farci credere la pubblicità dei rasoi Gillette di qualche anno fa) che il patriarcato opprime anche gli uomini perché, banalmente, non lascia la possibilità di piangere, c’è molto altro e molto di più della facoltà di esprimere i propri sentimenti o esplorare la propria intimità. In gioco c’è la possibilità di costruirsi come soggetti che non debbano rispondere a quell’ingiunzione maschile di cui parla Segato, che non è solo ingiunzione alla violenza, al rispetto delle regole del gruppo (o del branco che dir si voglia) e della sua gerarchia interna, a dare una risposta adeguata alla pressione sociale. Ma in gioco c’è anche la possibilità di rifiutare il meccanismo capitalista dello “scarto” e, per rovescio, dell’appropriazione e dello sfruttamento, che passa per la messa al lavoro di alcuni corpi, per la sottomissione violenta di altri5.
Il tentativo di uscire da una condizione di instabilità materiale e esistenziale può essere letto come desiderio di restaurare un privilegio (e sicuramente questo tratto esiste e viene reso sempre più ipertrofico) ma al di sotto di esso, e andrebbe ri-politicizzata e fatta emergere, c’è anche la ricerca di una propria stabilità, voce e di una propria dignità.
“Come molte femministe radicali visionarie, ho contestato l’idea, sbagliata, avanzata da donne semplicemente stanche dello sfruttamento e dell’oppressione maschili, che gli uomini fossero il nemico (…) sollecitando i sostenitori della politica femminista a contestare la retorica che attribuisce ai soli uomini la colpa di perpetuare il patriarcato e il predominio maschile”6. L’ideologia patriarcale prova a fare il lavaggio del cervello alle donne, cercando di renderle complici, e agli uomini, provando a fargli credere di essere vantaggiosa per loro, mentre invece non lo è. “L’oppressione maschile delle donne non può essere giustificata dal fatto che anche gli uomini soffrano a causa di rigidi ruoli sessisti” però bisognerebbe “riconoscere questo dolore a impegnarsi per eliminarlo, perché esiste”, anche se questo ovviamente “non cancella e ne riduce la responsabilità nei maschi nel sostenere e perpetuare il proprio potere patriarcale”7.
La questione che poniamo non è morale o almeno non è soltanto morale. È una questione anche e soprattutto politica.
Ce lo racconta bene Houria Bouteldja (si veda un nostro articolo sul suo ultimo libro qui) quando, parlando delle mascolinità non egemoniche, ovvero di quegli uomini e gruppi di uomini, che godono solo in maniera molto astratta o limitata del cosiddetto privilegio maschile, sottolinea che sono ipersfruttati, marginalizzati, ma soprattutto che sul piano dell’identità e del racconto pubblico non trovano alcuno spazio. E così finiscono a contendere quello spazio alle donne che invece, a fatica e ancora troppo parzialmente, l’hanno conquistato. Che hanno cercato e trovato una loro voce.
Si tratta di un problema politico, dicevamo. Perché la falsa contrapposizione tra maschi poveri, razzializzati, che vivono in condizioni di precarietà, e donne e persone della comunità queer, serve solo a spaccare in due un fronte che sarebbe altrimenti naturalmente unito da interessi simili. Quelli legati alla necessità uscire da una condizione di oppressione e di abbandono, di trovare un proprio posto nel mondo.
La stessa operazione fatta per il razzismo, ovvero quella di scaricarne il peso sul piano intersoggettivo, di individuarne la matrice esclusiva nell’inclinazione individuale, nell’ignoranza, etc. è oggi sempre più fatta anche per il sessismo e quando si parla di violenza contro le donne. Si sposta la questione da un piano strutturale – che non vuol dire solo sistematico, ma che ha a che fare con la struttura economica, con la possibilità di espropriare l’altro, di sfruttarlo – a un piano individuale.
La responsabilità del sessismo e della violenza di genere è stata di fatto subappaltata alle classi popolari e agli scarti: è colpa dei poveri, dei “disadattati” degli ignoranti, dei rozzi, degli “psicopatici”. Imbavagliamoli, imprigioniamoli, rendiamoli inoffensivi e tutto sarà risolto.
Frustrazione, risentimento, violenza, non sono la causa, sono l’effetto. Se non lavoriamo assieme per riorientarli, se non ne estirpiamo le radici, probabilmente ci sarà qualcun altro che le farà crescere sempre più profonde e vigorose. Lo stiamo già vedendo, sono in molti, nella destra autoritaria e non solo, a cavalcare questi sentimenti, a renderli politici, ovvero a fornire un quadro collettivo in cui collocarli – “ragazzo, la tua non è frustrazione individuale ma legittima rivendicazione di potere” – e a ricavarne consenso.
Nel libro di grandissimo successo di Naomi Alderman Ragazze elettriche (nel 2023 ne è stata tratta anche una serie per Prime Video) si racconta di un futuro prossimo in cui le donne hanno acquisito dei superpoteri e gli uomini sono finalmente ridotti all’impotenza. In Un mondo di donne (ed. Fanucci 2021) di Lauren Beukes si racconta di una pandemia che porta all’estinzione di quasi tutti gli uomini. Entrambi i mondi non sono poi così pacificati o liberati. Perché le linee dell’oppressione, della violenza, che storicamente si incarnano nel maschile, non hanno a che fare con un’essenza mitica: non basta cancellare gli uomini, separarsi da loro, renderli innocui per essere al sicuro. Per metterci in salvo c’è bisogno di spezzare il meccanismo profondo della sopraffazione, che può avere molti volti e molti modi di esprimersi.
“È un’invenzione del falso femminismo che noi donne possiamo scoprire il nostro potere in un mondo senza uomini, in un mondo in cui neghiamo i nostri rapporti con loro. Rivendichiamo pienamente il nostro potere solo quando possiamo dire la verità: che abbiamo bisogno degli uomini nella nostra vita, che gli uomini fanno parte della nostra vita a prescindere dalla nostra volontà, che abbiamo bisogno di loro per sfidare il patriarcato, che abbiamo bisogno di loro per cambiare”8.
- J. Riviere Aranda, Gli uomini nel femminismo, in Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità, di prossima pubblicazione per ed. Me-Ti. ↩︎
- Rita Segato, Contro-pedagogie della crudeltà, Manifestolibri, 2024, p. 54. ↩︎
- Ivi, p. 59. ↩︎
- Ibidem. ↩︎
- Cfr. N. Fraser, Capitalismo cannibale, Laterza 2023. ↩︎
- bell hooks, La volontà di cambiare. Mascolinità e amore, il Saggiatore, 2022, p. 43. ↩︎
- Ivi, p. 44. ↩︎
- Ivi, p. 12. ↩︎