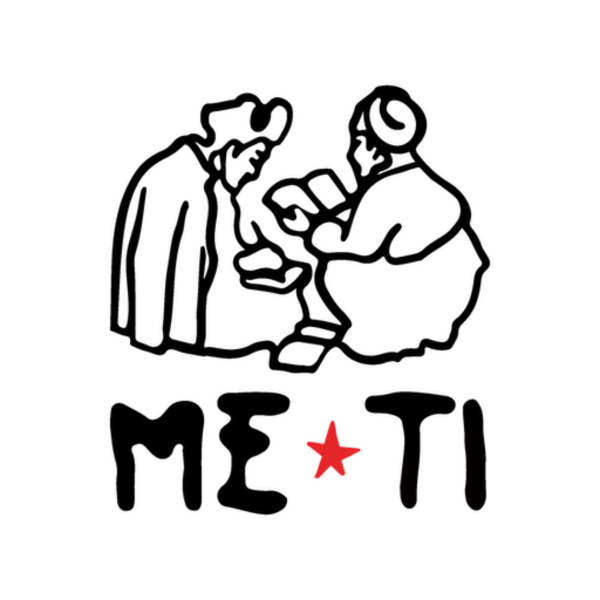Abbiamo molto parlato di quanto la causa palestinese sia intrinsecamente transfemminista e di come invece Israele abbia utilizzato il pink e rainbow whashing per fare propaganda e accreditarsi come paese moderno, “progredito”, dove si rispettano i diritti civili1.
In questo articolo di Sophie Lewis – pubblicato l’8 marzo 2024 sulla rivista Salvage Zone – si parla della storia del femminismo sionista fin dalle sue origini e di come la liberazione delle donne sia stata associata a processi coloniali ed estrattivi. Questa ricostruzione è preziosa per diversi motivi: ci mostra come le nostre istanze possano essere stravolte e utilizzate per bieca propaganda, ma soprattutto mette in evidenza come un’analisi dei rapporti di genere (ma anche religiosi, interetnici, della questione ecologica, etc.) svincolata da una lettura sistemica dei meccanismi di oppressione, non solo finisca per offrirci una visuale limitata e distorta di questi meccanismi, ma addirittura per contribuire al loro rafforzamento e alla loro perpetuazione.
***
Il 7 marzo 2017, il giorno prima della Giornata Internazionale della Donna, il New York Times ha pubblicato un editoriale della direttrice della rivista Bustle, Emily Shire, che denunciava l’antisionismo di una rete socialista-femminista, l’International Women’s Strike. “Non vedo alcun motivo per cui dovrei sacrificare il mio sionismo per il bene del mio femminismo”, si lamentava Shire riguardo all’appello femminista dell’8 marzo per lo sciopero, citando la piattaforma propalestinese. Era particolarmente turbata dalla presenza di Rasmea Odeh, ex membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, nel comitato organizzativo dello sciopero, così come dalla crescente popolarità del movimento Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) contro lo Stato di Israele per le sue violazioni dei diritti umani. Sostenere BDS “non ha nulla a che fare con il femminismo”2, affermava frustrata Shire. Nella polemica che ne seguì, la co-presidente della Women’s March, Linda Sarsour, spiegò perché il BDS è una tattica femminista3; e l’attrice di The Big Bang Theory, Mayim Bialik, replicò dichiarandosi una femminista sionista e aggiungendo che “non avrebbe potuto tollerare di essere accusata di essere «il nemico» in questo modo”4.
Sette anni dopo, la Giornata Internazionale della Donna cade esattamente cinque mesi dopo l’inizio di un genocidio finanziato dagli Stati Uniti contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Nell’arco di questa eternità invivibile – dall’inizio delle rappresaglie genocidarie di Israele contro l’attacco guidato da Hamas alle basi militari israeliane e agli insediamenti civili del 7 ottobre 2023 – la questione del femminismo sionista si è fatta conoscere su scala globale come mai prima d’ora. Un mondo che si solleva nell’indignazione contro le atrocità di Israele si scontra con un sistema mediatico che a malapena riesce a rappresentare la soggettività palestinese persino a livello sintattico. I media si rifiutano di nominare chi perpetra il genocidio di Gaza [letteralmente cosmicide, ovvero cosmicidio, N.d.T] tranne quando, curiosamente, gli autori possono essere ritratti nei panni di una banda di giovani e attraenti lesbiche e/o femministe in divisa militare. Ecco che vediamo articoli celebrativi corredati da un gran numero di fotografie: “Leonesse del deserto: all’interno dell’unità di carri armati tutta al femminile di Israele”5 (Daily Mail), “Donne israeliane combattono in prima linea a Gaza, novità”6 (New York Times), e così via. Quest’anno desidero offrire queste riflessioni su un’ideologia in crisi [il sionismo N.d.T.], nella speranza che sia un modo per onorare le sue vittime e, mi auguro, accelerarne il crollo.
Storicamente parlando, il femminismo sionista condivide caratteristiche fondamentali con i femminismi coloniali del diciannovesimo secolo. È sorto come uno strumento per forgiare una nuova modernità nazionalista – intrecciata con utopismo laburista borghese – portando con sé un’ambizione palingenetica di rinascita civilizzatrice legata a una narrazione alternativa del proprio destino razziale come intrinsecamente egualitario dal punto di vista di genere. “Non è possibile”, scriveva l’attivista femminista e sionista polacca Puah Rakovsky nel suo opuscolo del 1918 La donna ebrea, “che noi ebrei, che siamo stati i primi portatori dei principi democratici, dovremmo rimanere indietro rispetto a tutti i popoli civilizzati e chiudere la strada alle donne nella conquista dell’uguaglianza dei diritti”7. (La versione britannico-imperiale di questa idea, sviluppatasi significativamente prima, era anch’essa incentrata sul “ricordare” ai britannici un mitico passato di armonia anglosassone caratterizzato da una vera uguaglianza tra i sessi. Ricordate come Jane Eyre, verso la fine dell’omonimo romanzo, discute del bisogno spirituale del mondo di donne inglesi indipendenti che emigrino per servire come missionarie e insegnanti nelle colonie? L’eroina di Charlotte Brontë emula la figura energica e intraprendente della “nuova donna inglese modello”, che parte per ripulire vari disastri morali causati dagli uomini in Australia, Canada e India. “Miss Jane Bull un’icona patriottica, fu un’invenzione degli anni 1840 delle femministe di Langham Place a Londra pensata principalmente per incoraggiare e organizzare questa emigrazione a servizio della Corona.)
Che fosse coloniale o coloniale di insediamento, sionista o imperialista, il femminismo europeo d’élite del XIX secolo alimentava tra le donne irrequiete e soffocate il desiderio di un vasto Lebensraum [spazio vitale] personale che le attendeva all’estero se si fossero trasferite a vivere tra gli “indigeni”. Sion come luogo in cui le donne potessero spiegare le ali: nel XXI secolo si possono facilmente udire gli echi di questa idea storica negli scritti di hasbaristi [propagandisti N.d.T.] come Amotz Asa-El, fellow della Columbia University. Asa-El rispolvera abitualmente le vecchie sfumature del femminismo etnonazionalista quando scrive – erroneamente, peraltro – che “il movimento sionista ha concesso alle donne il diritto di voto già nel 1897, decenni prima di molti paesi occidentali”8. (Secondo il Friends of Zion Museum, alcune donne parteciparono effettivamente al primo Congresso Sionista, a Basilea, in Svizzera, nel 1897, ma senza diritto di voto9. L’anno successivo, in vista del secondo congresso, Theodor Herzl annunciò che le donne avrebbero avuto diritto di voto all’interno delle istituzioni dello Yishuv – una testimonianza della sua visione modernizzatrice della costruzione dello Stato10. Tuttavia, questa decisione fu ignorata fino al 1917, quando le suffragette nella Palestina ottomana, come Nehamah Pukhachewsky di Rishon LeTzion, iniziarono a ricordare ai loro compagni coloni questa antica concessione del diritto di voto: “Non possiamo più vivere senza pieni diritti di uguaglianza. Noi che costruiamo l’insediamento insieme agli uomini… Dateci ciò che è nostro”11.) I fatti concreti sulla condizione spesso sofferta delle donne in quello che presto sarebbe diventato il Mandato Britannico di Palestina e poi, nel 1948, Israele – dove ancora oggi gli ultraortodossi si oppongono al suffragio universale – raramente sembrano offuscare la percezione da parte delle femministe sioniste di Israele come avamposto straordinariamente avanzato della femminilità ebraica emancipata circondato da un mare di arretratezza patriarcale araba e/o musulmana. Durante un’intervista con la rivista Lilith, intitolata “Una sionista suo malgrado”, la femminista novantenne Judith Shotten descrive il suo trasferimento dal Canada a Israele nel 1949 e la sua esperienza di “incredibile uguaglianza” di genere nei kibbutz. Agli occhi della giovane Judy, dal punto di vista femminista, Israele era all’avanguardia: un’utopia coloniale di genere tale che “tutto il mio antinazionalismo e universalismo andarono a farsi benedire”12.
Le femministe sioniste di mia conoscenza non ammettono mai l’etnonazionalismo della loro idea di emancipazione di genere in modo così esplicitamente vivido. Tuttavia, da circa un decennio, “femminismo e sionismo sono due facce della stessa medaglia” è diventato un ritornello di testate come il Jerusalem Post. Persino attivisti di J Street orientati alla “giustizia sociale” hanno cercato di sostenere che è perfettamente possibile essere “una femminista sionista” se si espande “la nostra comprensione del sionismo fino a includere il sostegno ai diritti sia degli israeliani che dei palestinesi”13 – un sè piuttosto gravoso/colmo di conseguenze. Alla Israel Forever Foundation, invece, una blogger chiamata Forest Rain Marcia non fece concessioni simili a Linda Sarsour nel 2017, sostenendo con enfasi che femminismo e sionismo sono entrambi fondamentalmente “questioni di libertà” (lo può dire perché “uomini e donne sionisti vennero in Israele, ararono i campi e costruirono case insieme. Combatterono i nemici fianco a fianco. Insieme costruirono un paese, insieme diedero vita alla Start-Up Nation”14). In una rubrica del 2020, un giornalista di Y-Net arrivò persino ad affermare che “non si può essere femministe senza essere sioniste”, basando la sua argomentazione su un’analogia tra una definizione altamente discutibile dell’obiettivo del sionismo – “che gli ebrei diventino i padroni del proprio destino” – e quello del femminismo: “che anche le donne possano essere padrone del proprio destino”15.
Questo linguaggio del dominio sovrano di sé richiama forse inconsciamente una visione di nazionalismo femminile: una posizione che, di fatto, fu sinceramente adottata per un certo periodo tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 dalle lesbiche separatiste ebree-americane e difesa da Andrea Dworkin16, ad esempio nel suo libro Scapegoat: The Jews, Israel, and Women’s Liberation – che invoca una “patria” per le donne sul modello israeliano – e questo persino nel XXI secolo. Poco prima dell’invasione israeliana del Libano nel 1982, la direttrice della rivista Ms., Letty Pogrebin, dichiarò: “Il sionismo è semplicemente un piano di discriminazione positiva su scala nazionale”17. L’invasione causò circa 20.000 vittime civili e ne ferì cinque volte tante, spingendo molte femministe della diaspora ebraica a insorgere contro le presunte guerre di liberazione nazionale e di genere combattute in loro nome. Alcune settimane dopo l’inizio dell’“Olocausto” – per citare Ronald Reagan – del 1982, la rivista femminista Spare Rib intervistò tre attiviste per la liberazione delle donne: Aliza Khan, un’israeliana, e due attiviste, una palestinese e una libanese, identificate solo con i loro nomi di battesimo, Randa e Nidal. Insieme, tutte e tre dichiararono inequivocabilmente l’incompatibilità tra femminismo e sionismo. “Quello che Israele sta facendo ora non è nulla di nuovo, ma una parte estrema della sua natura”, spiegò Khan: cioè “uccidere persone barbaramente, bambini, donne, con gas velenosi e bombe a grappolo”. Persino la madre di Khan, che era emigrata in Israele dalla Germania, ora si stava rendendo conto della verità sul sionismo. Era sempre più ovvio per le femministe ebree di tutte le generazioni che “le donne devono schierarsi contro di esso perché le nostre sorelle vengono assassinate”. E in effetti, “se una donna si definisce femminista, dovrebbe consapevolmente definirsi anti-sionista”. Un punto ovvio per quanto riguarda lo Women’s Strike di oggi.
Al momento della stesura di questo testo, il campo sionista-femminista è lacerato da defezioni e caos, proprio come l’intero “sionismo liberale” (o ciò che ne resta). È sembrato quasi naturale che la “madre del femminismo israeliano”, Alice Shalvi – fervente sostenitrice della partecipazione femminile nell’esercito d’occupazione che fondò nel 1984 l’Israel Women’s Network bipartisan – sia morta proprio pochi giorni prima che “l’esercito più morale del mondo” iniziasse a far piovere fosforo bianco sulla più grande prigione a cielo aperto del mondo, in nome, tra le altre cose, delle sopravvissute agli stupri e dei diritti delle donne. Alcune delle femministe che hanno pubblicamente pianto Shalvi hanno cercato nuovi riferimenti per il culto fascista dell’icona femminile (vedi le nostre squadre di carri armati interamente femminili delle Zionesses™); altre hanno adottato un silenzio di pietra, presumibilmente carico di vergogna, riguardo alla nuova Nakba in corso; altre ancora hanno semplicemente approfondito il loro impegno nella vecchia filosofia e pratica dello “spara-e-piangi”18, per esempio sentendosi sollevate del fatto che Alice fosse morta prima che “lo shock degli attacchi di Hamas del 7 ottobre potesse ucciderla”19. Tutte devono sopportare di essere accusate di essere il nemico – cioè, il mio nemico, e il nemico di tutti i femminismi abolizionisti – ogni minuto di veglia, e così deve essere.
Il 5 dicembre, Benjamin Netanyahu ha iniziato a martellare le “organizzazioni per i diritti delle donne” di tutto il mondo per il loro silenzio riguardo ai presunti “stupri di donne israeliane” avvenuti due mesi prima20. Non avevamo forse sentito parlare delle indicibili “mutilazioni” che le orde musulmane, fuggite dalla loro prigione, avevano inflitto a ragazze e madri nei kibbutz intorno a Gaza? Seni tagliati con taglierini21. Fu in quel periodo che cominciai a notare un aumento di materiali sionisti-femministi patinati e instagrammabili nei miei feed social: grafiche che esortavano le femministe a “credere alle donne israeliane”, e hashtag che denunciavano l’antisemitismo, lamentando che “#metoo vale per tutte, tranne che per le ebree”22. In realtà, l’Operazione Al-Aqsa Flood aveva appena “calpestato le fondamenta stesse del femminismo”23. Secondo il già citato fellow della Columbia gli eventi del 7 ottobre hanno infuso “nuova rilevanza all’eredità di de Beauvoir”: così scriveva il professor Asa-El in quel bastione storico del fandom e della ricerca su Simone de Beauvoir che è il Jerusalem Post. La tesi di Asa-El è che le “donne israeliane hanno confermato la teoria di de Beauvoir”, essendo, ehm, semplicemente donne mentre mitragliavano le brigate di Al-Qassam come membri dell’IDF. Egli descrive con enfasi “le guerriere di Israele” – “le nostre guerriere” – e in particolare una comandante di squadrone di carri armati e altre due combattenti in uniforme patriottica: le chiama in modo intimo con i loro nomi di battesimo “Inbal, Karni, Tal”, e afferma che in quel fatidico giorno queste donne erano “tutto ciò che de Beauvoir sosteneva che una donna potesse essere, se solo le fosse data l’opportunità: assertiva, intraprendente, lucida e coraggiosa”. Sicuramente l’esistenzialista anticoloniale avrebbe approvato il genocidio dei palestinesi come una guerra per la giustizia sessuale.
In quest’atmosfera di bramosia di sangue, travestita da un falso e rozzo intellettualismo, abbiamo sentito versioni insolitamente esplicite della solita favola occidentalista su “l’unica democrazia del Medio Oriente”. Secondo l’ex direttrice del Times britannico, Sarah Vine, “un nuovo asse del male misogino sta travolgendo il mondo”24; chiaramente, coloro che stanno dalla parte di quelli che Bibi chiama “i figli della luce” dovrebbero essere fieri della loro islamofobia perché “la liberazione delle donne è stata parte integrante dell’ideale sionista fin dalla sua nascita”25. La femminista americana transfobica Abigail Shrier accusa ogni progressista che si opponga al “diritto di Israele a esistere” come stato suprematista ebraico di essere un barbaro bigotto, guidato dall’odio per “una civiltà pacifica”, nello stesso modo in cui gli “eco-guerrieri” che “vandalizzano l’Arco di Wellington nel centro di Londra” chiaramente “disprezzano la civiltà che culla tali tesori”26. Gil Troy, autodefinitosi “storico americano e pensatore sionista” presso la McGill University, ha tuonato su Tablet Magazine dicendo che Hamas porterebbe avanti un “culto dello stupro” e avrebbe orchestrato un “crimine di massa contro le donne”, quindi “tutte le persone civili dovrebbero ripudiare il piacere con cui molti palestinesi e progressisti condividono questi video e applaudono a questi crimini”27. Il discorso pubblico è stato impostato sulla retorica della “guerra al terrore “ cinque mesi fa e vi è rimasto bloccato. Molti opinionisti probabilmente credono ancora, persino adesso, di dire la verità quando urlano, in termini vaghi ma vividamente plastici, degli innumerevoli, innumerevoli stupri perpetrati il 7 ottobre.
La polizia israeliana aveva promesso che sarebbero emerse “decine di migliaia” di testimonianze di violenze sessuali commesse da Hamas quel giorno. Mai pervenute. Ciononostante, molte femministe statunitensi hanno sostenuto la propaganda che giustificava il genocidio. La rivista Ms. ha pubblicato una lista di letture su “lo stupro come arma di guerra”, ispirata da “resoconti di prima mano di ciò che è accaduto in Israele il 7 ottobre”28. (L’elenco delle fonti inizia con citazioni senza attribuzione, presumibilmente di sopravvissute, riportate in forma anonima dalla polizia nazionale israeliana, insieme a racconti di brutalità già smentiti provenienti da riservisti dell’esercito israeliano. Non è mai stato aggiornato o corretto.) Sheryl Sandberg, ex direttrice operativa di Meta™ e celebre autrice di Lean In, ha parlato pubblicamente della sua rabbia contro le femministe “che restano in silenzio” di fronte ai “terroristi di Hamas”: secondo lei, avrebbero perpetrato “stupri premeditati, coordinati, in più località, tutti in un solo giorno, e una violenza sessuale incredibile”29. Persino Katha Pollitt, editorialista di The Nation e nota femminista di sinistra, ha scritto che “bisogna essere complottisti o negazionisti degli stupri” per liquidare i racconti israeliani sugli stupri sistematici di Hamas come semplice hasbara [propaganda N.d.T.]30. Helen Lewis, su The Atlantic, ha scritto che potrebbe tollerare, in circostanze specifiche, che delle suffragette mettano bombe per una giusta causa, ma non i metodi dell’“incursione da Gaza in Israele”.
Jill Filipovic ha affrontato in modo creativo l’assenza di prove, assicurandoci nella sezione opinion del New York Times che è normale, in tempo di guerra, che non ci siano prove corroborate o verificabili in modo indipendente, mentre al tempo stesso affermava in modo paradossale che “ce ne sono molte, molte di più”31. In passato, scrivendo degli stupri di guerra, Filipovic dichiarava di aver sempre “trattenuto la lingua e la penna, aspettando che emergessero reportage sostanziali e prove più chiare”. (Dopotutto: “le accuse di stupro sono estremamente delicate, e affermazioni non corroborate che si rivelano esagerate o false possono minare la fiducia del pubblico nei giornalisti e nella veridicità delle denunce di violenza sessuale in generale”). Ma questa volta, non avrebbe taciuto. Echeggiando molti altri stenografi di Stato che si spacciano per “giornalisti”, ripetendo a pappagallo ciò che dice Bibi, Filipovic ha affermato, al contrario, che tra coloro che tacevano non ci fossero veri femministi.
Un altro articolo dello stesso genere – rivolto alle “femministe del mondo intero” su Slate – affermava spudoratamente che “la solidarietà verso le vittime di violenza sessuale dovrebbe avere la precedenza su qualsiasi altra politica”. In altre parole, lo stupro è paragonabile al genocidio. “Tra tutti gli orrori che emergono” dalla guerra genocida contro Gaza – hanno scritto Dahlia Lithwick, Mimi Rocah, Tamara Sepper, Jennifer Taub, Joyce White Vance e Julie Zebrak, alla fine di novembre, quando erano già stati confermati 15.000 palestinesi uccisi – “i più orribili sono gli omicidi barbari, gli stupri, le aggressioni sessuali e i rapimenti di donne e bambine in Israele durante l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas”32.
Il 28 febbraio, The Intercept ha pubblicato un’inchiesta su un’inchiesta. Intitolata Between the Hammer and the Anvil33 [tra l’incudine e il martello], analizza in profondità una delle tante gocce pesanti del giornalismo del New York Times che, senza dubbio, ha contribuito materialmente alla distruzione indiscriminata di Gaza da parte di Israele (legittimandola). Il lavoro di demistifazione è meticoloso e il risultato è una lettura devastante. I tre co-autori smascherano la costruzione forzata di una narrativa femonazionalista sulla brutalità sessuale palestinese. Jeremy Scahill, Ryan Grim e Daniel Boguslaw – tutti giornalisti di The Intercept – dimostrano quello che si può solo definire un palese tentativo di manipolazione: la fabbricazione di distrazioni mirate a influenzare femministe occidentali come me durante un genocidio, progettate per farci simpatizzare con i colonizzatori, non con i colonizzati. Mi riferisco qui al femonazionalismo34, un concetto che potreste ricordare dall’epoca della guerra al terrorismo, che molti di noi speravano fosse ormai superata.
Lo stratagemma femonazionalista è il nome di un meccanismo ben rodato attraverso cui le femministe occidentali vengono moralmente ricattate per sostenere una causa imperiale, ovvero “dobbiamo unirci nella lotta contro la barbarie sessuale”, con pesanti riferimenti al patriarcato orientale. Il femonazionalismo è ciò che definisce, di fatto, il sentimento civilizzatore instillato nei cittadini del centro imperiale durante campagne militari di punizione collettiva che richiedono la disumanizzazione islamofoba dei “barbari”in questione; campagne che traggono beneficio dal seminare dubbi e incertezze tra gli alleati dei colonizzati. L’articolo del New York Times del 28 dicembre 2023, Screams Without Words, scritto da Jeffrey Gettleman, Anat Schwartz e Adam Sella, è stato un capolavoro di questo genere.
Screams Without Words era un resoconto sensazionalistico della sofferenza e della violazione femminile israeliana per mano di “gazawi scatenati”, pubblicato in un momento cruciale del genocidio. Sottotitolato “Come Hamas ha usato la violenza sessuale come arma il 7 ottobre”, si basava in gran parte su interpretazioni immaginifiche e prive di competenze forensi di scene del crimine fornite da ZAKA, un’organizzazione privata ultra-ortodossa di soccorso già accusata di aver diffuso molteplici false storie e di aver manomesso prove35. L’articolo faceva affidamento su racconti incredibilmente incoerenti di due soldati, partecipanti a un festival che nascosti tra i cespugli avevano raccontato ciò che avrebbero visto: i due soldati in questione sono il veterano delle forze speciali Raz Cohen e il suo compagno Shoam Gueta (che ora pubblica video su TikTok in uniforme mentre rovista tra le macerie delle case di Gaza)36. Sono le “urla senza parole” di una donna non identificata, vista – o forse solo sentita? – da Cohen mentre veniva stuprata da cinque “civili” di Gaza, a dare il titolo all’articolo del Times su “Hamas” (una contraddizione in sé, se si trattava di civili, come nota The Intercept).
Inoltre, Screams Without Words si basava sulla testimonianza di Shari Mendes, un’architetta americana che presta servizio come riservista in un’unità rabbinica delle forze di difesa israeliane. Nell’ottobre 2023, Mendes aveva dichiarato al Daily Mail che “un bambino era stato estratto dal grembo di una donna incinta, decapitato, e poi anche la madre era stata decapitata”37, ma l’elenco ufficiale israeliano delle vittime non include nessuna donna incinta. Inoltre, Mendes non possiede alcuna qualifica forense o medica. Eppure, è apparsa ovunque, dalle Nazioni Unite alle principali piattaforme mediatiche, dopo il 7 ottobre, raccontando le sue esperienze con i “cadaveri israeliani stuprati” che avrebbe preparato per la sepoltura in obitorio. Quando la giornalista del New York Times, Anat Schwartz, ha intervistato Mendes, la storia del “feto decapitato” aveva già fatto il giro del mondo ed era stata definitivamente smentita. Tuttavia, Mendes, così come altre fonti già note per la loro inaffidabilità, sono state comunque incluse nel resoconto esclusivo del Times sulla presunta “violenza sessuale sistematica di Hamas”. Quando si trattava di costruire questa narrazione, il Times era chiaramente disposto a credere a individui “con precedenti di affermazioni non affidabili e privi di credenziali forensi”38.
Ciò che Boguslaw, Grim e Scahill dimostrano – in modo estremamente rilevante, dato il contesto di “rappresaglia” genocida con 35.000 morti confermati – è che Screams Without Words crolla completamente sotto scrutinio. I familiari di Gal Abdush, “la donna in abito nero” al centro della storia dello stupro, hanno attivamente negato che fosse stata stuprata. (“I media l’hanno inventato”, ha detto uno. “Non ha alcun senso”, ha detto un altro39.) La cosa più compromettente di tutte è che la giornalista che ha filmato il corpo di Abdush afferma di essere stato perseguitata per ottenere l’accesso: i giornalisti del New York Times “mi hanno chiamato ancora e ancora spiegando quanto fosse importante per l’hasbara israeliana”. Non c’è da stupirsi che una ex editor pubblica del “giornale di riferimento” degli Stati Uniti dica di sperare che venga fatta un’indagine completa. Centinaia di lettori hanno inviato lettere di annullamento iscrizione agli editori più responsabili di Screams Without Words (Suzanne Spector, Philip Pan, Joseph Kahn), spiegando le loro ragioni a partire da un modello preparato dal gruppo Writers Against the War on Gaza. “Sono profondamente perplesso”, recita questo modello, “dalla decisione del Times di assumere due principianti per trattare l’estremamente delicata questione della violenza sessuale, soprattutto dato che l’accusa di violenza sessuale, in questo caso, è diventata un pretesto per la punizione collettiva di Gaza.”
Abbiamo bisogno non di più concordia, ma di un maggior scontro diretto tra le femministe, in un contesto in cui la distruzione della vita palestinese viene continuamente rimossa nella nostra cultura dal pink-washing [letteralmente “women washed” N.d.T.]. Inoltre, abbiamo molti precedenti: l’eredità delle nemiche femministe su questo tema – un “conflitto” che sarebbe meglio descrivere come un nodo centrale del sistema imperialista capitalista mondiale – ha almeno cinquant’anni. Fu nel giugno del 1975 – l’anno in cui le Nazioni Unite dichiararono “Anno Internazionale della Donna”– che una conferenza mondiale di femministe, tenutasi in Messico, dichiarò che “l’uguaglianza delle donne” poggiava su “l’eliminazione del colonialismo e del neocolonialismo, dell’occupazione straniera, del sionismo, dell’apartheid e della discriminazione razziale in tutte le sue forme”40. Questa dichiarazione potente e infamante fu naturalmente fortemente contrastata dai rappresentanti presenti della WIZO (Women’s International Zionist Organization) così come da Betty Friedan, che tornò negli Stati Uniti per unirsi alle proteste contro la dichiarazione “Il sionismo è razzismo” e contribuire all’enorme sforzo di lobbying che si stava già mettendo in moto contro il suo futuro successo.
Eppure, la mozione venne comunque approvata, con settantadue voti favorevoli contro trentacinque, come risoluzione sull’”Eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” nell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel novembre del 197541. I paesi che sponsorizzarono e votarono a favore della Risoluzione 3379 dell’Assemblea Generale dell’ONU furono, come ci si potrebbe aspettare, per lo più nazioni precedentemente colonizzate. Alla fine, nel 1991, il documento venne abrogato dalle Nazioni Unite, e la risoluzione opposta, che di per sé è antisemita, secondo cui “l’antisionismo è antisemitismo” cominciò ad acquisire forza legale in un numero di istituzioni nazionali e sovranazionali. Le femministe sioniste non hanno mai dimenticato, né perdonato, il momento in cui, quarantanove anni fa, settantadue rappresentanti nazionali alle Nazioni Unite formalizzarono una decisione presa, in gran parte, da migliaia di femministe antimperialiste e comuniste in Messico durante l’estate dell’Anno Internazionale della Donna: che il sionismo non ha posto nel movimento popolare per la libertà di genere e la giustizia sessuale.
Non dovremmo permettere che ci rubino il ricordo di quella vittoria fugace. Il mito islamofobo del “culto musulmano dello stupro” non ci inganna più come il vecchio “mito dello stupratore nero” delle colonie di insediamento. Come insegna il collettivo femminista palestinese Tal’at, non può esserci “una patria libera senza donne libere”. Sebbene ci siano femministe su questa terra che giurano di essere nemiche di una Palestina libera condivisa da persone di tutti i generi e religioni, sono state proprio le femministe a riunirsi per affermare questa verità: che ogni tradimento verso il sionismo è un atto di lealtà verso l’umanità.
- Sull’uso strumentale delle questioni di genere in chiave sionista e sulla critica al pink e rainbow whashing di Israele si veda qui e qui (in part. lo scontro tra J. Butler/ E. Illouz sui fatti del 7 ottobre 2023). ↩︎
- Emily Shire, “Does Feminism Have Room for Zionists?”New York Times, 7 March 2017. ↩︎
- Collier Meyerson, “Can You Be a Zionist Feminist? Linda Sarsour Says No’, The Nation, 13 March 2017. ↩︎
- Gil Troy, “Mayim Bialik: The making of a heroic feminist Zionist’, Jerusalem Post, 29 March 2017. ↩︎
- Nick Pisa, “Lionesses of the Desert: Inside Israel’s all-female tank unit taking on Hamas…’, Daily Mail, 1 December 2023. ↩︎
- ”Israeli Women Fight on Front Line in Gaza, a First’, New York Times, 19 January 2024. Vedi: Ari Paul, “NYT Engages in Front-Page IDF “Womenwashing”’, FAIR, 25 January 2024. ↩︎
- Cit. in: Puah Rakovsky, My Life as a Radical Jewish Woman: Memoirs of a Zionist Feminist in Poland, transl. Barbara Harshav and Paula Hyman, Bloomington: Indiana University Press, 2002, p. 14. ↩︎
- motz Asa-El, “The anti-Zionist sex’, Jerusalem Post, 1 December 2023. ↩︎
- FOZ Museum, “The First Zionist Congress’, 8 March 2015. ↩︎
- Jewish Women’s Archive, “Suffrage in Palestine’, 23 June 2021. ↩︎
- Cit. in: Margalit Shilo, Girls of Liberty: The Struggle for Suffrage in Mandatory Palestine, trans. Haim Watzman, Waltham: Brandeis University Press, 2016, p. 14. ↩︎
- Judith Shotten and Barbara Gingold, “A Zionist In Spite of Herself’, Lilith, 34(4): 11-15, 2009, p. 13. ↩︎
- Liat Deener-Chodirker, “Can You Be a Zionist-Feminist?”Moment 42(3): 12, 2017. ↩︎
- Forest Rain Marcia, “Unapologetic Zionist Feminist’, Israel Forever Foundation, 20 March 2017. ↩︎
- “You can’t be a feminist and not be a Zionist’, Jerusalem Post, 23 January 2020. ↩︎
- Dworkin è stata tra le esponenti di spicco del cosiddetto Cultural feminism statunitense, per un approfondimento sul dibattito tra questa corrente, l’identitarismo e il femminismo materialista si rimanda a Alleanze ribelli, Me-Ti edizioni (2025), in particolare ai saggi di Paloma Uría Ríos e Cristina Garazaibal [N.d.T.] ↩︎
- Letty Cottin Pogrebin, “Anti-Semitism in the Women’s Movement’, Ms., June 1982, p. 65. ↩︎
- Ben White, “Shoot and cry: Liberal Zionism’s dilemma’, Electronic Intifada, 19 September 2007. ↩︎
- Letty Cottin Pogrebin, “Rest in Power: Alice Shalvi, the Mother of Israeli Feminism’, Ms., 18 January 2024. ↩︎
- “Netanyahu says human rights groups are turning a blind eye to alleged rapes by Hamas’, Sky News, 6 December 2023. ↩︎
- Anna Shecter, “Their bodies tell their stories. They’re not alive to speak for themselves’, NBC, 5 December 2023. ↩︎
- Joan Smith, “Why are people still denying Hamas’s rapes?’, UnHerd, 7 December 2023. ↩︎
- Amotz Asa-El, “The anti-Zionist sex’, Jerusalem Post, 1 December 2023. ↩︎
- Sarah Vine, “A new axis of misogynist evil is sweeping the world’, Daily Mail, 16 January 2024. ↩︎
- Amotz Asa-El, “The anti-Zionist sex’, Jerusalem Post, 1 December 2023. ↩︎
- Abigail Shrier, “This is not a drill’, Commentary, 15 December 2023. ↩︎
- Gil Troy, “Feminists Are Consenting to Hamas”Rape Culture’, Tablet, 29 October 2023. ↩︎
- “Rape as a weapon of war: a Ms. reading list’, 6 December 2023. ↩︎
- Charlotte Ivers, “Sheryl Sandberg on Hamas rapists and those who say nothing’, Times, 28 January 2024. ↩︎
- Katha Pollitt, “Why Have Feminists Been So Slow to Condemn the Hamas Rapes?“ Nation, 15 December 2023. ↩︎
- Jill Filipovic, “Denying the Gender-Based Violence of Oct. 7 Helps No One’, New York Times, 13 December 2023. ↩︎
- Dahlia Lithwick, Mimi Rocah, Tamara Sepper, Jennifer Taub, Joyce White Vance, and Julie Zebrak, “The World’s Feminists Need to Show Up for Israeli Victims’, Slate, 30 November 2023. ↩︎
- Jeremy Scahill, Ryan Grim, and Daniel Boguslaw, “Between the Hammer and the Anvil’, Intercept, 28 February 2024. ↩︎
- Sara Farris, In the Name of Women’s Rights: The Rise of Femonationalism, Durham: Duke University Press, 2017 [in italiano della stessa autrice si consiglia: Femonazionalismo. Il razzismo nel nome delle donne, Alegre, Roma, 2019, sull’uso del femminismo in chiave etnonazionalista si veda anche Elsa Dorlin, Difendersi. Una filosofia della violenza, Fandango, Roma 2020 e Beth E. Richie, Angela Davis, Erica R. Meiners, Gina Dent, Abolizionismo. Femminismo. Adesso., Alegre, Roma 2023, N.d.T]. ↩︎
- “ZAKA is not a trustworthy source for allegations of sexual violence on October 7’, Mondoweiss, 30 December 2023. ↩︎
- Samer Kalaf, “The New York Times Ignores Intense Scrutiny Of Its Oct. 7 Report’, Defector, 1 March 2024. ↩︎
- Nick Fagge, “Israeli morgue worker says horrors inflicted on Hamas’s victims are “worse than the Holocaust” including decapitated pregnant woman and her beheaded unborn child’, 20 October 2023. ↩︎
- Jeremy Scahill, Ryan Grim, and Daniel Boguslaw, “Between the Hammer and the Anvil’, Intercept, 28 February 2024. ↩︎
- “Family of key case in New York Times October 7 sexual violence report renounces story, says reporters manipulated them’, Mondoweiss, 3 January 2024. ↩︎
- Vedi questo report ostile da parte delle rappresentanti di WIZO (Women’s International Zionist Organization) che hanno partecipato alla conferenza: Evelyn Sommer, “Fighting Delegitimization: The United Nation’s “Zionism Is Racism”Resolution, a Case Study’, World Jewish Congress, 85th Anniversary Forum, 2021. ↩︎
- ONU, 10 Novembre 1975, Risoluzione 3379 (XXX), “Elimination of all forms of racial discrimination: Zionism as racism – resolution adopted by the General Assembly.’ ↩︎