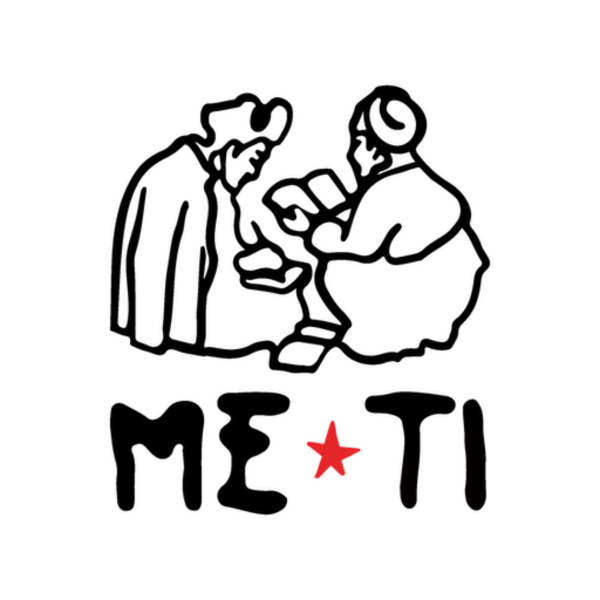Da quando, il 2 aprile 2025, Donald Trump ha annunciato la sua politica di “dazi doganali reciproci”, in rete così come su tutti gli altri mezzi di comunicazione sono apparsi innumerevoli interventi in merito da parte di economisti, politici, politologi, giornalisti e tuttologi. Date poi le continue modifiche annunciate da Trump rispetto ai dazi nelle due settimane successive, molti commentatori hanno parlato di “giostra dei dazi”. Riferendosi cioè ai suoi cambiamenti nelle decisioni su aumenti e diminuzioni dei dazi, così come sull’inclusione e poi esenzione di interi paesi e settori industriali da essi, annunciati e poi smentiti quasi giornalmente.
In conseguenza di ciò, però, anche i commentatori hanno dovuto riadattare le loro opinioni. Più che di “giostra dei dazi”, ci interessa qui mettere in evidenza la pericolosità di questa “giostra delle opinioni”. Quando così tanti commentatori corrono a dare opinioni estemporanee – anche se basate magari su anni di studio – viene da pensare che manchino alcuni criteri fondamentali di interpretazione dei fenomeni. E quasi sempre manca una vera analisi di classe.
Ripercorriamo le tappe di questa giostra. In primissima battuta, i commentatori più tecnici hanno rivolto la propria attenzione all’insensatezza dei calcoli dell’amministrazione Trump su come misurare i dazi. La rincorsa delle opinioni si è poi rivolta a stabilire se la Cina sia ormai più liberista e globalista degli USA, nonostante o proprio perché la globalizzazione in Cina l’hanno portata gli statunitensi. Se il protezionismo sia buono o cattivo. Se i dazi danneggeranno più gli USA dei loro avversari (Cina soprattutto) o dei loro presunti amici (Unione Europea soprattutto). E ancora: se questa mossa avvicinerà o allontanerà i paesi occidentali o asiatici dalla Cina e dalla sua massa di merci invendute; se la causa del declino statunitense stia più nell’economia reale deindustrializzata o nella finanza, se nel debito interno o in quello estero; se la guerra che abbiamo di fronte sia solo commerciale oppure di finanza internazionale o se porti alla guerra guerreggiata.
E poi ancora è partita la giostra dei suggerimenti di policy, soprattutto in Europa: è il momento di aumentare la propria autonomia strategica; è il momento di imboccare una terza via tra liberismo e protezionismo; per non dire dei commenti più radicali a sinistra che vanno dal “pensare” la fine del capitalismo o seguire la Cina ma anche le ricette di Draghi!
Sia chiaro: molti di questi commenti sono corretti, così come tanti altri. Così tanti che non li si può citare tutti. Ma tutte queste opinioni hanno un limite: la parzialità! Ciascun commentatore, più o meno innamorato della propria interpretazione dei fatti, si concentra su quella e piega ogni analisi a questa visione parziale: sia essa il debito USA oppure una giustificazione tecnica del protezionismo o del liberismo oppure la deindustrializzazione occidentale oppure qualsiasi altro fattore. Cerchiamo invece qui di usare tutti questi suggerimenti di illustri colleghi e commentatori, ma allo scopo di ricostruire un ragionamento più completo, anche se sempre in divenire.
- Tutti gli articoli citati mostrano da un lato che le mosse dell’amministrazione Trump derivano direttamente dalle contraddizioni del capitale a base statunitense, ossia il suo triplice debito: il deficit commerciale (ossia importare più di esportare, principale oggetto delle analisi di queste settimane), ma anche quello pubblico (statale, o per gli USA meglio definito come debito federale) e quello privato (dei cittadini sempre più indebitati dall’uso pluridecennale di carte di credito).
- Dall’altro lato, però, le mosse sui dazi fanno emergere subito anche le contraddizioni altrui. Gli europei, ad esempio, sono dannatamente preoccupati che i cinesi, per fare la guerra commerciale agli USA, inondino l’Europa delle loro merci in eccesso, spiazzando le imprese locali europee (oggettivamente meno competitive e ormai anche meno tecnologiche).
- Ma così emerge anche la contraddizione del capitale a base cinese, che è pienamente capitalistica. Come ha detto Ursula von der Leyen, la Cina ha un “nodo di sovraccapacità produttiva”. Ossia ha prodotto troppo, in particolare “nei settori in cui già oggi vi sono livelli di sovraccapacità globale”. Ma questa è, per una persona marxista, la normalità della crisi di capitale, ossia crisi da eccesso di sovrapproduzione. Intendiamo cioè che in Marx dire crisi da (e non di) sovrapproduzione significa che la crisi è sempre generata, sistematicamente, da sovrapproduzione e non che ci sono momenti contingenti e casuali di crisi. Questo perché “la sovraproduzione di valore, cioè la produzione di plusvalore è ‘norma’ per la ‘successiva’ accumulazione del capitale, mentre soltanto il suo eccesso, rispetto alla capacità del capitale stesso di assorbirlo e realizzarlo, diviene causa di contraddizione e crisi”, come scrive Gianfranco Pala nel suo Antikeynes.
- Date queste premesse, possiamo immaginare che la strategia dell’amministrazione Trump sia il tentativo non di risolvere la contraddizione del capitale statunitense, e questo perché – sempre marxianamente – la crisi di capitale è irrisolvibile, superabile davvero solo con la trasformazione in un altro modo di produzione. Questo perché “il capitale è esso stesso la contraddizione in processo, per il fatto che tende a ridurre il tempo di lavoro a un minimo, mentre, d’altro lato, pone il tempo di lavoro come unica misura e fonte della ricchezza” (Marx nei Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica). Bensì appare come il tentativo di usare tutte insieme varie strategie per scaricare sugli altri capitali concorrenti (e qui intendiamo capitali basati in altre aree geografiche, siano esse occidentali oppure orientali) le perdite immediate di tale crisi. Come?
- costringendo alcuni Paesi a sedersi al tavolo con gli USA per accettare sotto ricatto delle condizioni commerciali peggiori;
- facendo bruciare capitale fittizio in altre borse mondiali e non solo in quella di Wall Street, dove tale capitale fittizio risiederebbe, proprio come successo molte altre volte e in particolare nella crisi del 2007-2008;
- incassando qualche dollaro in più da chi accetti di pagare i dazi;
- riportando in USA una parte della produzione (non tutta che è impossibile ma magari quella più strategica a partire dai chip di Taiwan).
- E così via, con un impatto che può tranquillamente essere negativo e maggiore per alcuni capitali USA ma positivo per altri, a conferma che “l’interesse nazionale” è una forzatura ideologica. Ciò perché gli interessi di capitali residenti in uno stesso Paese possono avere, in conseguenza delle loro diramazioni mondiali differenti (in termini di imprese controllate in diverse aree del mondo), guadagni oppure perdite da uno stesso dazio trumpiano. Non dobbiamo infatti dimenticare l’attuale interconnessione globale dell’economia (attraverso filiere produttive e cosiddette catene globali del valore). Interconnessione che passa sì dal commercio internazionale ma il quale è soprattutto commercio di semilavorati e non di prodotti finiti. Non solo: molto spesso una grande parte di tale commercio è dato dalle filiali estere delle multinazionali che spediscono questi semilavorati nel proprio Paese di origine. È stato in passato stimato che circa il 50% delle importazioni statunitensi sono appunto importazioni che le case madri fanno dalle loro filiali all’estero.
Insomma, quella di Trump sembra una strategia multipla: in parte necessaria e dovuta alle contraddizioni ricordate del capitale a base statunitense; in parte semplicemente riflesso della “grande confusione sotto il cielo”. Come testimoniano i passi avanti e indietro rispetto agli interessi delle Big Tech statunitensi, prima colpite e poi esentate dai dazi. Forse è davvero il colpo di coda dell’egemonia statunitense, visto che dall’altra parte la Cina mantiene il sangue freddo – almeno apparentemente – concentrandosi sul rafforzare i rapporti con Paesi “amici ma sul punto di tradire” come il Vietnam; oppure sul fare leva immediatamente sui propri punti di forza, come le terre rare.
Questo articolo ha tentato di dare una panoramica globale perché riteniamo che si debbano leggere insieme tutte le leggi di movimento del capitale, e non privilegiare solo un aspetto alla volta, come fa l’economia mainstream e più in generale l’ideologia dominante caratterizzata dalla frammentazione del sapere scientifico. Il rischio delle opinioni parziali è che inducano a una lettura parziale dei fenomeni economici da parte delle masse, accontentandole con soluzioni facili e passivizzandole. Questo porta all’inazione – che vediamo da anni nell’astensionismo da parte dei “cittadini” o nella ritrosia nel portare avanti le proprie rivendicazioni da parte dei “lavoratori” – cioè al distacco dalla politica.
Una capacità di lettura della totalità dei fenomeni economici è, a nostro parere, ciò che manca e che ci si deve dare. Soprattutto con l’obiettivo di mostrare come la crisi di capitale sopra descritta si tramuti subito – dati i rapporti di classe – in crisi di lavoro da molteplici punti di vista: disoccupazione, morti sul lavoro, crisi ecologica, crisi abitativa, violenza di genere e così via. Se non si capisce la “totalità” della crisi di capitale, in altre parole, non si capiscono tutti gli altri problemi dei lavoratori negli ultimi secoli. Incluse le due guerre imperialiste che, un secolo fa, hanno distrutto l’Europa e gli europei con l’obiettivo di far finire la crisi e far ripartire l’accumulazione. Cosa effettivamente avvenuta salvo poi, dopo solo 2 o 3 decenni (che alcuni chiamano, esagerando, i “trent’anni gloriosi” dal 1945 al 1975), ripiombare in una nuova lunga crisi globale che dura ormai da più di mezzo secolo.
Ma forse quest’analisi totale impaurisce i cittadini, i lavoratori, le classi popolari? Serve allora un lavoro duplice. Da un lato la presenza di una soggettività politica che indichi pochi e immediati obiettivi da perseguire: oggi, la necessità di opporsi all’economia di guerra, che rischia di riportarci alla distruzione di un secolo fa; oppure la necessità di richiedere politiche di welfare vere ed efficaci, non quelle corporative che, nei “decenni gloriosi”, hanno posto le basi per la successiva accettazione del neoliberismo anche da parte di coloro che ne avrebbero pagato il prezzo, ossia i lavoratori dei paesi occidentali. Dall’altro lato, però, significa anche fornire a cittadini, lavoratori e classi popolari quegli strumenti di analisi per comprendere cosa stia succedendo nel mondo. Strumenti basati sulla storia e sulla scienza, affinché si capisca che la logica della crescita economica basata sul riarmo è la stessa che un secolo fa ha distrutto l’Europa e gli europei. O che i dazi di Trump non sono che un mascheramento per intensificare sempre più lo sfruttamento del lavoro, non solo all’estero ma anche negli USA, con la scusa di vincere la “guerra commerciale”. Così come fa anche il mascheramento nazionalista dei partiti conservatori e patriottici in Europa.
Insomma, si tratta di quel lavoro teorico di cui una soggettività politica non dovrebbe mai essere priva.