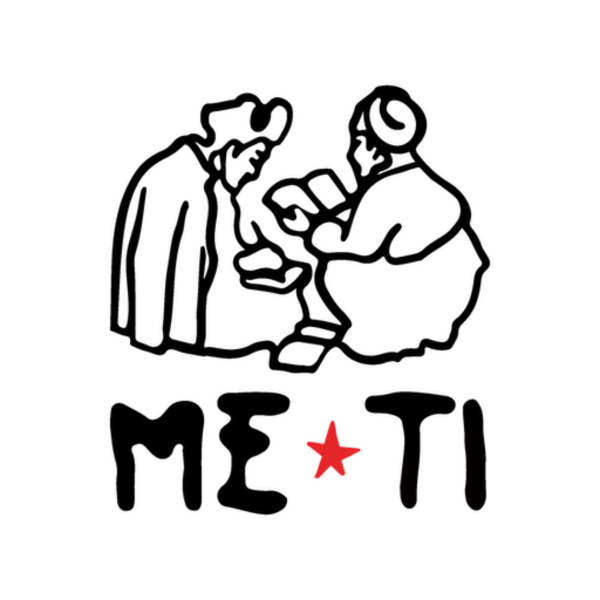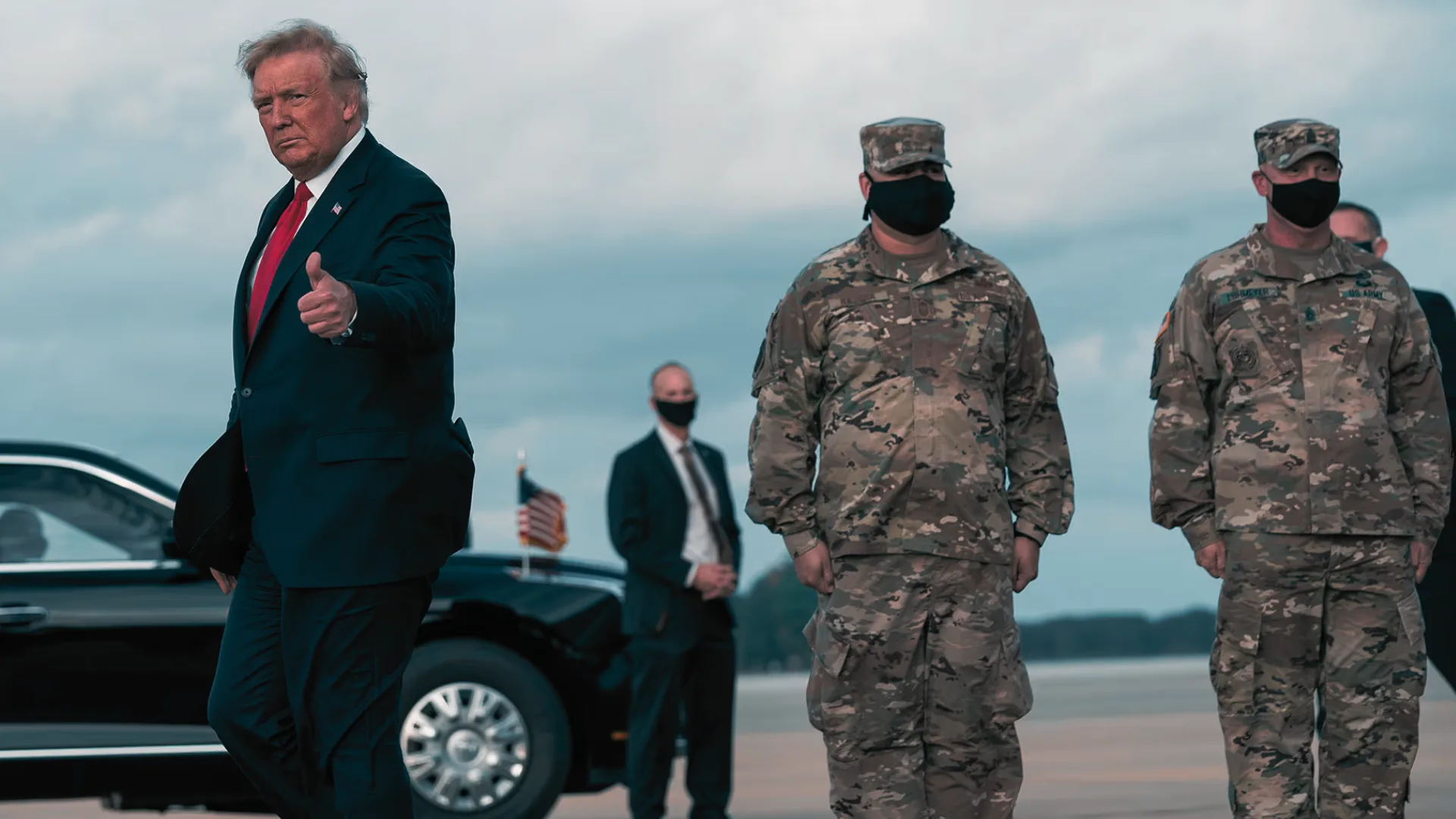Molti descrivono Trump e i suoi come una banda di “pazzi” che agiscono senza una precisa strategia e che si muovono in maniera totalmente randomica e umorale. In realtà, per quanto il loro “stile” sia sicuramente poco ortodosso, la situazione è ben diversa. La nuova amministrazione sta reagendo alla crisi dell’egemonia Usa che si è manifestata dal 2008 in poi. Quella attualmente in atto è una sorta di controffensiva dell’imperialismo americano con cui stanno provando a ristabilire i rapporti di forza messi in discussione dall’emergere della Cina sul piano economico e da diversi attori regionali sul piano politico e militare. Se mettiamo in fila i fatti, questa strategia – iniziata ancor prima dell’insediamento ufficiale di Trump – diventa abbastanza chiara.
Medio Oriente
Il Medio Oriente è stato il primo campo di battaglia. Obiettivo: distruggere o quanto meno indebolire in modo significativo il cosiddetto “asse della resistenza” e rilanciare gli accordi di Abramo, in particolare riportando l’Arabia Saudita nella propria sfera di influenza. Questo si è concretizzato nell’azione genocida portata avanti da Israele in Palestina, nella decapitazione dei vertici e dei quadri delle organizzazioni politico-militari nemiche per mezzo di omicidi mirati e azioni terroristiche oltre che da bombardamenti (vedi l’Iran) e invasione di parti di territorio di Libano e Siria.
Ad affiancare l’azione del vassallo sionista c’è stato poi l’intervento di Turchia e di alcune organizzazioni jihadiste che hanno portato alla definitiva caduta di Bashar al-Assad sostituendolo con un governo fantoccio guidato da al-Jolani. Con questa mossa la Federazione Russa è stata di fatto privata di uno dell’unico vero avamposto militare nella regione.
La guerra dei dazi
Come promesso in campagna elettorale, Trump non appena insediato ha emanato un ordine esecutivo per applicare nuovi dazi sui beni provenienti da Messico, Canada e Cina. A differenza di quanto avvenne nel primo mandato qui non si tratta di dazi selettivi, ma di imposte generalizzate con poche eccezioni. Nello specifico 25% sulle merci prodotte da Messico e Canada, mentre alla Cina viene aggiunto un ulteriore 10% rispetto a quanto già in essere. Sul petrolio estratto in Canada c’è una deroga e i dazi si fermano al 10% (le raffinerie statunitensi sono vetuste e hanno difficoltà a lavorare il greggio leggero estratto in patria).
Ufficialmente l’obiettivo è quello di spingere i governi dei paesi destinatari a mettere in atto azioni finalizzate a contenere l’ingresso dei migranti (soprattutto Messico) e della droga (in particolare il fentanyl dal Canada mentre la Cina è accusata di produrre precursori chimici per la produzione di stupefacenti). A Pechino inoltre sono contestate pratiche commerciali “sleali”.
Si tratta, come è evidente, di obiettivi difficilmente misurabili e il cui raggiungimento dipende solo in parte dall’azione degli stati oggetto del provvedimento. Ciò fa si che la presidenza Trump possa sospendere o inasprire a proprio piacimento i dazi senza dover motivare le proprie scelte o rapportarle a risultati oggettivamente riscontrabili. Al momento Canada e Messico hanno ottenuto una sospensiva della durata di un mese e sono iniziate le trattative per giungere ad un accordo e scongiurare l’entrata in vigore delle nuove tariffe. La Repubblica popolare cinese invece ha reagito in maniera molto pacata introducendo per ora solo dazi del 15% su carbone e gas liquefatto proveniente dagli Stati Uniti e annunciando l’avvio di un’indagine antitrust su Google.
Poi è seguito l’annuncio di dazi del 25% su acciaio e alluminio nei confronti dell’Ue a partire dal 12 marzo. La domanda che si pongono in molti è se Trump stia utilizzando i dazi come leva negoziale da impiegare per imporre condizioni più vantaggiose per gli Usa o se veramente voglia imprimere una svolta alle politiche in tema di commercio internazionale alzando barriere tariffarie.
Abbiamo pochi dubbi sul fatto che l’amministrazione Usa non stia perseguendo un vero cambio di paradigma, ma che invece utilizzi i dazi come una sorta di clava con cui minacciare i propri partner commerciali.
Applicare realmente dazi come quelli proposti da Trump sarebbe molto complicato per l’economia statunitense. Le entrate derivanti da questi tributi, che si dice debbano essere destinate al taglio delle tasse, sono assolutamente ipotetiche mentre è certo l’aumento dell’inflazione e il rafforzamento del dollaro. Un dollaro forte si tradurrebbe poi in uno svantaggio per l’export di merci statunitensi che invece l’amministrazione Trump afferma di voler rilanciare per riequilibrare la bilancia commerciale. Inoltre, come dimostra l’esperienza maturata a seguito dell’introduzione di nuove tariffe durante il Trump 1, l’effetto dei dazi è solitamente molto contenuto e rapidamente il commercio internazionale si “riorganizza” aggirando i tributi per mezzo di triangolazioni. I livelli di interdipendenza tra i vari paesi e di socializzazione del lavoro sono ormai così alti che è materialmente impossibile tornare indietro a meno che non si voglia produrre un tracollo generalizzato da cui nessun paese può uscire vincitore.
Quali sono dunque gli obiettivi perseguiti con la cosiddetta guerra dei dazi?
Nel caso del continente americano, l’obiettivo è riportare pienamente sotto il proprio controllo i paesi limitrofi, e questo discorso riguarda in particolar modo il Messico. Gli Usa sono preoccupati per la crescente presenza di capitali cinesi in territorio messicano. In questi anni il vicino meridionale degli Usa è stato, infatti, utilizzato per aggirare i dazi varati durante la prima amministrazione Trump. La preoccupazione è che le aziende cinesi possano non solo aggredire il grande mercato interno del Messico, ma anche approfittare dei numerosi accordi di libero scambio stipulati dal Messico e quindi utilizzarlo come una sorta di piattaforma per vendere i propri prodotti. In particolare, le preoccupazioni principali riguardano il settore automotive, quello delle telecomunicazioni e dell’estrazione del litio.
I dazi nei confronti dell’Ue sono parte di un disegno più complessivo (ci torneremo tra poco) che mira ad ostacolare lo sviluppo del processo di integrazione europea, aumentare la dipendenza energetica, impedire qualsiasi forma di autonomia strategica, sabotare la global minimum tax, garantire l’elusione fiscale alle corporation e soprattutto alle big tech – oltre ad eliminare una serie di restrizioni che la normativa comunitaria pone in tema di tutela della privacy e antitrust.
Infine, come scritto precedentemente, non è una novità l’inasprimento dei dazi nei confronti della Cina. Anche in questo caso, si tratta di uno strumento di pressione che gli Usa utilizzano per contrattare con Pechino rispetto alle varie dispute attualmente in corso nei diversi settori e nei diversi quadranti geografici.
La conferenza sulla sicurezza di Monaco
Al netto dei ridicoli espedienti retorici, il messaggio del vicepresidente Usa Vance a Monaco è stato molto chiaro: l’amministrazione Trump appoggia tutte le formazioni politiche populiste di destra del vecchio continente, a cominciare dalla Alternative für Deutschland e dal Rassemblement National. Tra le righe, gli ha indicato anche i punti su cui devono fare campagna elettorale o, meglio, quali nemici immaginari devono indicare: donne, ambientalisti e soprattutto migranti. L’intento è decapitare gli attuali vertici europei approfittando del fatto che sono già ampiamente screditati presso le opinioni pubbliche del vecchio continente. Agli “alleati” europei Vance ha anche specificato che da ora la difesa del vecchio continente sarà loro responsabilità, che – tradotto – vuole dire “aumentate le spese militari e comprate i nostri sistemi d’arma”.
Il discorso di Vance si innesta su una crisi del processo di integrazione che va avanti da molti anni (nei fatti è fermo dal 2007). Nonostante gli ambiziosi progetti emersi durante gli anni ‘90 non si è creata infatti una vera borghesia europea (processo impossibile con l’attuale quadro normativo comunitario, come ha ricordato in questi giorni Mario Draghi) e così le diverse borghesie nazionali continuano a restare in competizione tra loro e incapaci di confrontarsi a livello internazionale con Usa e Cina. Inoltre, con la guerra in Ucraina gli Stati Uniti sono riusciti a troncare i rapporti tra i paesi Ue e la Federazione Russa, fondamentali per ciò che concerne l’approvvigionamento energetico. L’Ue è allo sbando con i due “azionisti” di maggioranza, Francia e Germania, in piena crisi politica ed economica.
Trump vuole approfittare di questa situazione per stabilire rapporti di forza ancor più favorevoli agli Usa, provando ad implementare i rapporti bilaterali con i singoli paesi membri a discapito della dimensione comunitaria. Insomma, il più classico divide et impera.
La reazione europea è stata al momento blanda. Con il vertice di Parigi (fuori da qualsiasi iter istituzionale comunitario perché conscio che in quel contesto un accordo sarebbe stato impossibile) Macron ha tentato di trovare almeno una quadra di massima rispetto all’Ucraina, coinvolgendo anche il Regno Unito. Il tutto si è risolto in un nulla di fatto.
Dal punto di vista delle borghesie europee, il più lucido resta come al solito Draghi che già dagli anni in cui era governatore della Banca d’Italia spiegava che fin quando l’Ue resterà una somma di interessi e compromessi nazionali inevitabilmente sarà vittima degli agenti esterni e destinata ad un progressivo declino.
Il grande quesito è se a fronte di una crisi di questa portata (taluni come Lucio Caracciolo parlano addirittura di fine dell’Unione Europea), le borghesie del vecchio continente riusciranno a fornire la risposta rapida richiesta oggi da Draghi durante il suo discorso all’Europarlamento. Se riusciranno, cioè, ad avviare un percorso che conduca in poco tempo alla creazione di una vera entità statale che si traduce in primis in debito, politica estera, esercito e sistemi d’arma comuni oltre che nell’“abbattere le barriere interne, standardizzare, armonizzare e semplificare le normative nazionali e spingere per un mercato dei capitali più basato sull’equity”.
Senza un’adeguata centralizzazione e concentrazione dei capitali europei e senza una sovrastruttura politica e normativa idonea, infatti, per le borghesie europee è impossibile pensare di poter competere o quanto meno trattare con Usa e Cina.
Il vertice di Riad
Ieri a Riad, in Arabia Saudita, sono iniziati i colloqui tra la delegazione Usa e quella della Federazione Russa per porre fine alla guerra in Ucraina. Questa è stata l’altra grande svolta operata in campo di politica estera dall’amministrazione Trump, che segna una discontinuità con la precedente.
Tale discontinuità è figlia probabilmente di una valutazione diversa rispetto ai risultati conseguiti dagli Usa per mezzo di questo sanguinoso conflitto in cui la Russia è stata di fatto trascinata. Come detto in precedenza, con la guerra in Ucraina gli Usa hanno reciso i rapporti tra paesi dell’Ue e Federazione Russa rendendo gli europei molto più dipendenti dagli Stati Uniti rispetto all’approvvigionamento energetico. Inoltre, la guerra ha notevolmente indebolito dal punto di vista economico un paese essenzialmente povero come la Russia (oltre ai costi del conflitto c’è da considerare il sequestro di circa 300 mld di dollari di riserve valutarie detenute all’estero e di numerosi asset pubblici e privati).
La stessa Ucraina, della quale in teoria gli Stati Uniti erano andati in “soccorso” fornendo aiuti economici e militari, si trova ora in una situazione di assoluta vulnerabilità. Da quanto trapela dagli organi di stampa rispetto alle ipotesi di accordo di pace emerge il rischio che venga autorizzato un vero e proprio saccheggio delle risorse minerarie ucraine da parte delle grandi compagnie americane.
La politica estera Usa è tradizionalmente incentrata al pragmatismo ed è molto probabile che la nuova amministrazione si ritenga soddisfatta di quanto ottenuto. D’altro canto, però, il conflitto ha avuto un risvolto poco gradito agli Usa come il rinsaldarsi dei rapporti politici, economici e commerciali tra Federazione Russa e Cina. Una situazione poco gradita a Mosca, che mal sopporta il ruolo di “socio di minoranza”, ma a cui i russi sono stati costretti per far fronte all’isolamento. Le aperture di Trump a Putin e la riabilitazione sulla scena internazionale della Federazione Russa promossa dagli Usa probabilmente sono finalizzate a indebolire questo legame tra Mosca e Pechino. Una situazione potenzialmente positiva per entrambe le parti. La Federazione Russa potrebbe tornare a giocare su più tavoli senza esser vincolata ad un unico partner e gli Usa avrebbero nei fatti indebolito la Cina e più in generale l’aggregato dei Brics.
I negoziati commerciali Usa-India
Anche se poco coperta dai media, l’altra notizia importante di politica estera dell’ultima settimana è stata la visita alla Casa Bianca del premier indiano Narendra Modi, con annessa sottoscrizione di nuovi accordi su energia e difesa tra India e Usa in cambio di rimpatri forzati di migranti indiani. Non solo accordi specifici, ma addirittura al termine del bilaterale è stato annunciato che i due paesi lavoreranno alla creazione “una delle più grandi rotte commerciali in tutta la storia” che “correrà dall’India a Israele, all’Italia e poi verso gli Stati Uniti, collegando i nostri partner, i porti, le ferrovie e i cavi sottomarini”. Inoltre, sono state annunciate collaborazioni anche nel campo dell’hi-tech, dai semiconduttori alla intelligenza artificiale passando per la quantum technology.
Il rinsaldarsi dei rapporti tra India e Usa, che in realtà era iniziato già sotto l’amministrazione Biden, è un duro colpo per la Cina, che vede un altro dei membri principali dei Brics allontanarsi dall’orbita di Pechino in cerca di maggiore libertà di movimento.
In realtà, le difficoltà dei Brics a fare sintesi e passi in avanti erano già emerse durante il vertice di Kazan dove si erano evidenziate diverse contraddizioni interne. Per certi versi, come nel caso dell’Unione Europea anche i Brics non sono altro che una somma di interessi e compromessi tra diverse borghesie nazionali. La differenza però è che al loro interno il peso delle diverse componenti è molto meno equilibrato rispetto al contesto europeo, in quanto la Cina ha dimensioni enormemente superiori rispetto agli altri, in termini economici, finanziari e produttivi. Una situazione che inevitabilmente è mal sopportata da chi si trova in una condizione di debolezza e ha il timore di ritrovarsi in una condizione di subalternità.