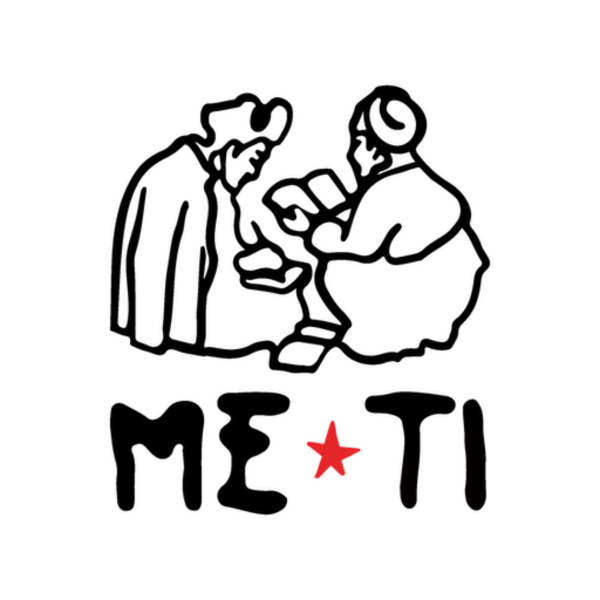Per quanto ci piaccia (sì, ci piace) il momento nel quale Lisbeth Salander in Uomini che odiano le donne marchia quello schifoso con il tatuaggio “pervertito, stupratore e sadico porco” quella scena ci dice molto poco su cosa può essere, concretamente, la giustizia transfemminista.
Elsa Deck Marsault la richiama nel suo Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes (La fabrique éditions, 2023) (p. 65) per provare a disegnare la linea di demarcazione tra vendetta, autodifesa, giustizia, potenza e impotenza.
Vogliamo parlare di questo testo e ne abbiamo tradotto in italiano uno dei passaggi per noi particolarmente significativi, quello sul moralismo progressista (lo trovate qui di seguito) perché mette a fuoco alcune questioni che ci stanno a cuore: cosa significa, per noi, ottenere e fare giustizia? Come possiamo arginare la deriva punitivista che caratterizza le istituzioni, gli apparati statali e l’opinione pubblica e che talvolta contagia anche i nostri spazi e movimenti?
“I contesti militanti, proprio come il resto della società, sono pena-dipendenti: non sappiamo più trovare delle soluzioni ai conflitti senza fare appello al sistema penale” (p. 95, trad. nostra), pensare la giustizia fuori da questi schemi, in un’ottica trasformativa, ovvero fuori dall’idea che l’unica riparazione a un danno sia una punizione da infliggere, significa per prima cosa rendersi conto che i conflitti possono essere preziosi e, in secondo luogo, che esiste una dimensione sociale e non solo un rapporto individuo/Stato nell’esercizio della giustizia.
La nostra difficoltà a ripensare la giustizia dipende, secondo l’autrice, da diversi fattori. In primo luogo, da un certo “realismo” e senso di impotenza che caratterizza il nostro tempo. Se non si può ottenere alcuna vera giustizia, non si possono rimuovere le cause profonde che informano i rapporti sociali come ingiusti e oppressivi, allora tutto ciò che possiamo fare è accontentarci della magra soddisfazione della punizione. Questo senso di impotenza – e questo è l’aspetto che sembra preoccupare maggiormente Marsault – non di rado si trasforma in sete di vendetta o desiderio di poter esercitare un potere. Alcuni esponenti politici riescono a capitalizzare questa spinta e questo desiderio promettendo pene più severe, di stanare i “colpevoli” (che poi spesso coincidono con le figure di persone marginalizzate, razzializzate, che hanno commesso piccoli reati e che contribuiscono ben poco all’instabilità e insicurezza sociale) e di farli marcire in prigione.
Per chi assume un’impostazione moralistica “di sinistra” questa spinta si trasforma, anche nei contesti più insospettabili, in azioni solo apparentemente significative e latrici di effetti, ma sostanzialmente inutili e vendicative. Convinti di non poter cambiare il fuori – è troppo difficile, non è alla nostra portata – ci si accanisce nel voler “purificare” lo spazio militante, le persone che lo vivono, ma anche le persone a noi prossime, parenti, amiche, partner, etc. fino ad arrivare al tentativo di trasformazione e purificazione assoluta di noi stessi e stesse. Evidentemente l’autrice non sta invitando a non lavorare su se stessi, a non pretendere e aspettarsi correttezza da chi ci è prossimo, evidenzia solo l’intransigenza che mettiamo in campo e la sproporzione, talvolta grottesca, tra il lavoro verso l’esterno e il lavoro verso l’interno (pp. 18 e ss.)1 – nei vari sensi in cui possiamo intendere questa espressione.
Le forme di spersonalizzazione della vita sociale prescritte dal modello capitalista neoliberista si impongono anche in dinamiche apparentemente private. Frammentati e individualizzati come siamo non riusciamo più a sostenere e avere non solo conflitti, ma anche forme di riparazione, dialogo, negoziazione che ci mettano in connessione con gli altri. Coabitare, condividere lo spesso spazio significa scontrarsi, talvolta danneggiarsi, ma, anche laddove il danno non è grave e la frattura sarebbe facilmente ricomponibile, spesso ricorriamo – attraverso i tribunali, ma anche attraverso procedure informali che riguardano i nostri spazi sociali e i movimenti di cui siamo parte – a autorità “esterne” che ci sollevino dalla fatica del conflitto/confronto. Perché teniamo assieme questi due termini? Perché come sottolinea Sarah Schulman non tutte le forme di conflitto, i disaccordi, gli scontri sono necessariamente forme di abuso2, espressioni di una dominazione o di una sopraffazione. Il conflitto è parte integrante della vita sociale e relazionale. Ma c’è di più: non aggirare il conflitto ci serve anche a mantenerlo nella nostra “cassetta degli attrezzi” politica.
Se è importante mantenere la disponibilità e l’attitudine al conflitto è altrettanto centrale la nostra disposizione e disponibilità al dialogo. Troppo spesso sentiamo dire e diciamo che siamo stanche di insegnare agli altri cosa significhi antisessismo, antirazzismo etc., ma se è vero che non siamo obbligate a un continuo lavoro pedagogico, è altrettanto vero che non possiamo del tutto sottrarci ad esso, se vogliamo avere una capacità trasformativa e se assumiamo un approccio politico. Come possiamo pretendere che altre persone si decostruiscano, si chiede Marseault, senza dire loro cosa ci aspettiamo, senza socializzare le nostre riflessioni, senza lavorare al dialogo? Bisogna provare a trovare un modo di “farsi carico delle persone di buona fede che semplicemente non sanno da dove iniziare il loro cammino militante” (p. 27). Anche perché l’ingiunzione alla ricostruzione individuale, la chiusura in dimensioni e discorsi identitari, il rifiuto del “lavoro pedagogico”, invece di creare le condizioni per le quali poter lottare insieme, producono una forma di militanza – o meglio di attivismo, come quello social – che diviene un’avventura solitaria, “edificata sul modello di un mondo neoliberista e costruita per non sconvolgerlo poi troppo” (p. 28).
“Le classi oppresse sembrano consegnare le chiavi della loro emancipazione al potere costituito. Il desiderio di libertà, così come la consapevolezza del proprio potere e del potere del collettivo, scompare poco a poco dietro a un’aspirazione politica limitata all’emancipazione individuale, al semplice riconoscimento delle nostre identità e delle oppressioni subite” (p. 85). Come ha efficacemente evidenziato Wendy Brown3 sembra che la sofferenza diventi una virtù sociale e, per converso, che il potere – che altro non è che il poter fare, il poter trasformare – venga quasi considerato immorale. Di qui la deriva punitivista: scompare il conflitto – ci dobbiamo rivolgere a un’autorità superiore ed esterna – ma scompare anche la capacità di confrontarsi e di ricomporre fratture anche profonde, scompare il dibattito e la negoziazione.
“Proporre una critica dei meccanismi punitivi e deleteri che si sviluppano nei contesti militanti” non significa divenire ipercritici, autolesionisti, paralizzarsi e avvitarsi in un dibattito infinito, “significa mettere sul tavolo i nostri meccanismi disfunzionali collettivi e darci l’occasione di fare meglio, di ricostruire delle nuove fondamenta” (p. 13)4. Ci offre la possibilità di mettere in discussione le potenzialità e i limiti dei nostri modi di fare giustizia (call out, lettere aperte, discussioni collettive, allontanamenti, messa a confronto dei soggetti implicati nel conflitto, etc.), di non leggere come collocati su un unico asse (de genere, dell’eteronormatività, della “razza”, etc.) i dislivelli di potere, in maniera disincarnata, ma di leggere i rapporti tra individui (e gruppi) nella loro complessità (pp. 50 e ss), preservando l’agency di chi è “vittima” e la possibilità di trasformazione di chi è “carnefice”.
Se nella finzione tutto è lecito, e possiamo immedesimarci in Lisbeth, nella realtà, e doppiamente nella realtà dei nostri spazi e movimenti, siamo costrette a percorsi più tortuosi e meno “spettacolari”. Soprattutto più giusti. A ripensare una giustizia che non sia vendetta, ma autodifesa, nel senso più ampio del termine5. Ovvero a pratiche, spazi di incontro e di confronto, protocolli, soluzioni, percorsi6 che non fissino il trauma né la colpa ma li rendano superabili e trasformabili, che rendano vivibile la vita delle persone danneggiate attraverso forme di supporto pratico (economico, abitativo, sanitario, psicologico, etc.), ma anche di risarcimento morale e sociale. Che ci portano, laddove è possibile e desiderato, a forme di ricomposizione e negoziazione, che, in una parola, abbiano come obiettivo la riumanizzazione (p. 65).
Il fuori non è intrasformabile, per contro lo spazio interno, personale, relazionale, militante, comunitario non è alla nostra mercè, completamente emendabile da ogni forma di conflitto. Partire da questo assunto significa per l’autrice aprire la porta alla possibilità di ripensare la giustizia in chiave trasformativa e transfemminista.
Ringraziamo la casa editrice francese La fabrique per averci concesso di tradurre questo pezzo.
Tratto da Elsa Deck Marsault, Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La fabrique éditions, 2023 (pp. 19-25).
Sul moralismo progressista
In assenza di un progetto militante unificante che possa condurci a un futuro desiderabile, le forze progressiste finiscono per soccombere a un moralismo giustizialista e rimproverante. A tal proposito potremmo parlare di militanza senza reale speranza di cambiamento. Questo è ciò che Wendy Brown chiama «moralismo progressista»7.
Questo moralismo si incarna in divieti individuali e porta alla condanna di certe parole, argomenti o atti oppure alla loro limitazione a un ambito molto ristretto. Se è giusto bandire certi comportamenti o termini oppressivi diffusi nei media o nelle nostre famiglie, questi divieti si applicano ancora più duramente proprio all’interno delle frange progressiste. Così, ci si ritrova a criticare duramente l3 militant3 delle nostre stesse organizzazioni per ogni errore lessicale o passo falso politicamente scorretto. Per esempio, ho già visto alcune persone esigere che un’associazione che distribuiva pasti gratuiti presentasse delle scuse per aver preparato piatti con la carne.
Nel mio lavoro e nella mia vita da militante raramente passa anche una sola settimana senza che emerga un conflitto assurdo attorno a una pubblicazione o a un intervento considerato «problematico», generando richieste interminabili di spiegazioni pubbliche. Questo moralismo progressista si incarna oggi in una serie di nozioni-ingiunzioni che regolano l’ordine sociale e sanzionano i dissensi: quella del safe8, della cura, dei trigger warnings9 o ancora della «radicalità».
Formulare una critica del genere nella società occidentale contemporanea, dove le forze reazionarie parlano incessantemente di wokismo è particolarmente delicato. In origine, questo termine, nato negli ambienti antirazzisti statunitensi, indicava la presa di coscienza delle strutture di oppressione in cui viviamo. Apparso in francese nel 2015, è stato successivamente oggetto di appropriazione da parte delle forze reazionarie, che lo utilizzano per designare e screditare i movimenti di pensiero progressisti e coloro che lottano per la giustizia sociale (femminismo, antirazzismo, antispecismo, ecc.). Se queste critiche e il travisamento di questo concetto si radicano nell’ignoranza, nella paura e nella codardia, ciò non deve impedirci, dal nostro lato, di aprire gli occhi su alcune delle nostre pratiche.
Un’altra caratteristica del discorso moralista è quella di concentrarsi su certe persone, prese singolarmente, che incarnerebbero l’ordine costituito e tutto ciò che si vuole combattere come il razzismo, il sessismo, l’omofobia, ecc., riducendo semplicemente il male a questi casi individuali. La conseguenza di ciò è un’individualizzazione delle relazioni di dominazione che invece, per definizione, sono il frutto di dinamiche sociali. Questo fenomeno di personalizzazione dei nostri nemici politici si sviluppa in coerenza con una società occidentale neoliberista che pretende di basarsi su un insieme di individui e non su gruppi o classi sociali. Tale fenomeno inoltre contribuisce all’invisibilizzazione dei meccanismi strutturali responsabili dei rapporti di oppressione. Certo, i rapporti sociali influenzano i rapporti di forza che si giocano nelle relazioni interpersonali. Ma gli individui da soli non potrebbero esserne gli unici responsabili, poiché i rapporti di dominazione si fondano su diversi livelli: individuale, ma anche istituzionale, strutturale e storico. Sebbene individualmente abbiamo una responsabilità e un ruolo da giocare nell’abolizione di un sistema di classi e privilegi, i nostri margini di manovra sono limitati.
È proprio perché il sistema può sembrare inamovibile che ci rifugiamo nel livello individuale. Abbattere una persona è più facile che abbattere il sistema che la sostiene. Ci si sofferma su ciò che qualcuno ha detto o fatto sui social media invece di concentrarsi sulle istanze del potere politico ed economico. Si agisce come se le ingiustizie sociali derivassero esclusivamente dal fallimento morale di alcuni, invece di riconoscere che esse sono anche il risultato di un processo storico di costruzione culturale, politica e socio-economica del potere. In altre parole, si attaccano gli effetti dei rapporti di oppressione piuttosto che le ragioni per cui sistemi come il capitalismo o l’imperialismo esistono.
Le strutture di potere e i rapporti di oppressione (sessismo, razzismo, classismo, abilismo, ecc.) vengono presentati come operanti esclusivamente a livello individuale, attraverso posizioni binarie ed esclusive: dominante o dominato, oppressore o oppresso, oppresso o privilegiato. In questo approccio, ogni coppia viene pensata in modo coerente e inscindibile, ogni termine definito solo nel suo rapporto con l’altro: i privilegi sono considerati come il semplice opposto dell’oppressione; i dominanti sono coloro che dominano i dominati, ecc. Pensare la realtà secondo due categorie, i buoni (i dominati, le vittime) da una parte e i cattivi (i dominanti, i carnefici) dall’altra, impoverisce la complessità dei rapporti sociali.
La prima conseguenza dell’uso di queste nozioni rese vaghe e dicotomiche è la confusione teorica in cui ci immerge. I termini «oppressione», «dominazione» o «privilegi» dovrebbero essere utilizzati nel loro significato stretto per acquisire forza analitica. Le rivendicazioni in materia di giustizia sociale si riorientano invece sul riconoscimento dell’identità e della differenza. Ne sono esempio quelle relative alla possibilità di iscrivere un genere neutro su un documento d’identità. Si osserva quindi uno «scivolamento dalla redistribuzione al riconoscimento»10, facendo evolvere il femminismo della seconda ondata verso una variante della «politica dell’identità»11. Pur essendo progressista, questa svolta tende a sovrainvestire la «critica culturale a discapito della critica dell’economia politica»12. Esiste effettivamente un aspetto individuale che gioca nei rapporti di dominazione; tuttavia, non è l’unico. Concentrarsi nelle nostre lotte unicamente sulla presa di coscienza dei nostri privilegi o, al contrario, delle loro ripercussioni negative sulla nostra vita, non potrebbe proporre un orizzonte politico soddisfacente. Peggio ancora, ci intrappola, noi «dominat3», in un sistema di pensiero dove la figura della vittima sostituisce quella dei combattenti, dei dissidenti o dei rivoluzionari.
I progressi non sono visti come «ottenuti o vinti, ma rivendicati e concessi»13, il che favorisce una tendenza a rifugiarsi dietro una «epistemopolitica della vulnerabilità»14 per guadagnarsi un posto in una società maltrattante. In questo senso, si sviluppa una politica di attesa, orientata verso le istituzioni, a scapito di una politicizzazione del conflitto. Ciò cancella innanzitutto la violenza di cui siamo capaci e che possiamo infliggere agli altri ma, soprattutto, accentua una posizione passiva e fatalista.
Ci diciamo che a forza di «far vedere loro» (le nostre condizioni di vita, le sofferenze che «loro» perpetuano, ecc.), ci sarà finalmente un momento in cui «loro» (lo Stato, le multinazionali, le persone che detengono il potere e il denaro, ecc.) apriranno gli occhi e si renderanno conto che ciò che ci impongono è disumano. Così, veniamo indott3 a credere che, superato un certo stadio, questa situazione finirà (le disuguaglianze/il capitalismo/il sistema oppressivo, ecc.). Questa concezione alimenta una rappresentazione che non spinge ad agire, ma incita a sopportare sempre un po’ di più… in attesa che «loro» decidano di fermarsi.
Uno degli aspetti del moralismo progressista risiede nel fatto che la militanza lascia gradualmente la strada e le sfere decisionali (politiche o economiche), per investire sempre di più il terreno del linguaggio e del simbolico. Così trattiamo «le rivoluzioni nell’ordine delle parole come rivoluzioni radicali nell’ordine delle cose»15. Per esempio, è diventato comune vedere pubblicazioni iniziare con una lista di trigger warnings. Se questa pratica sembra motivata da buone intenzioni (proteggere sé stessi o gli altri da una possibile reminiscenza traumatica legata a un contenuto sensibile), si basa però su presupposti che, a mio avviso, somigliano a deviazioni teoriche. I trigger warnings si fondano su un’individualizzazione dei traumi (ognuno ha i propri traumi) e su una lettura psicologizzante anziché su una lettura strutturale e politica. Parole come «stupro» o «incesto» tendono ad essere cancellate o attenuate per evitare ogni possibile retraumatizzazione individuale. Ma, non essendo più utilizzate come strumenti di descrizione e di elaborazione per pensare una realtà materiale, perdono della loro efficacia nel proteggere e nel nominare una realtà che, purtroppo, persiste. I trigger warnings fanno appello, per molti, alla credenza che si possano disattivare le reminiscenze traumatiche grazie a delle sorte di incantesimi. Se questa lista non è esaustiva, la persona che ha creato la pubblicazione può essere oggetto di critiche, se non di rimproveri.
Questa vigilanza costante verso il linguaggio (il nostro e quello altrui) permette di rassicurarsi sul proprio impegno, come un modo per distinguersi individualmente e dimostrare il proprio valore, presentandosi come detentor3 del pensiero corretto. Questo fenomeno è rafforzato online: i social network favoriscono la «starificazione» di persone e profili le cui azioni e idee vanno seguite. Questa militanza da influencer16 che sia antispecista, queer o altro, si nutre di logiche neoliberiste in cui l’individuo diventa l’alpha e l’omega delle lotte: la persona che insegna e quella che si educa, si rende consapevole, si decostruisce e si assume responsabilità – la fonte e la fine di tutto. La politica si riduce così a una «pratica di sviluppo personale»17.
- Cfr. Me-Ti, Il personale è (ancora) politico? Sul tema del moralismo progressista consigliamo la lettura del primo numero della rivista “Nous”, Genre et Empire. Les impasses du progressisme (2024). ↩︎
- Cfr. Sarah Schulman, Il conflitto non è abuso. Esagerazione del danno, responsabilità collettiva e dovere di riparazione, Minimum fax, Roma 2022. ↩︎
- Cfr. Wendy Brown, States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton University Press 1995. ↩︎
- Riguardo alla riflessione sul punitivismo all’interno degli spazi militanti Marseault fa riferimento ai lavori di Jo Freeman, che anticipano il dibattito attuale; nei prossimi giorni troverete su progettometi.org la traduzione di uno dei suoi testi fondamentali: La tirannia dell’assenza di struttura (1973). ↩︎
- Cfr. Elsa Dorlin, Difendersi. Una filosofia della violenza, Fandango, Roma 2020. ↩︎
- Faire justice si chiude con un riferimento alle esperienze mutualistiche e di gruppi e organizzazioni politiche che si sono spese a supporto delle persone danneggiate e per una giustizia trasformativa negli Stati Uniti (pp. 133 e ss – allegato 1 Genealogia iniziative recenti della giustizia trasformativa); dal punto di vista teorico fa riferimento alla riflessione sulla giustizia trasformativa di Ruth Morris, ci permettiamo di consigliare anche: Beth E. Richie, Angela Davis, Erica R. Meiners, Gina Dent, Abolizionismo. Femminismo. Adesso., Alegre, Roma 2023. ↩︎
- Brown, Wendy, Politics Out of History, Princeton, Princeton University Press, 2001. ↩︎
- Spazio safe: luogo o ambiente in cui una persona o un gruppo può avere la certezza di non essere espostə alla discriminazione (tratto da Ahenkorah, Elise, «Safe and Brave Spaces Don’t Work (and What You Can Do Instead)», traduzione dell’autrice, 2020, disponibile su www.medium.com). ↩︎
- Trigger warning: avviso che un contenuto (articolo, video, film, libro, canzone) contiene elementi che potrebbero scatenare un trauma psicologico in alcune persone. ↩︎
- Fraser, Nancy, Le Féminisme en mouvement. Des années 1960 à l’ère néolibérale, Paris, La Découverte, 2012. ↩︎
- Termine inventato dal Combahee River Collective, «The Combahee River Collective Statement», aprile 1977, www.circuitous.org/scraps/combahee.html; su questo tema vedi: Brown, Wendy, States of Injury: Power and Freedom in Late Modernity, Princeton, Princeton University Press, 1995; Kruks, Sonia, «Identity Politics and Dialectical Reason: Beyond an Epistemology of Provenance», Hypatia, vol. 10, n 2, 1995, p. 1-22; Wolfe, Ross, «“Identity” – The Bane of the Contemporary Left», The Charnel-House, 2013, visibile su www.thecharnelhouse.org; Mohandesi, Salar, «Identity Crisis», Viewpoint Magazine, 2016, visibile su www.viewpointmag.com. ↩︎
- Fraser, N., Le Féminisme en mouvement, cit. ↩︎
- Chi-Chi Shi, «La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique?», online, Période, 2019, trad. Sophie Coudray et Selim Nadi, veresion originale in Historical Materialism, vol. 26, n 2, 2018. ↩︎
- CASQ, «Quelques considérations sur la Pride radicale», online, Trou Noir, n° 17, septembre 2021. ↩︎
- Bourdieu, Pierre, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997, p. 11. ↩︎
- CASQ, «Queer influence: le management de l’innocence», online, Trou Noir, n° 25, juin 2022. ↩︎
- Ibid. ↩︎