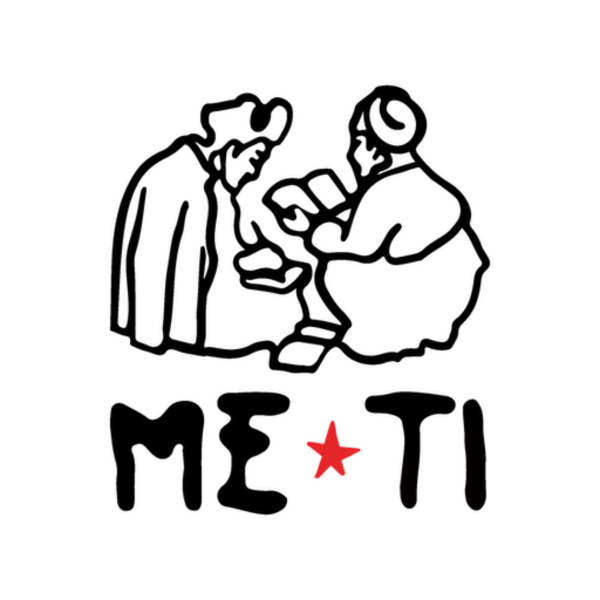I fatti sono abbastanza noti. Qualche giorno fa, in un paese in provincia di Rimini, Villa Verucchio per la precisione, un rifugiato egiziano ha accoltellato quattro persone in strada. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Un carabiniere, Luciano Masini, è intervenuto e ha sparato al rifugiato uccidendolo. Masini è indagato per eccesso di legittima difesa e uso improprio di arma da fuoco. La notizia è rimbalzata su tutti i giornali e su moltissime testate online, ed è stato dato grande risalto alla colletta che una parte della cittadinanza di Villa Verucchio ha organizzato in favore del carabiniere per coprire le sue spese legali. Un momento prima della colletta sono arrivate diverse dichiarazioni di solidarietà da parte del capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Bignami, che ha proposto di correggere la legge sulla legittima difesa in favore di chi fa parte delle forze dell’ordine, e di Matteo Salvini, che in seguito ha ovviamente applaudito alla colletta in favore dell’ennesimo “eroe”.
A queste notizie si accede molto facilmente. Bisogna invece sforzarsi un po’ di più e scorrere qualche pagina per scoprire il nome del rifugiato egiziano. Si chiamava Muhammad Abdallah Abd Hamid Sitta e aveva 23 anni.
Questa storia è una storia di subalternità. La prima cosa che salta agli occhi è che nessuno dei media che riporta la notizia si sofferma sui possibili motivi del gesto. Non sappiamo a quali conclusioni sia approdata o quali piste stia seguendo l’indagine in corso, quali supposizioni sono sul campo. Ma soprattutto, nessuno sembra chiedersi in quale contesto e su quali basi siano maturate le motivazioni di un gesto che rimane – a leggere le pagine di informazione – inspiegabile. Ancora una volta, come è stato per esempio nel recente caso di Leonardo Caffo, chi ha occupato la scena, chi ha la parola, chi decide più o meno direttamente quale debba essere il punto di vista della vicenda, è sempre colui che rappresenta in qualche modo il potere. La vicenda viene vista, raccontata, commentata dal lato del carabiniere, di chi per una notte ha incarnato i sogni di sicurezza maturati all’interno di un Paese che evidentemente non sa fare i conti con le sue contraddizioni, con chi vive in uno stato di subalternità, con le sue periferie, con le sacche di marginalità che la società stessa produce.
Quale punto di vista?
Fatte queste premesse, il buon senso ci direbbe che la questione va guardata dal punto di vista di chi non potrà mai spiegare le motivazioni o le cause di un simile gesto. Ma non può essere questa la strada giusta, per il semplice motivo che quel punto di vista ci è del tutto precluso. Non possiamo conoscerlo, a meno di non andare a indagare in profondità nella vita complessa di un rifugiato egiziano di 23 anni.
Tuttavia, questa vicenda ci dice molte cose anche se continuiamo a guardarla dal punto di vista del carabiniere, andando proprio a vederla in soggettiva, “dalla parte del manico”, non del coltello, ma della pistola. L’omicidio di Muhammad e ciò che ne è conseguito non fanno altro che affermare e confermare l’idea che quella vita ci appartiene. Appartiene, cioè, a una nazione “bianca”, a una fascia di popolazione che per semplice appartenenza culturale è ritenuta superiore a un’altra. È lo stesso schema del Ku Klux Klan che prima ancora di sostituirsi a un qualsiasi tribunale (tribunale che spesso condivideva e applicava leggi che andavano incontro ai desideri anche dei razzisti più estremi), si prendeva letteralmente le vite dei neri, affermando il diritto dei bianchi a decidere chi nell’organigramma sociale dovesse mantenere una posizione di privilegio.
Ricordiamo questo, non perché riteniamo di dover giustificare il gesto di Muhammad, ma perché la trasposizione pubblica che è stata fatta della vicenda ha permesso che un fatto circoscritto mostrasse quella che evidentemente è una concezione generalizzata, una mentalità, affermatasi in Italia e spinta da chi ci governa, che va ben oltre i torti e le ragioni di singoli individui. Indignarsi per le imputazioni mosse al carabiniere e promuovere un intervento legislativo e un movimento di opinione che tenda a giustificare l’assassinio di un qualsiasi criminale prima di un processo, vuol dire dare pesi diversi alle vite umane, e vuol dire soprattutto separare il campo tra chi può avere il diritto di decidere della vita altrui impunemente, e chi invece è costretto il più delle volte a soccombere e a vedersi privato del diritto di parola.
Quale legittima difesa?
Quando sentiamo che la nostra vita appartiene a qualcun altro, e decidiamo di ribellarci a quello che per alcuni è uno stato di cose necessario, possiamo farlo in due modi: con un gesto individuale, oppure con gesti collettivi. Entrambe queste soluzioni spesso sfociano nella violenza, ma se nel primo caso la violenza nel suo esito rimane solitamente fine a se stessa, nel secondo caso la violenza è sempre organizzata e può avere esiti che alla lunga contribuiscono a mutare le condizioni dei soggetti subalterni. Un esempio di questo tipo di soluzione è proprio la pratica dell’autodifesa che si afferma nella stagione del Black Power e dei movimenti di liberazione delle comunità nere negli Stati Uniti d’America, e parte da un assunto piuttosto evidente. Se il sistema è violento, allora bisogna difendersi con ogni mezzo necessario.
Qualcuno chiederà: se questo poteva essere vero per un sistema segregazionista come è stato quello degli USA fino almeno alla fine degli anni ’60, possiamo dire che le nostre democrazie, oggi, sono fondate sulla violenza? Lo sono su molti livelli. Lo sono perché escludono, ghettizzano e discriminano; e quando non lo fanno apertamente, sono ugualmente violente perché compiangono e compatiscono, a patto però che ciascuno rimanga al suo posto, in quei ghetti in cui anche il diritto tende a rinchiudere i più deboli. Ma le nostre democrazie sono violente anche in un modo più profondo, e cioè perché condividono quello che Engels nell’AntiDühring chiamava il peccato originale delle società borghesi: l’asservimento dell’uomo sull’uomo che in un primo momento deve affermarsi con il massimo della violenza possibile e poi, via via che la società borghese si struttura, assume la forma del diritto e viene permesso sulla base di leggi che sublimano la violenza primordiale, quella cioè che costringe un essere umano a vendere al prezzo più conveniente per il compratore la sua forza lavoro. È così difficile vedere nelle leggi che difendono il decoro, che reprimono il dissenso (si pensi al nuovo ddl sicurezza, per esempio) e che difendono la proprietà con ogni mezzo necessario, la stessa forma primitiva che riduceva di fatto un uomo alla mercé di un altro? Ogni legge, anche quelle che possono poggiare su basi giuste o che possono effettivamente garantire spazi di libertà, si scontra con il limite di questo peccato originale: diventa cioè un altro modo per affermare la possibilità, anzi la legittimità, dello sfruttamento, per sublimarne e permetterne la violenza, anche sotto la forma della garanzia di un diritto considerato fondamentale, quale quello della difesa della proprietà privata. È il caso del diritto alla legittima difesa, e della sua progressiva trasformazione. Ne sintetizziamo alcuni passaggi.
L’istituto della legittima difesa è un istituto tendenzialmente giusto: ci permette di reagire a un’aggressione, a una violenza, a una prepotenza. Nasce, insomma, a tutela e a garanzia di chi subisce e non di chi agisce violenza. Ma la sua estensione arbitraria, attraverso la creazione di tante fattispecie precise, denota la volontà di rendere più facile l’esercizio di questo diritto per chi occupa una certa posizione nella società, e finisce col rendere la società e il diritto ancora più violenti nei confronti di chi è già in una posizione di maggiore debolezza o di subalternità. Escludere per esempio un reato come l’eccesso di legittima difesa per i commercianti, o per le forze dell’ordine, vuol dire di fatto dare un potere di difendersi ad alcuni e indebolire il diritto a difendersi per altri.
Dal soggettivo al collettivo
Come uscirne? Difficile da fare, semplice a dirsi: da un sistema violento ci si difende. L’autodifesa è in prima istanza una reazione a questo stato di cose. Ma nel momento in cui smette di essere una tendenza soggettiva, individuale, e viene resa collettiva, l’autodifesa diventa un modo per far emergere le contraddizioni di una società, ed eventualmente per cambiare lo stato di cose. Se si legge quello che è successo a Rimini con un occhio volto agli Stati Uniti d’America, si vede abbastanza chiaramente che la violenza è stato uno dei mezzi necessari con cui il movimento di liberazione degli afroamericani ha tentato di rispondere alla brutalità di un sistema razzista, e che allo stesso tempo la violenza collettiva si è mossa di pari passo con tutte le altre pratiche di autodifesa che hanno permesso a un soggetto subalterno e frantumato di prendere coscienza delle proprie condizioni. L’autodifesa non ha lo scopo di vendicarsi del nemico, ma è volta a costruire un meccanismo di riconoscimento collettivo, ad aprire spazi di presenza in uno Stato, come era ed è quello degli USA, e come è il nostro, che prosperava sulla divisione razziale e di classe della società. L’autodifesa era dunque il modo in cui i ne*ri americani potevano vedersi riconosciuti come soggetti esistenti e reali, anche come soggetti vittime di discriminazioni, aprendosi uno spazio di azione concreta, anche ‘violenta’, per ridurre la violenza dello Stato e dei ‘bianchi’.
Muhammad non potrà mai dirci i motivi del suo gesto. Nessuno potrà chiederglielo, pochi sono interessati a saperlo, anche perché a parlare saranno ancora i Salvini, i Bignami, e tutti quelli che in un modo o nell’altro – più o meno dotati di incarichi istituzionali – occupano una posizione di potere. Anche per questo l’autodifesa da un sistema violento e brutale, che esiste solo in quanto processo politico collettivo di soggettivazione organizzata e contrasto del modo di produzione in cui siamo inseriti, e non come semplice azione individuale, deve permettere di dare voce ai senza voce, a quelli che pensano di non poter prendere parola e a quelli che non potranno farlo mai più, ma anche a chi, ugualmente vittima dello sfruttamento, si illude però di appartenere al campo di chi ha il coltello dalla parte del manico.