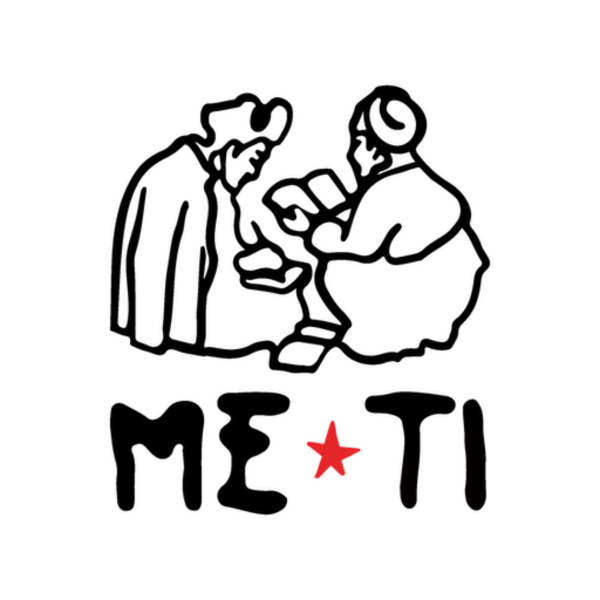Pubblichiamo in anteprima l’introduzione all’edizione italiana di Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità della curatrice spagnola Clara Serra. In queste pagine si ricostruisce il contesto nel quale il libro è stato scritto e si traccia la proposta teorica e militante di un transfemminismo materialista, non escludente, non colpevolizzante, che non si presti ad essere utilizzato in chiave punitiva o repressiva, che non assuma derive identitarie, ma unisca il fronte delle persone oppresse costruendo alleanze con altri movimenti e lotte sociali.
Il femminismo è uno dei movimenti politici più vitali del nostro tempo. Di pari passo con le importanti mobilitazioni femminili che hanno avuto luogo in vari Paesi negli ultimi anni, la lotta femminista ha acquisito visibilità e ha risvegliato l’interesse di gran parte della società. Il femminismo è uscito dall’accademia, dai libri e dai discorsi degli esperti, dagli ambiti militanti o dalle organizzazioni politiche ed è riuscito ad attraversare la vita sociale anche nei suoi spazi più quotidiani. Questa non è un’opportunità politica che la sinistra può sottovalutare o sprecare. In tempi in cui dilagano la rassegnazione, la passività e il conservatorismo, in cui ha la meglio un realismo capitalista anestetizzante, il femminismo dimostra di avere la capacità di mettere in discussione, sollecitare e mobilitare un numero significativo di persone.
L’8 marzo 2018 una storica mobilitazione femminista ha invaso le strade delle principali città spagnole, sia le manifestazioni che lo sciopero hanno raggiunto anche i centri di medie dimensioni e le zone rurali più remote. Da dove proveniva questo potenziale politico? Credo che se c’è qualcosa che spiega la crescita del femminismo in Spagna nell’ultimo decennio, soprattutto tra il 2016 e il 2020, è che questo movimento è riuscito a dimostrare che quelli che le donne sollevano sono problemi che coinvolgono e riguardano l’intera collettività e che la libertà che le donne rivendicano ha a che fare con l’emancipazione della società nella sua interezza. È questo impulso espansivo e universalistico che spiega il potere mobilitante delle manifestazioni femministe di maggior successo degli ultimi anni. bell hooks lo ha definito un femminismo per tutti, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser lo hanno chiamato femminismo per il 99%. Il femminismo è riuscito a riempire le strade perché ha prodotto incontri intergenerazionali, gemellaggi tra lotte, alleanze di classe, legami internazionali. È vero che siamo scese in piazza per denunciare la precarietà delle donne, le condizioni occupazionali inique, il mancato riconoscimento del valore del lavoro delle donne, lo sfruttamento dei settori femminilizzati, la povertà di chi si prende cura della famiglia e lavora a casa senza diritti, ma questa denuncia non è fatta per chiedere diritti solo per le donne. Il femminismo porta alla luce ciò che accade a una parte della società, ma rendere visibile quella parte implica guardare all’intera società. La situazione delle donne denuncia un ordine di cose più generale: il taglio dei servizi pubblici, uno Stato in ritirata di fronte all’attacco delle imprese ai diritti di chi lavora, le politiche di austerità che hanno impoverito il corpo sociale nel suo complesso. Negli ultimi anni abbiamo anche denunciato le aggressioni sessuali e la violenza di genere, ma questa critica è una critica a una cultura della violenza di cui non siamo le uniche vittime. Contestiamo una società in cui gli uomini sono indotti a usare la violenza contro le altre persone e a usarla anche contro se stessi. La nostra critica è la critica a un patriarcato costruito su gerarchie ed esclusioni (anche maschili), sull’omofobia, sul bullismo e sull’umiliazione, insomma su un sistema di violenza generalizzata che produce schiavitù, disagio e infelicità anche per gli uomini.
Le forze reazionarie che hanno condotto una crociata anti-femminista stanno cercando di raccontarci un’altra storia. Dipingono il femminismo come un movimento che promuove una guerra tra i sessi, come una lobby che difende gli interessi di una parte contro l’altra. La loro narrazione è che ogni centimetro di libertà guadagnato dalle donne rappresenta una battuta d’arresto per gli uomini, come se ci stessimo sfidando in un gioco a somma zero in cui si vince solo se l’altro gruppo perde. Prima di affermare, probabilmente in modo difensivo, che il femminismo appartiene solo a noi, pensiamo bene a chi ha realmente interesse a rappresentare il femminismo come una lotta delle donne per le donne. Trasformarlo in una lotta particolare non contribuisce alla vittoria del movimento femminista. E, sebbene i gruppi di donne che si organizzano in maniera separata abbiano avuto (e abbiano ancora!) un senso dal punto di vista funzionale e tattico, dovremmo ricordare che nella nostra tradizione di sinistra, fare del femminismo una questione esclusivamente femminile è stato il modo più facile, paternalistico e condiscendente per alcuni uomini di disimpegnarsi da qualsiasi questione femminista ed escluderla dal campo dei “grandi temi politici”. L’essenzializzazione del soggetto del femminismo è funzionale alla sua subalternità politica, alla negazione del suo potere universalmente emancipatorio e al potenziamento di discorsi reazionari. Se il femminismo è emerso di recente come questione centrale, è perché ha dimostrato che ci riguarda tutti e tutte, perché non si propone di cambiare le cose solo per una piccola parte della società, né solo per alcune persone. Vuole trasformare le cose alla radice e, quindi, cambiare tutto per tutte e tutti noi.
Per dispiegare il potenziale emancipatorio del femminismo dobbiamo costruire alleanze ribelli. Ribelli esattamente perché producono l’unione e la collaborazione proprio tra quelle soggettività che si vorrebbe fossero in contrasto tra loro per mantenere le cose così come sono. Quando vogliono separarci, allearsi diviene un atto di ribellione e il femminismo deve difendere questa ribellione moltiplicando e ampliando i fronti comuni. Non tutti i femminismi, però, sembrano muoversi in questa direzione. Accanto a questa veloce espansione del raggio d’azione del femminismo, sono emerse anche alcune forme di inerzia e di chiusura in senso “protezionistico”. Alcuni dibattiti attuali – come quello tra una parte del femminismo e i movimenti che portano avanti le istanze delle persone transgender – mostrano come certe correnti femministe vivano nel terrore di perdere il loro soggetto e pattuglino con fermezza i propri confini. Questa inerzia conservatrice fa parte di un quadro più ampio, di una ritirata generalizzata nel piano identitario, della richiesta di identità monolitiche e circoscritte, di una logica che attraversa le nostre lotte politiche e i nostri movimenti sociali. La questione del rapporto con le soggettività transgender è una delle giunture lungo le quali si snodano le contraddizioni di un femminismo identitario, ma, e questo è evidente, un’altra tensione si sta aprendo oggi a proposito del ruolo degli uomini nel movimento. Questa domanda sta diventando politicamente rilevante non solo perché molti uomini oggi si interrogano su questo senza trovare degne risposte, ma anche perché è una domanda a cui alcune forze politiche stanno rispondendo in modo reazionario. La nuova estrema destra sta reclutando un esercito di uomini arrabbiati contro il femminismo, descritto come un progetto escludente che ha dichiarato guerra a metà della società. Non va sottovalutato che questo appello, per quanto manicheo e ingannevole, sta riscuotendo un successo preoccupante; uno dei tratti più caratteristici del voto alla nuova estrema destra è l’altissimo consenso raccolto tra gli uomini.
Per affrontare con successo la politica di genere delle forze reazionarie di oggi, dobbiamo uscire dall’identitarismo in cui sono bloccate alcune prospettive femministe. Il patriarcato deve essere visto come un problema strutturale, come un sistema che non risparmia nemmeno gli uomini. Pierre Bourdieu lo ha ricordato ne Il dominio maschile: “la struttura impone i suoi vincoli ai due estremi del rapporto di dominio, quindi ai dominanti stessi, che possono beneficiarne pur essendo, secondo il motto di Marx, ‘dominati dal loro dominio’”1. Comprendere nella sua interezza e complessità il problema che abbiamo di fronte implica capire che non è possibile combattere il sistema patriarcale senza combattere tutte le imposizioni legate al genere. Le donne non possono liberarsi dal patriarcato se non se ne liberano anche gli uomini. Gli uomini non possono liberarsi dalla mascolinità imposta loro senza combattere insieme a noi contro la disuguaglianza. Questa alleanza deve essere impedita a tutti i costi per continuare a organizzare il mondo in base al genere. È ribelle e trasformativo impegnarci tutte e tutti in un progetto politico per cancellare le disuguaglianze e, allo stesso tempo, scommettere insieme per la nostra libertà. Ed è in questo quadro che i discorsi dell’estrema destra avranno più difficoltà a reclutare e aizzare gli uomini contro le donne.
Questo libro nasce dalla convinzione che sia necessario mettere in discussione un’idea che sembra avere parecchi seguaci al giorno d’oggi: che le rivendicazioni politiche appartengano essenzialmente ed esclusivamente ad alcuni soggetti che presumono di esserne i proprietari – e che quindi hanno l’autorità di “negare l’ingresso” ad altri. Per noi che abbiamo scritto questo libro, questa privatizzazione delle lotte è l’esatto opposto della costruzione di alleanze, costruzione che un progetto radicalmente trasformativo deve necessariamente attivare, ed è funzionale a mettere in opposizione fra loro le persone che stanno in basso. Da quando la politica trasformativa ha reso le lotte un affare privato? Da quando abbiamo dato per scontato che la politica sia un insieme di gruppi che non possono comunicare tra loro e che difendono i propri interessi particolari? E perché mai quelle di noi che aspirano a un femminismo in grado di cambiare radicalmente e nel complesso tutta società dovrebbero sentirsi parte di lotte di questo tipo?
Con queste convinzioni e questi dubbi, nel marzo 2019, un centinaio di persone con affinità politiche e militanti, con traiettorie più o meno condivise ma sempre vicine, si sono riunite a Madrid. Ci siamo riunite per discutere della nostra preoccupazione per l’affermarsi di certi discorsi identitari che una parte della sinistra sembrava accogliere con entusiasmo e, soprattutto, per dare forma al nostro desiderio di proporre un altro percorso critico e di lotta. Eravamo un gruppo molto eterogeneo, tra noi c’erano note attiviste antifranchiste, compagne storiche del movimento femminista attive fin dalla fase della transizione democratica post-dittatura, uomini del movimento per l’uguaglianza (molti dei quali provenienti dal movimento anti-militarista dei Paesi Baschi), ex attivisti del Movimento Comunista (un partito nato nella clandestinità della dittatura e sciolto negli anni ’90), membri del collettivo Acción en Red, oggi attivo in quasi tutto il territorio spagnolo e particolarmente vivo in Andalusia. C’erano anche persone di altre generazioni che facevano parte dell’attuale movimento transfemminista catalano, del movimento queer o dell’attivismo anti-punitivista e anti-carcerario. C’erano anche compagne migranti organizzate nel movimento delle lavoratrici del sesso e dirigenti del movimento sindacale delle lavoratrici domestiche. Dopo il primo incontro a Madrid, abbiamo tenuto una conferenza a Barcellona, dove eravamo molte più persone e abbiamo potuto continuare ad approfondire le questioni che ci interessavano. L’arrivo della pandemia ci ha impedito di continuare a incontrarci fisicamente, così abbiamo deciso di mettere per iscritto alcune delle nostre riflessioni condivise, che sono diventate il libro Alianzas rebeldes. Por un feminismo más allá de la identidad, pubblicato nel 2021. Dopo la fase pandemica abbiamo organizzato nuovi incontri e iniziative militanti, il prossimo sarà a Barcellona nell’ottobre 2025.
Il lettore italiano ha tra le mani una selezione dei testi presenti nella versione spagnola, che ben rappresenta le questioni che intendevamo affrontare. I testi di Santiago Alba e quello scritto da me affrontano in modo critico l’ascesa della politica del vittimismo e difendono la necessità di rifiutare un discorso paternalista per reclamare agency, potere ed emancipazione. Violeta Assiego e Mirem Ortubay si oppongono al dilagare del populismo penale che sembra aver colonizzato anche l’immaginario politico di alcuni esponenti della sinistra liberale. La loro idea è quella di difendere una riflessione transfemminista sulla giustizia e di ricordare che il compito di una sinistra radicale è quello di lavorare per trasformare la società e che questo significa non perdere mai la convinzione che tale trasformazione sia possibile. Altrimenti saremo stati sconfitti senza nemmeno rendercene conto. Laura Macaya affronta la critica del punitivismo, intendendolo come una resa, un passo falso, che riproduce la prospettiva puritana sulle donne e che serve da fertilizzante per le politiche reazionarie. In un momento in cui l’ultradestra più sessista e misogina invoca la sicurezza delle donne per allargare lo spettro di ciò che può essere considerato reato, inasprire le pene, stigmatizzare alcuni gruppi e incoraggiare il razzismo nelle nostre società, dobbiamo sfidare radicalmente queste false soluzioni. Sia Paloma Uría che Cristina Garaizábal guardano ai dibattiti femministi, la prima facendo una panoramica più generale e storica, la seconda analizzando il confronto sul tema della sessualità, dagli anni ’80 a oggi. Sono due voci storiche del movimento femminista spagnolo e ricostruiscono le genealogie critiche a cui questo libro attinge. Miquel Missé, uno dei principali esponenti del movimento per i diritti delle persone transgender spagnolo, spiega perché l’identitarismo rende impossibile l’alleanza del movimento trans con il femminismo. Josetxu Riviere spiega l’importanza di coinvolgere gli uomini nel femminismo e Nuria Alabao difende un femminismo di classe che mette al centro la riproduzione sociale e costruisce un soggetto collettivo a partire dall’alleanza con altre lotte in corso.
Restano fuori da questa selezione i testi di autrici come Paz Francés, penalista anti-punitivista, Laura Pérez Castaño, ex assessore al Femminismo nel governo di Ada Colau, Noemi Parra, sessuologa ed esperta di adolescenza trans, e Sejo Carrascosa, storica attivista del movimento queer e omosessuale. Ci sono anche due testi di Mamen Briz basati su due interviste: la prima con Iris Aldeide, lavoratrice sessuale transgender, migrante ecuadoriana e fondatrice dell’Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo del polígono de Villaverde a Madrid, e la seconda con Rafaela Pimentel, migrante dominicana e leader delle lavoratrici domestiche in Spagna. Infine, Siobhan Guerrero, filosofa e attivista trans messicana, che ha parlato dell’importanza di costruire alleanze in ambito latinoamericano in chiave decoloniale.
Questo è un libro di voci diverse; quelle di noi che scriviamo sono affini ma anche differenti, e non concordano su tutte le posizioni espresse. Tuttavia, condividiamo molte cose importanti e una di queste è la certezza che l’apertura di questi dibattiti è essenziale perché è in essi che ci giochiamo la possibilità che il femminismo accenda micce rivoluzionarie o che, viceversa, collabori, magari inavvertitamente, con i meccanismi di riproduzione del mondo che ci sono stati imposti. Questo libro è già di per sé un’alleanza. Grazie al Progetto Me-Ti per aver portato queste pagine nel contesto italiano e aver reso le riflessioni che vi abbiamo inserito aperte alla discussione, all’ampliamento e al miglioramento. È un modo di pensare collettivamente e ci sono molte ragioni per iniziare a farlo. Abbiamo troppo da guadagnare.
- P. Bourdieu, Il dominio maschile, Feltrinelli, Milano 1998, p. 83. ↩︎