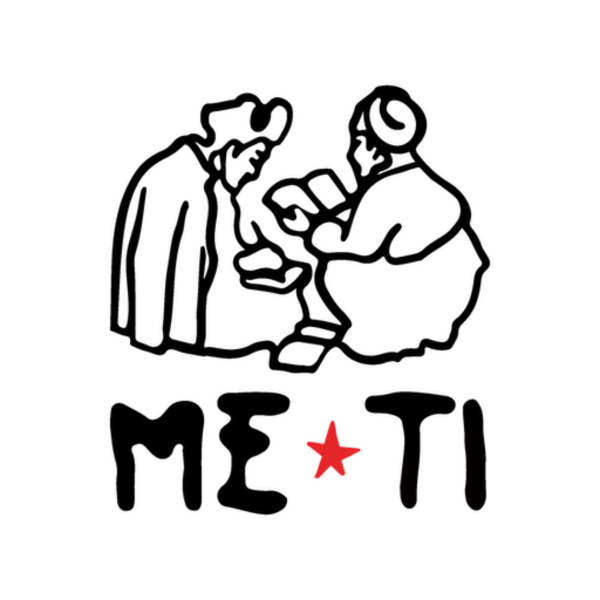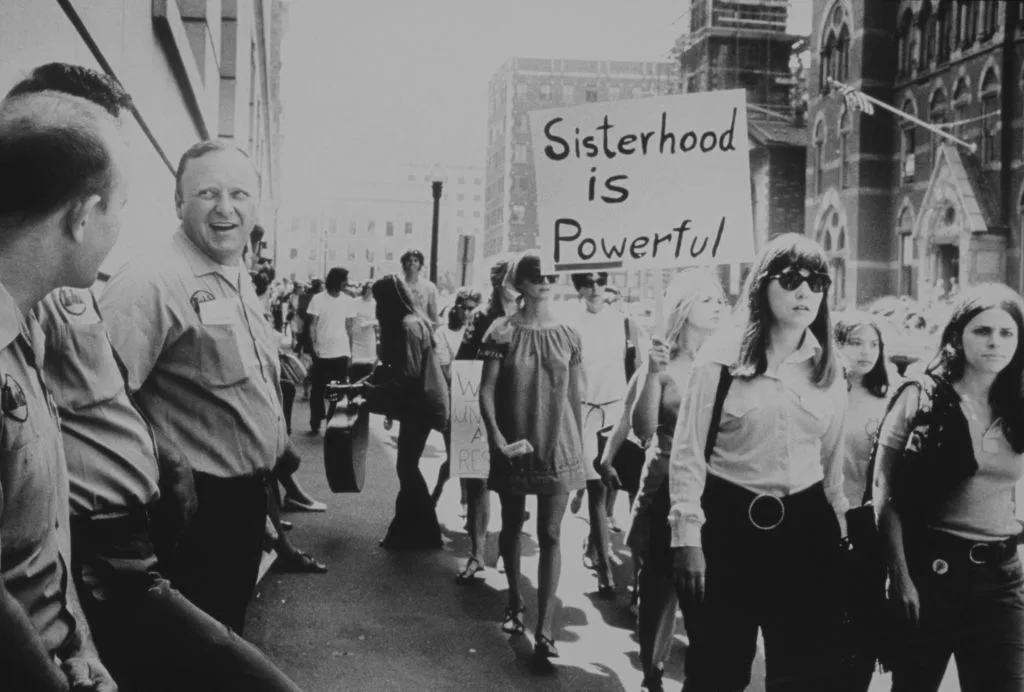Jo Freeman (26 agosto 1946), detta anche Joreen, è una militante femminista, attivista per i diritti civili e autrice di molti libri sulla condizione femminile e sui movimenti degli anni Sessanta e Settanta. Occupandoci di identity politics, giustizia transfemminista, potenziale e limiti dei movimenti nello scenario attuale siamo “inciampate” tante volte nella sua riflessione1 così abbiamo deciso di tradurre uno dei suoi testi più noti, La tirannia dell’assenza di struttura. In questo saggio Freeman mostra come il feticcio dell’informalità – la costruzione di gruppi apparentemente non organizzati, in cui i ruoli e i compiti non sono definiti in maniera chiara, in cui non ci sono portavoce – possa danneggiare i movimenti e nascondere strutture informali di potere opprimenti, prevaricatorie ed escludenti.
Scritto nel 1970 il testo parte da un assunto: se le organizzazioni e i gruppi politici sono troppo rigidi e verticistici la ricetta per costruire movimenti più “sani” e soprattutto più efficaci nel portare avanti le loro istanze non è de-strutturarli ma costruire strutture migliori, più giuste, inclusive e funzionali. Nelle quali i contributi delle singole persone possano essere valorizzati al massimo – anche quando si tratta di persone che non hanno un’enorme quantità di tempo libero da investire, che lavorano, che hanno figli, etc. – e nelle quali si riesca a moltiplicare le capacità e l’apporto di ciascuna persona.
L’assenza di struttura, di regolazione, esattamente come avviene per il “mercato”, non determina maggiore libertà, ma lo strapotere di chi è già in una posizione apicale. Questo metodo di gestione informale può divenire più opprimente della struttura che intendeva criticare e sostituire, producendo forme di esclusione, ostracizzazione, ma soprattutto rendendo meno efficaci i nostri sforzi per il cambiamento.
Questo testo2, a più di cinquant’anni di distanza, resta quanto mai attuale (basti pensare al riferimento allo star system che richiama le modalità di attivismo social, con i relativi vantaggi e rischi) e può aprire fra tutte e tutti noi, che ci impegniamo a vario titolo nei movimenti che lottano per la trasformazione e la giustizia sociale, un dibattito e una seria autocritica.
***
Negli anni in cui ha preso forma il movimento di emancipazione delle donne è stato messo un forte accento sull’importanza di avere gruppi senza leader e senza struttura come unica forma organizzativa possibile. Quest’idea si è affermata come reazione alla società iper-strutturata nella quale viviamo, all’inevitabile controllo che questa ha sulle nostre vite, e all’elitismo della sinistra e dei gruppi affini, che sulla carta si ponevano l’obiettivo di combattere questa iper-strutturazione.
L’idea di “assenza di struttura”, tuttavia, si è trasformata da sana opposizione a queste tendenze in obiettivo fine a sé stesso. L’idea, che è tanto poco analizzata quanto l’espressione è molto usata, è diventata una parte intrinseca e indiscussa dell’impostazione di fondo dei movimenti femministi. Nello sviluppo iniziale del movimento questo tema non aveva molto peso: avendo definito i propri obiettivi e metodi dando centralità alla presa di coscienza, un gruppo organizzato attorno all’idea di assenza di struttura era un ottimo strumento per raggiungere questo scopo. La non ufficialità e l’informalità del gruppo incoraggiano la partecipazione al dibattito e l’atmosfera, di reciproco supporto, favorisce l’espressione personale. Se da questi gruppi non scaturiva nulla di più concreto dell’aumento di consapevolezza individuale non importava granché, perché i loro obiettivi non andavano oltre.
I problemi di fondo sono emersi solo quando i singoli gruppi sono andati oltre la sola volontà di sensibilizzare e hanno deciso di fare qualcosa di più specifico. A questo punto di solito naufragavano perché la maggior parte dei gruppi non era disposta a cambiare la propria struttura col mutare dei propri obiettivi. Le donne avevano assunto fino in fondo l’idea di “assenza di struttura” senza rendersi conto dei limiti del suo utilizzo. Si cercava di usare il gruppo “senza struttura” e il dibattito informale per scopi per i quali non erano adatti, nella cieca convinzione che qualsiasi altro mezzo avrebbe prodotto oppressione.
Se il movimento vorrà andare oltre questo stadio infantile, dovrà liberarsi di questi pregiudizi sull’organizzazione e sulla struttura: non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato in nessuna delle due; spesso sono usate in maniera errata, ma rifiutarle a prescindere a causa di esempi sbagliati significa negarci gli strumenti per un ulteriore avanzamento. Vediamo quali sono i limiti delle forme organizzative senza struttura.
Strutture formali e informali
Contrariamente a quanto vorremmo credere, non può esistere un gruppo senza struttura. Qualsiasi gruppo di persone, di qualsiasi natura, che si forma per un determinato periodo di tempo intorno a un qualsiasi obiettivo, inevitabilmente si strutturerà in qualche modo. La struttura può essere flessibile, può variare nel tempo, può distribuire in modo più o meno uniforme compiti, potere decisionale e risorse tra suoi i membri. Ma assumerà una forma indipendentemente dalle capacità, dalla personalità o dalle intenzioni delle persone coinvolte. Il fatto stesso che siamo individui, con diverse capacità, predisposizioni e background, lo rende inevitabile. Solo se ci rifiutassimo di relazionarci o interagire in qualsiasi modo potremmo avvicinarci all’assenza di struttura, ma questo esula dalla natura dei gruppi umani.
Ciò significa che ambire a costruire un gruppo privo di struttura ha la stessa utilità di ricercare una notizia “obiettiva”, una scienza sociale “neutra” o a un’economia “libera”. Un gruppo basato sul laissez faire è realistico quanto una società basata sul laissez faire; questa idea diventa uno strumento retorico per i più forti o fortunati che riescono a stabilire un’egemonia indiscussa sugli altri. Questa egemonia può essere prodotta così facilmente perché l’idea di “assenza di struttura” non impedisce la formazione di strutture informali, ma solo di strutture formali. Proprio come la filosofia del laissez faire non ha impedito ai soggetti economicamente più potenti di controllare salari, prezzi e distribuzione dei beni, ma ha solo impedito al governo di farlo. L’assenza di struttura diventa quindi un modo per nascondere il potere, e all’interno del movimento delle donne è di solito sostenuta con maggior forza da coloro che ne hanno di più (che siano o meno consapevoli di questo potere). Finché la struttura del gruppo è informale, le regole riguardo a come vengono prese le decisioni sono note solo a poche persone e la gestione del potere è limitata a chi conosce queste regole. Coloro che non conoscono le regole e non sono stati scelti per essere introdotti nel gruppo ristretto devono rimanere nella confusione, o soffrire di deliri paranoici sul fatto che sta accadendo qualcosa di cui non sono consapevoli.
Affinché tutte le persone abbiano la possibilità di essere coinvolte in un determinato gruppo e di partecipare alle sue attività, la struttura deve essere esplicita, non implicita. Le regole decisionali devono essere chiare a tutti, e questo può avvenire solo se vengono formalizzate. Questo non significa che la formalizzazione della struttura di un gruppo distrugge la sua struttura informale. Di solito non è così. Ma impedisce alla struttura informale di predominare e rende disponibili strumenti per attaccarla se le persone coinvolte non si fanno carico delle esigenze del gruppo in generale. L’“assenza di struttura” è impossibile dal punto di vista organizzativo. Dunque, non possiamo decidere se avere un gruppo strutturato o meno, ma solo se averne uno strutturato formalmente o meno. Pertanto, questo concetto sarà utilizzato solo per riferirsi all’idea che rappresenta. L’espressione “non strutturato” farà riferimento a quei gruppi che hanno deliberatamente scelto di non dotarsi di alcuna struttura. Strutturato si riferirà a quelli che hanno scelto di farlo. Un gruppo strutturato ha sempre una struttura formale, ma può anche avere una struttura informale o nascosta. È questa struttura informale, soprattutto nei gruppi non strutturati, ad essere alla base delle “élite”.
La natura dell’elitarismo
“Elitario” è probabilmente la parola più abusata nel movimento di emancipazione delle donne. È usata con la stessa frequenza, e per le stesse ragioni, di “pinko” negli anni Cinquanta [Il termine definiva dispregiativamente una persona di sinistra, un “sinistroide”, nello slang del tempo N.d.T.]. Raramente è usata in maniera corretta. All’interno del movimento spesso viene riferita a persone le cui caratteristiche personali e modi di agire possono variare molto: un individuo, in quanto tale, non può mai rappresentare un’élite, perché l’unico uso corretto di questo termine è in riferimento ai gruppi. Un individuo, indipendentemente dalla sua notorietà, non può mai costituire un’élite.
L’espressione “élite” fa riferimento a un piccolo gruppo di persone che ha potere su un gruppo più ampio di cui fa parte, di solito senza la responsabilità diretta di quel gruppo più ampio, e spesso senza che questi ne sia a conoscenza o sia d’accordo. Un individuo diventa “elitario” quando è parte o sostiene il dominio di questo gruppo ristretto, indipendentemente dal fatto che l’individuo sia noto o meno. Notorietà non è un sinonimo di elitarismo. Le élite più insidiose sono di solito gestite da persone che non sono affatto note al grande pubblico. Gli elitari più intelligenti sono di solito abbastanza furbi da non diventare noti: quando lo diventano, sono osservati e non riescono più a mascherare bene il loro potere.
Le élite non sono cospirazioni. Molto raramente un piccolo gruppo di persone si costituisce e cerca deliberatamente di prendere il controllo di un gruppo più grande per i propri scopi. Le élite non sono nient’altro che un gruppo di amici che portano avanti le stesse posizioni politiche. Probabilmente manterrebbero la loro amicizia indipendentemente dal fatto che partecipano o meno a attività politiche; probabilmente sarebbero coinvolti in attività politiche indipendentemente dal fatto che mantengano o meno la loro amicizia. È la sovrapposizione di questi due fenomeni che crea le élite in un gruppo e le rende così difficili da distruggere.
Questi gruppi amicali si reggono su reti di collegamento diverse da qualsiasi canale comunicativo tradizionale che può essere creato dal gruppo più grande di cui fanno parte. Se non sono stati predisposti formalmente dei canali comunicativi, queste reti ricoprono tale ruolo. Poiché le persone che ne fanno parte sono amiche in quanto condividono gli stessi valori e orientamenti e si consultano quando si devono prendere decisioni comuni, chi è parte di queste reti ha più potere nel gruppo rispetto a chi non ne fan parte. E sono rari i casi di gruppi al cui interno sono presenti sottogruppi amicali e in cui non vengono stabilite reti comunicative informali.
Alcuni gruppi, in base alle loro dimensioni, possono avere più di una rete di comunicazione informale. Le reti possono anche sovrapporsi. Quando esiste una sola rete di questo tipo, questa rappresenta l’élite di un gruppo altrimenti non strutturato, indipendentemente dal fatto che le persone che ne fanno parte vogliano o meno essere elitarie. […] Se ci sono due o più reti relazionali di questo tipo, possono competere tra loro per il potere nel gruppo, formando fazioni, o una di esse può deliberatamente scegliere di non partecipare alla competizione, lasciando all’altra il ruolo di élite. In un gruppo strutturato, due o più reti amicali di norma competono tra loro per il potere formale. Questo è di norma il caso migliore, in quanto gli altri membri sono in grado di scegliere tra le persone che concorrono alla gestione del potere e quindi di fare richieste a quelle in cui ripongono temporaneamente la loro fiducia.
La natura inevitabilmente elitaria ed escludente delle reti comunicative informali amicali è un fenomeno che non è nuovo né nel movimento femminista, né per le donne. Queste relazioni informali hanno escluso per secoli le donne dalla partecipazione a gruppi di cui facevano parte. In ogni ambito professionale o organizzazione, queste reti hanno creato la mentalità da “spogliatoio” e i legami della “vecchia guardia”, che hanno di fatto impedito alle donne come gruppo (così come ad alcuni uomini presi individualmente) di avere pari accesso ai ruoli decisionali o di riconoscimento sociale. Buona parte degli sforzi dei movimenti femministi in passato è stata diretta all’ottenimento di strutture decisionali e processi di selezione formali, così da potersi opporre frontalmente ai processi volti alla loro esclusione. Come sappiamo, questi sforzi non hanno impedito alle reti informali di soli uomini di discriminare le donne, ma l’hanno reso più difficile.
[…] Poiché i gruppi di movimento non hanno preso decisioni definite su chi debba avere potere decisionale al loro interno, vengono utilizzati molti criteri diversi. […] Questi spesso includono [a seconda del tipo di gruppo]: provenienza dalla classe media (nonostante tutta la retorica sulla centralità della classe operaia); essere sposate; non essere sposate ma convivere; essere o dichiararsi lesbica; avere un’età compresa tra i venti e i trent’anni; avere un’istruzione universitaria o almeno un background di questo tipo; essere “alla moda”; non essere troppo “alla moda”; avere un determinato posizionamento politico o identificarsi come “radicale”; avere figli o almeno apprezzarli; non avere figli; avere tratti di personalità “femminili” come essere “simpatiche”; vestire bene (che sia uno stile convenzionale che non); ecc. Ci sono anche alcune caratteristiche che spesso identificano una persona “deviante” con cui non ci si dovrebbe relazionare. Tra queste: essere troppo vecchi; lavorare a tempo pieno, soprattutto se si è attivamente impegnati in una “carriera”; non essere “simpatici”; essere dichiaratamente single (ovvero né attivamente eterosessuali né omosessuali).
Si potrebbero includere altri criteri, ma tutti hanno questi tratti comuni. I requisiti per far parte delle élite informali del movimento, e quindi per esercitare il potere, riguardano il background, la personalità o la disponibilità di tempo. Non includono la capacità, la dedizione al femminismo, il talento o il potenziale contributo al movimento. I primi sono i criteri che di solito si usano per selezionare le amicizie. I secondi sono quelli che ogni movimento o organizzazione dovrebbe adottare per ottenere risultati politici. […]
Sebbene questa disamina del processo di formazione delle élite all’interno dei piccoli gruppi si collochi in una determinata prospettiva, non è stata fatta nella convinzione che queste strutture informali siano necessariamente negative, ma solo inevitabili. Tutti i gruppi creano strutture informali come risultato dei modelli relazionali tra i membri del gruppo. Queste strutture informali possono anche fare cose molto utili, ma solo i gruppi non strutturati sono completamente governati da esse. Quando ci troviamo di fronte alla commistione tra élite informali e il mito dell’“assenza di struttura”, è inutile provare a porre limiti all’uso del potere. Il potere diventa ingovernabile [letteralmente “capriccioso” N.d.T.].
Questo implica due conseguenze potenzialmente negative di cui dobbiamo avere coscienza. La prima è che la struttura decisionale informale sarà molto simile a quella di una confraternita, in cui si ascoltano gli altri perché ci piacciono e non perché dicono cose valide. Finché il movimento non è impegnato in azioni significative, questo non ha molta importanza. Ma se non vuole arrestare la sua crescita in questa fase preliminare, dovrà invertire questa tendenza. La seconda è che le strutture informali non devono rendere conto al gruppo in generale. Il potere decisionale non è stato conferito a queste strutture e dunque non glielo si può togliere. La loro influenza non si basa su ciò che fanno per il gruppo, quindi non possono essere influenzate direttamente dal gruppo. Questo non esclude necessariamente le strutture informali da ogni responsabilità. Coloro che si preoccupano di mantenere la propria influenza di solito cercano di prendersi anche delle responsabilità. Il gruppo semplicemente non può imporre questa responsabilità, che dipende dagli interessi dell’élite.
Lo star system
L’idea di “assenza di struttura” ha creato lo “star system”. Viviamo in una società che si aspetta che siano i gruppi politici a prendere le decisioni e a selezionare le persone che le riportano al grande pubblico. La stampa e l’opinione pubblica non sono in grado di ascoltare seriamente le singole donne in quanto donne; vogliono sapere come la pensa il gruppo. Sono stati elaborati solo tre dispositivi per sondare l’opinione di una massa: il voto o il referendum, il sondaggio d’opinione e la selezione di un/a portavoce del gruppo scelta/o in un’apposita riunione. Il movimento di emancipazione delle donne non ha utilizzato nessuno di questi strumenti per comunicare con il pubblico. Né il movimento nel suo complesso né la maggior parte dei numerosi gruppi al suo interno hanno scelto uno di questi strumenti per esprimere la propria posizione sulle varie questioni. Ma il pubblico si aspetta delle portavoce.
Pur non avendo scelto consapevolmente delle portavoce, il movimento ha fatto emergere molte donne che hanno attirato l’attenzione su di sé per motivi diversi. Queste donne non rappresentano un gruppo particolare o un’opinione consolidata; lo sanno e spesso lo sottolineano anche. Ma poiché non esistono portavoce ufficiali né organi decisionali che la stampa possa interpellare quando vuole conoscere la posizione del movimento su un tema, queste donne sono considerate come portavoce. Così, che lo vogliano o no, che al movimento piaccia o no, alle donne di rilievo pubblico viene assegnato implicitamente il ruolo di portavoce.
Questa è una delle principali cause dell’irritazione che spesso si genera nei confronti delle donne etichettate come “star”. Poiché non sono state scelte dalle donne del movimento per rappresentarne il punto di vista, si risentono quando la stampa presume che parlino a nome del movimento. Ma finché il movimento non sceglierà le proprie portavoce, queste donne saranno messe in quel ruolo dalla stampa e dal pubblico, indipendentemente dalla loro volontà.
Questo ha diverse conseguenze negative per il movimento e per le donne etichettate come “star”. In primo luogo, dal momento che non è stato il movimento ad assegnare loro il ruolo di portavoce, non può neanche toglierglielo. La stampa le ha scelte e solo la stampa può scegliere di ignorarle. La stampa continuerà a cercare le “star” come portavoce finché non avrà alternative ufficiali a cui rivolgersi per ottenere dichiarazioni dal movimento. Il movimento non ha alcun controllo sulla scelta delle sue rappresentanti finché ritiene di non doverne avere. In secondo luogo, le donne messe in questa posizione si trovano spesso attaccate ferocemente dalle loro sorelle. Questo non porta nessun vantaggio per il movimento ed è dolorosamente distruttivo per le persone implicate. Questi attacchi non fanno altro che portare queste donne ad abbandonare del tutto il movimento – spesso amareggiate – o a non sentirsi più responsabili nei confronti delle loro “sorelle”. Possono mantenere una certa fedeltà al movimento, ma non rispondono più alle sollecitazioni delle altre donne che ne fanno parte. Non ci si può sentire responsabili nei confronti di persone che ci hanno causato tanto dolore senza essere masochiste, e queste donne di solito sono abbastanza forti da non piegarsi a questo tipo di pressioni individuali. In questo modo la conseguenza del meccanismo dello “star system” è quella di favorire proprio quell’atteggiamento individualistico di mancanza di responsabilità verso le altre che il movimento condanna. Tacciando una sorella di essere una “star”, il movimento perde il controllo che poteva avere su quella persona, che diventa così libera di adottare tutti i comportamenti individualistici di cui è stata accusata.
Impotenza politica
I gruppi non strutturati possono essere molto efficaci nel permettere alle donne di raccontare della loro vita, ma non sono molto efficaci nel raggiungere obiettivi. Nel momento in cui le persone si stancano di “parlare soltanto” i gruppi falliscono, a meno che non riescano a dare una forma diversa al loro agire. In alcuni casi, la struttura informale che si è sviluppata risponde a una necessità che il gruppo può soddisfare dando così l’impressione che un gruppo non strutturato “funzioni”. In altre parole, il gruppo ha sviluppato casualmente proprio il tipo di struttura più adatto a raggiungere un determinato obiettivo. Lavorare in questo tipo di gruppo è un’esperienza molto stimolante, ma anche rara e molto difficile da replicare. Queste sono le quattro condizioni che quasi inevitabilmente si riscontrano in un gruppo di questo tipo;
1) È settato su compiti precisi. La sua funzione è molto limitata e molto specifica, come organizzare una conferenza o pubblicare un giornale. La funzione è alla base della struttura del gruppo; questa determina cosa e quando deve formarsi. Fornisce una chiave di lettura con la quale le persone possono valutare il loro operato e pianificare le attività future.
2) È relativamente piccolo e omogeneo. L’omogeneità è necessaria per garantire che i partecipanti utilizzino internamente un “linguaggio comune”. Persone che provengono da contesti molto diversi possono arricchire un gruppo che si occupa di sensibilizzazione condividendo le proprie esperienze, ma troppa diversità in un gruppo orientato a obiettivi puntuali porta solo a incomprensioni interne. Persone così diverse hanno chiavi di lettura e modelli di intervento troppo diversi. Hanno aspettative diverse sul comportamento altrui e giudicano i risultati con criteri diversi. Se ogni persona conosce tutte le altre abbastanza bene da percepire le sfumature, non sorgono problemi. Nella maggior parte dei casi, invece, si genera solo confusione e si trascorrono ore interminabili a risolvere conflitti che nessuno avrebbe mai pensato potessero sorgere.
3) C’è un elevato livello di comunicazione. Le informazioni devono essere trasmesse a tutti, le opinioni verificate, il lavoro suddiviso e la partecipazione alle decisioni garantita. Questo è possibile solo se il gruppo è piccolo e le persone vivono praticamente insieme nelle fasi cruciali del lavoro. Ovviamente il numero di interazioni necessarie per coinvolgere tutti aumenta esponenzialmente col numero dei partecipanti. Questo limita i partecipanti al gruppo a circa cinque, oppure ne esclude alcuni da parte delle decisioni. […]
4) C’è un basso grado di specializzazione. Non tutti devono essere in grado di fare tutto, ma tutto deve poter essere fatto da più di una persona. Così nessuno è indispensabile. In un certo senso, le persone sono interscambiabili.
Mentre queste condizioni possono avere casualmente modo di verificarsi nei piccoli gruppi, ciò non è possibile in quelli grandi. Di conseguenza, poiché il movimento più grande nella maggior parte delle città è destrutturato come i singoli gruppi, non è molto più efficace dei gruppi separati che si occupano di compiti specifici. La struttura informale raramente è abbastanza unita o in contatto con i singoli per poter funzionare bene. Il movimento produce quindi molta attività e pochi risultati. Purtroppo, le conseguenze di tutte queste azioni non sono così irrilevanti come lo sono i risultati e la loro vittima è il movimento stesso.
Alcuni gruppi si sono costituiti sulla base di inizative territoriali, quindi, non coinvolgono molte persone e lavorano su piccola scala. Ma questa forma limita l’attività del movimento al livello locale; non può coprire il piano regionale o nazionale. Inoltre, per funzionare bene, i gruppi devono di solito ridursi a quel gruppo informale di amici che gestiva le cose all’inizio. Questo esclude molte donne dalla partecipazione. Finché l’unico modo in cui le donne possono partecipare al movimento è attraverso l’appartenenza a un piccolo gruppo, le persone non appartenenti al sottogruppo di élite si trovano in una posizione di netto svantaggio. Finché i gruppi amicali sono il perno dell’organizzazione, l’elitarismo non è scalfibile.
Per quei gruppi che non riescono a trovare un progetto locale a cui dedicarsi, restare uniti diventa fine a sé stesso. Quando un gruppo non ha un compito ben definito (e la sensibilizzazione lo è), le persone che ne fanno parte rivolgono le loro energie al controllo degli altri membri. Questo non avviene tanto per il desiderio maligno di manipolare le altre persone (anche se a volte è così), quanto per la mancanza di qualcosa di meglio in cui impiegare le proprie forze. Le persone capaci, con tempo a disposizione e con la necessità di giustificare il loro far parte del gruppo, concentrano i loro sforzi nel controllo e nella critica degli altri membri. Lotte intestine e giochi di potere la fanno da padroni. Quando un gruppo ha un compito, i membri imparano ad andare d’accordo tra loro e a mettere da parte le antipatie personali per raggiungere lo scopo. Subentrano dei limiti al desiderio di plasmare gli altri a nostra immagine e somiglianza.
La fine del processo di presa di coscienza lascia le persone senza una prospettiva a cui volgersi, e la mancanza di struttura le lascia senza un modo per arrivarci. Le donne del movimento o si ripiegano su sé stesse e sulle loro sorelle o cercano altri campi di intervento. Ne restano poche disponibili. Alcune donne semplicemente “fanno di testa loro”. Questo può portare a una grande creatività individuale, in gran parte utile al movimento, ma non è un’alternativa praticabile per la maggior parte delle donne e di certo non contribuisce allo spirito cooperativo. Altre donne si allontanano completamente dal movimento perché non vogliono perseguire un progetto individuale e non hanno trovato il modo di scoprire, unirsi o avviare i progetti di gruppo che le interessano. […]
Molte élite informali si sono nascoste sotto la bandiera dell’“anti-elitarismo” e della “mancanza di struttura”. Per contrastare efficacemente la concorrenza di un’altra struttura informale, dovrebbero uscire allo scoperto, e questa scelta implica molte conseguenze pericolose. Così, per tutelare il proprio potere, è più facile provare a escludere i membri dell’altra struttura informale con mezzi come l’accusa [a seconda dei contesti N.d.T.] di essere comunista, riformista, di essere lesbica o cis-etero. L’unica alternativa è strutturare formalmente il gruppo in modo da istituzionalizzare la struttura di potere iniziale. Questo non è sempre possibile. Se le élite informali si sono ben strutturate e hanno esercitato abbastanza potere in passato, è fattibile. Questi gruppi hanno alle spalle una storia di una certa efficacia politica, in quanto la rigidità della struttura informale si è dimostrata un sostituto adeguato di una struttura formale. Strutturarsi non altera di molto il loro funzionamento, anche se l’istituzionalizzazione della struttura di potere la espone a contese formali. I gruppi che hanno più bisogno di una strutturazione sono spesso quelli meno capaci di crearla. Le loro strutture informali non sono state ben formate e l’adesione all’ideologia della “mancanza di struttura” porta a una resistenza a cambiare tattica. Meno un gruppo è strutturato, più è privo di strutture informali e più aderisce all’ideologia dell’“assenza di struttura”, più è vulnerabile a essere controllato da parte di un gruppetto.
Poiché il movimento in generale è destrutturato, come la maggior parte dei gruppi che lo compongono, è altrettanto soggetto a influenza indiretta. Ma il fenomeno si manifesta in modo diverso. Sul piano locale la maggior parte dei gruppi può operare autonomamente, ma gli unici gruppi che possono intervenire sul piano nazionale sono quelli organizzati su quel piano. Pertanto, spesso sono le organizzazioni femministe strutturate a fornire una direzione nazionale alle attività del movimento, e questa direzione è determinata dalle priorità di tali organizzazioni. Gruppi come NOW, WEAL e alcuni comitati femministi di sinistra sono semplicemente le uniche organizzazioni in grado di organizzare una campagna nazionale. La moltitudine di gruppi di emancipazione femminile non strutturati può scegliere di sostenere o meno le campagne nazionali, ma non è in grado di imbastirne una propria. Così i loro membri diventano le truppe alla cui guida ci sono le organizzazioni strutturate. I gruppi dichiaratamente non strutturati non hanno modo di attingere alle vaste risorse del movimento per sostenere le proprie priorità. Non dispongono nemmeno delle modalità decisionali per definirle.
Più un movimento è destrutturato, meno controllo ha sulla direzione in cui si sviluppa e sull’intervento politico che sceglie di avere. Ciò non significa che le sue idee non si diffondano. Con un certo interesse da parte dei media e adeguate condizioni sociali, le idee riescono comunque a diffondersi adeguatamente. Ma la diffusione delle idee non implica la loro messa in pratica; significa solo che se ne parla. Nella misura in cui possono vivere sul piano individuale, vengono attuate; nella misura in cui richiedono un potere politico coordinato per essere attuate, non lo saranno.
Fin quando il movimento di emancipazione delle donne continuerà a prediligere piccoli e poco operativi gruppi di discussione amicali, i problemi principali dell’assenza di struttura non saranno percepiti. Ma questa forma organizzativa ha i suoi limiti: è politicamente inefficace, escludente e discriminatoria verso quelle donne che non fanno e non possono far parte delle reti amicali. Coloro che non rientrano in reti già esistenti a causa della classe, razza, impiego, istruzione, genitorialità o condizione matrimoniale, carattere, etc., saranno inevitabilmente scoraggiate dal partecipare. Coloro rientrano in questi canoni avranno tutto l’interesse personale nel mantenere le cose come stanno.
Gli interessi acquisiti dei gruppi informali si sosterranno con le strutture informali esistenti e il movimento non avrà modo di decidere chi dovrà avere ruoli decisionali al suo interno. Anche se il movimento continua deliberatamente a non scegliere chi debba ricoprire ruoli decisionali, tali ruoli non scompariranno per questo. Semplicemente si abdicherà al diritto di pretendere che coloro che esercitano potere e influenza ne siano responsabili. Se il movimento continua a mantenere il potere il più diffuso possibile, perché sa di non poterne chiedere conto a chi lo detiene, impedisce sì a un gruppo o a una persona di avere potere assoluto. Ma allo stesso tempo finisce per essere assolutamente inefficace. È necessaria una via di mezzo tra il potere assoluto e l’inefficacia.
Questi problemi stanno emergendo adesso perché la natura del movimento sta inevitabilmente cambiando. La presa di coscienza come funzione principale del movimento di emancipazione femminile sta diventando obsoleta. Grazie all’intensa pubblicità della stampa degli ultimi due anni e ai numerosi libri e articoli in circolazione, la questione dell’emancipazione delle donne è diventata di dominio pubblico. I suoi temi vengono discussi e si formano gruppi informali che non hanno nessun legame con gruppi del movimento. Il movimento deve volgere lo sguardo ad altri compiti. Ora deve stabilire le sue priorità, articolare i suoi obiettivi e perseguirli in modo coordinato. Per farlo, deve organizzarsi sul piano locale, regionale e nazionale.
Principi di strutturazione democratica
Una volta che il movimento non si aggrappa più ostinatamente all’ideologia della “mancanza di struttura”, è libero di sviluppare le forme organizzative più adatte ad un corretto funzionamento. Questo non significa che dobbiamo spostarci estremo opposto e replicare ciecamente le forme organizzative tradizionali. Ma non dobbiamo nemmeno rifiutarle in assoluto. Alcune scelte tradizionali si riveleranno utili, anche se non perfette; altre ci daranno indicazioni su ciò che dovremmo o non dovremmo fare per ottenere determinati risultato con il minimo sforzo per le persone che sono parte del movimento. Nella maggior parte dei casi, dovremo sperimentare diverse tipologie di strutturazione e sviluppare differenti tecniche da adattare ai diversi contesti. […] Ma prima di procedere a sperimentare in modo intelligente, dobbiamo accettare l’idea che non c’è nulla di intrinsecamente sbagliato nella struttura in sé, ma solo nel suo abuso. Mentre ci impegniamo in questo percorso fatto di tentativi e fallimenti, ci sono alcuni principi che possiamo tenere a mente, essenziali per la strutturazione democratica e anche politicamente efficaci:
1) Delega dell’autorità decisionale limitata a singoli membri per lo svolgimento di compiti specifici attraverso procedure democratiche. Lasciare che le persone assumano compiti solo in automatico significa che non verranno svolti in maniera affidabile. Se le persone vengono selezionate per svolgere un compito, preferibilmente dopo aver espresso il loro interesse o la loro volontà di farlo, hanno assunto un impegno che non può essere ignorato così facilmente.
2) Richiedere che tutte le persone a cui è stata delegata l’autorità siano responsabili nei confronti di chi le ha scelte. In questo modo il gruppo ha il controllo sulle persone che occupano posizioni di autorità. Gli individui possono esercitare potere decisionale, ma il gruppo ha l’ultima parola sul come viene esercitato.
3) Distribuzione del potere tra il maggior ragionevole numero di persone possibile. In questo modo si evita il monopolio del potere e si richiede a chi detiene posizioni di autorità di consultarsi con molti altri nel processo decisionale. Inoltre, dà a molte persone l’opportunità di avere la responsabilità di compiti specifici e quindi di acquisire diverse abilità.
4) Rotazione dei compiti. Le responsabilità che vengono mantenute troppo a lungo da una sola persona, in modo formale o informale, vengono viste come “proprietà” e non sono facilmente cedibili o controllabili dal gruppo. Al contrario, se i compiti vengono ruotati troppo frequentemente, la singola persona non ha il tempo di imparare il proprio compito e ottenere la soddisfazione che deriva dall’averlo svolto bene.
5) Assegnazione dei compiti secondo criteri razionali. Scegliere una persona per un ruolo perché è gradita al gruppo o assegnarle un lavoro duro perché non lo è, nel lungo termine è inutile per il gruppo e per la persona. Capacità, interesse e responsabilità devono essere i criteri centrali in questa scelta. Le persone dovrebbero avere l’opportunità di apprendere competenze che non hanno, ma questo è meglio farlo attraverso una sorta di programma di “apprendistato” piuttosto che con il metodo “nuota o affonda”. Avere un compito che non si riesce a ricoprire bene è frustrante. Al contrario, essere esclusi da ciò che si sa fare bene non incoraggia a sviluppare le proprie capacità. Le donne sono state punite per la loro competenza per la maggior parte della storia umana; il movimento non deve ripetere questo processo.
7) Parità di accesso alle risorse necessarie al gruppo. Questo obiettivo non è sempre pienamente raggiungibile, ma dovrebbe essere tenuto in considerazione. Una persona che detiene il monopolio su una risorsa necessaria (come una macchina da stampa di proprietà del marito o una camera oscura) può influenzare indebitamente l’uso di quella risorsa. Anche le competenze e le informazioni sono risorse. Le competenze possono essere disponibili per tutte le persone che fanno parte del gruppo solo se ciascuna di loro è disposta a insegnare alle altre ciò che sa.
Quando questi principi vengono applicati, assicurano che qualsiasi struttura sviluppata da diversi gruppi di movimento sarà controllata dal gruppo e responsabile nei suoi confronti. Il gruppo di persone che occupa posizioni di autorità sarà ampio, flessibile, aperto e temporaneo. Non sarà così facile istituzionalizzare il loro potere, perché le decisioni finali saranno prese dal gruppo in generale. Il gruppo avrà il potere di determinare chi dovrà esercitare l’autorità al suo interno.
- Viene citata ad esempio da Olúfẹ́mi O. Táíwò, La cattura delle élite, Alegre 2024 e da Elsa Deck Marsault nel suo Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes, La fabrique, 2023 di cui abbiamo parlato qui. ↩︎
- La prima versione di questo articolo è stata pubblicata sotto forma di intervento a una conferenza indetta dalla Southern Female Rights Union, tenutasi a Beulah, Mississippi, nel maggio 1970. Fu scritto per Notes from the Third Year (1971), ma i redattori non lo utilizzarono. Fu poi sottoposto a diverse riviste di movimento, ma solo una chiese il permesso di pubblicarlo; altre lo fecero senza autorizzazione. La prima pubblicazione ufficiale fu nel Vol. 2, No. 1 di The Second Wave (1972). Questa prima versione pubblicata nelle riviste è stata scritta da Joreen [pseudonimo di Freeman]. Diverse versioni furono pubblicate nel Berkeley Journal of Sociology, vol. 17, 1972-73, pp. 151-165, e nella rivista Ms., luglio 1973, pp. 76-78, 86-89, a firma Jo Freeman. Questo articolo ha avuto diffusione mondiale. Molti hanno modificato, ristampato, tagliato e tradotto “Tyranny” per riviste, libri e siti web, di solito senza il permesso o la conoscenza dell’autore. La versione che segue è una miscellanea delle tre qui citate. Vedi qui. ↩︎