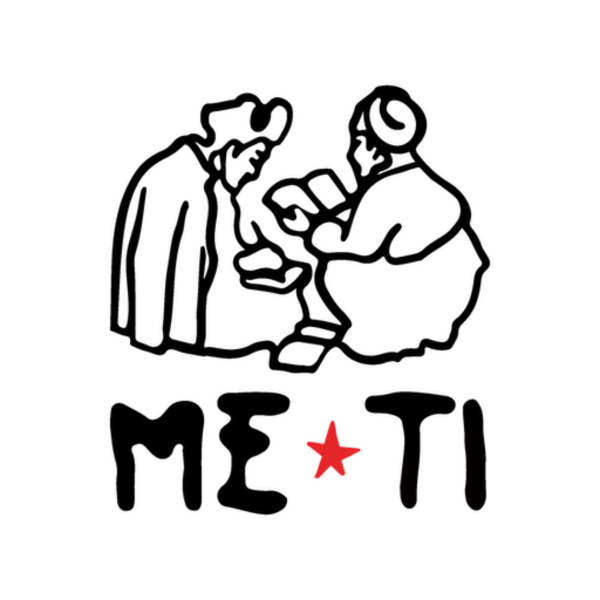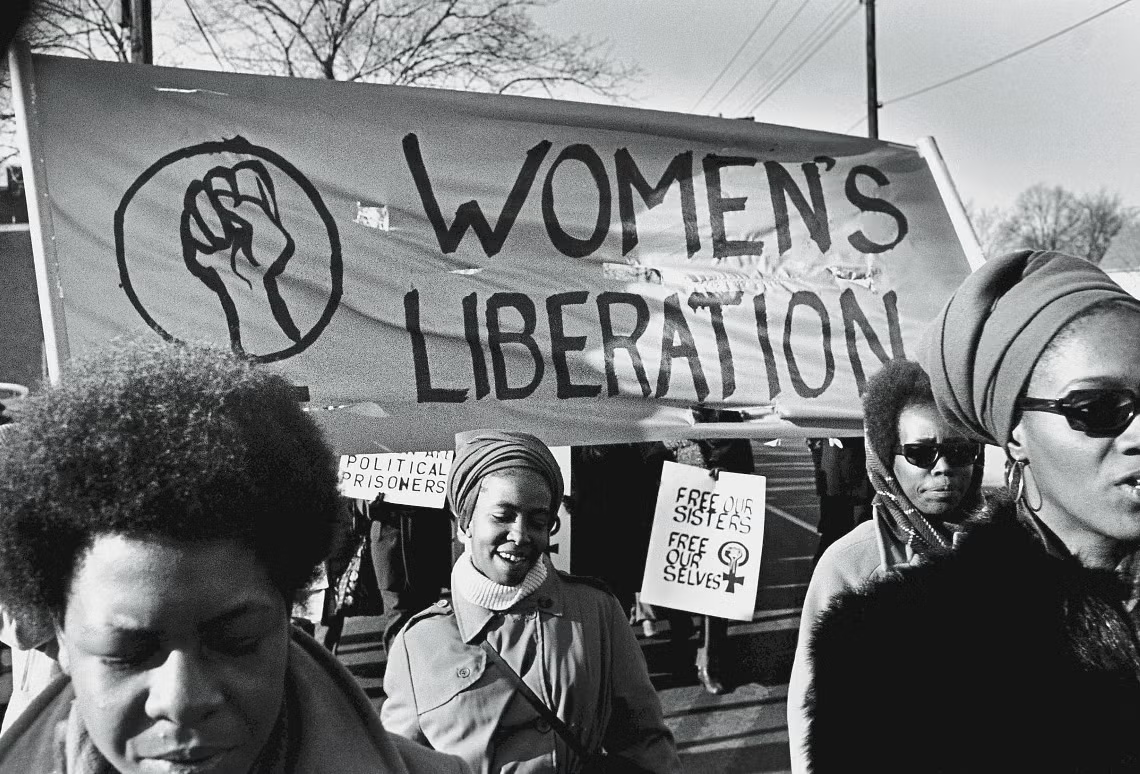Pubblichiamo in traduzione italiana “Trauma and capitalism or, your trauma story will kill you” di Yasmin Nair, pubblicato sul suo blog il 5 ottobre 2023. Trovate la versione originale qui.
***
Ormai siamo tutt* abituat* alle “Trauma Parades”: eventi il cui unico scopo è far sfilare le vittime che, in un modo o nell’altro, sono costrette a vomitare le loro storie di vita a beneficio di un pubblico di finanziatori e finanziatrici, accademici e accademiche e scrittori e scrittrici in trepidante attesa. Se il Pride è una parata che vuole esprimere la gioia dell’esistenza, le Trauma Parades sono l’opposto, non esprimono altro che la miseria delle vite delle persone più svantaggiate. Le più comuni, soprattutto nei circoli di sinistra, sono quelle che vedono come protagonist* le persone più giovani: ragazz* provenienti da contesti cosiddetti svantaggiati, spesso spint* sul palco a ripetere litanie di sventura, spesso sotto forma di Spoken Word (se il Trauma ha un genere, è questo).
Ho scritto spesso di come le storie traumatiche servano solo a emarginare ulteriormente le stesse comunità che dovrebbero “elevare” (per usare un termine popolare nel mondo della giustizia sociale). Ultimamente ho spostato la mia attenzione dall’uso del trauma, ad esempio, tra le femministe, alla riflessione sull’uso del trauma su una scala ancora più ampia. Come persona di sinistra, o ultra-sinistra, secondo alcuni, sono sempre preoccupat* di come un discorso si inserisca nel capitalismo, di come venga utilizzato come arma per promuovere la disuguaglianza e lo sfruttamento dilaganti. A tal fine, mi sono spesso chiest*: In che modo il capitalismo trae vantaggio dal trauma? Quali sono le connessioni tra trauma e capitalismo? Quali sono i problemi legati al fare del trauma lo strumento centrale di organizzazione, come spesso accade in molte (se non in tutte) le campagne di giustizia sociale di questi giorni? Come ho scritto in “AOC and the Weaponization of Trauma”:
Quando tutto è trauma, allora niente lo è. Se il trauma diventa l’unica cosa che vediamo all’orizzonte, diventa impossibile vagliare le gradazioni di tutto ciò che ci accade, dagli insulti e dalle offese agli episodi dolorosi, fino a ciò che davvero devasta il nostro corpo e la nostra anima.
A questo vorrei ora aggiungere che il capitalismo usa il trauma per oscurare il suo funzionamento e le sue dinamiche. L’uso del trauma come narrazione – come storytelling – nasconde le particolarità dei suoi effetti su specifiche popolazioni e categorie di persone e oscura forme di privilegio che passano inosservate. In tutta la confusione e la drammaticità delle storie traumatiche che ci vengono propinate così di frequente, non riusciamo a vedere come queste riproducano gerarchie e forme di privilegio.
Chiariamo: anche se parti della destra e della sinistra vorrebbero far finta che non esistano traumi degni di essere presi in considerazione, è necessario capire che i traumi esistono. Possiamo discutere su alcuni aspetti specifici e anche capire che il trauma a volte è inventato, soprattutto su scala di massa, ma riconoscere la finzione di alcuni episodi non ci obbliga ad assumere che forme di abuso e di trauma non esistano. I Satanic Panics degli anni ‘80 sono tra i migliori esempi di traumi inventati, ma nessuno dovrebbe usarli come esempio per fingere che anche l’abuso sessuale sui e sulle minori sia in qualche modo un costrutto1. È anche inutile, e insensibile, discutere sull’entità di tali abusi: il nostro compito principale è assicurarci che chiunque abbia bisogno di aiuto per elaborare gli effetti del trauma riceva gli strumenti necessari. Allo stesso tempo, possiamo riconoscere come le storie traumatiche siano ormai una vera e propria industria. Quando avrete finito di leggere questa frase, un* nuov* “narrante” avrà passato un’ora a raccontare tutte le orribili esperienze vissute in qualità di, a scelta, persona immigrata, vittima di stupro, rifugiata, sopravvissuta a una setta, fuggiasca e così via.
Ma questi esempi sono tutti uguali? Non intendo chiedere se l’effetto del trauma sia lo stesso, ma piuttosto porre una domanda più scomoda: queste persone sono tutte esattamente uguali? E che importanza ha?
Si pensi, ad esempio, al movimento de* giovani senza documenti. Quando è esploso, all’inizio degli anni ‘80, la stampa e chi faceva attivismo per l’immigrazione non smettevano di parlare di quella che all’inizio sembrava un’evoluzione particolarmente coraggiosa e necessaria di quello che allora era un movimento per i diritti dell’immigrazione poco sexy, incentrato sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Qui, al posto di chi lavorava nei giardini, nei cantieri o nei campi, c’erano persone giovani dal volto pulito, in grado di citare bell hooks e Audre Lorde, e sembravano essere di sinistra, con tutte le loro storie da persone senza documenti. Ciò che importava ai media e al pubblico era che i loro vari racconti di appartenenza e non appartenenza l* rendevano più, come dire, appetibili rispetto alle figure spettrali e oscure dei genitori che l* avevano preceduti. Per il pubblico americano che leggeva o l* guardava in televisione (era prima dei social media, quando tutti guardavano ancora quella che noi chiamavamo televisione, in veri e propri cofanetti), le persone clandestine erano una massa indifferenziata con storie individuali, certo, ma che erano anche solo versioni di un’unica storia traumatica che si svolgeva più o meno così:
Sono stat* portat* in questo Paese da bambin* dai miei genitori, che si sono fatti strada attraverso confini irti di guardie armate, attraversando deserti e oceani insidiosi. Una volta qui, i miei genitori hanno affrontato una vita di stenti e povertà e hanno lottato per dare a me e ai miei fratelli una normale vita americana e io ora sono qui per rivendicare il mio legittimo posto di american*.
Questa è senza dubbio una storia vera per molte persone (la retorica patriottica era considerata una strategia necessaria), e ha permesso a molte migliaia di giovani attivist* priv* di documenti di presentare un caso plausibile per il DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors Act), che avrebbe fornito loro un percorso verso la cittadinanza. Invece, hanno ottenuto un ordine esecutivo presidenziale, il DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), che sarà sempre a rischio perché non ha alcun sostegno legislativo.
All’epoca, chi di noi spingeva per un cambiamento molto più radicale delle politiche sull’immigrazione degli Stati Uniti sottolineava che il DACA rendeva le persone vulnerabili, perché le avrebbe costrette a “uscire dall’ombra”, finendo nel mirino dello Stato di sorveglianza (ottenere i benefici del DACA significava rivelarsi come persona priva di documenti ed essere effettivamente etichettata come tale). Abbiamo anche sottolineato che le persone più giovani che avrebbero avuto maggiori probabilità di subire un contraccolpo non sarebbero stati quelle in posizioni di “leadership” – persone che provenivano da contesti privilegiati, anche se prive di documenti – ma quelle che non avevano il capitale materiale, culturale e politico derivante dall’essere legate a potenti organizzazioni e ad attivist* per l’immigrazione (per ovvie ragioni, non offrirò alcun dettaglio identificativo)2.
Questo può sembrare irreale al pubblico, anche di sinistra, che ama pensare a tutte le persone immigrate senza documenti come più o meno uguali, con storie stereotipate di grinta e povertà. Ma la realtà è che le persone e le famiglie senza documenti provengono da strati sociali economicamente diversi, e che “senza documenti” non significa la stessa cosa in tutti i casi: alcune sono infatti economicamente più privilegiate di altre, e dispongono di un capitale politico (e quindi di immunità) molto maggiore di altre. Secondo la corrente principale del movimento per i diritti dell’immigrazione, che aveva già visto la possibilità di usare quest* giovani per raccogliere fondi, sollevare queste complicazioni significherebbe distruggere potenzialmente il movimento. Le prove, le sofferenze e le condizioni mortali di chi lavorava nei campi non erano così sexy ed eleganti come le tristi storie traumatiche raccontate dalle persone senza documenti, che dovevano tutte presentare lo stesso tipo di storia sulla loro provenienza. Il fatto che alcun* de* suo* leader fossero persone che si muovevano sulle ali del privilegio era – e rimane – un fatto scomodo ma nascosto3.
Lo stesso vale per la categoria delle persone giovani svantaggiate, che vengono messe al servizio, spesso senza volerlo, di organizzazioni, università e artist* rapaci. Questo mi è stato ricordato qualche anno fa, in occasione di un evento organizzato da un’università molto ricca e in via di imborghesimento che, insieme al suo “artivista” di fama internazionale appena arrivato, cercava di placare le preoccupazioni di un quartiere l* cui abitanti erano preoccupat* per il fatto di essere stat* espuls* dalle loro case. I segnali d’allarme non erano mancati: l’evento era iniziato alle 14.00 di un giorno feriale, impedendo di parteciparvi (e di fare domande scomode) alla stragrande maggioranza del pubblico che avrebbe dovuto prendervi parte. La grande sala, all’interno di un edificio di proprietà dell’università, si riempì presto di personalità di alto profilo del mondo accademico, della ricerca, dell’arte e dell’attivismo, che avevano deciso di partecipare a un evento molto elegante. Vidi molti volti noti: dirigenti di organizzazioni non profit ben finanziate, che avevano reso un gran servizio alla disuguaglianza, artist*, giovani personalità accademiche fresche di laurea, docenti e persone del corpo studentesco, tutt* con i volti accesi dalla necessità di fare del bene. Ci erano già stati consegnati degli opuscoli introduttivi cosparsi di tutto il linguaggio corretto sul neoliberismo, sulla gentrificazione e su come “mettere al centro le comunità”: conoscevano il gergo e sapevano come usarlo.
La cosa peggiore, però, è stata forse la Trauma Parade, in cui giovani, tutt* di colore, sono salit* sul palco e hanno partecipato a vari pezzi di teatro, dallo spoken word alla poesia alla danza, per descrivere le loro vite sotto il capitalismo, il neoliberismo, la devastante chiusura di non meno di cinquanta scuole da parte di Rahm Emanuel (come discusso da Eve Ewing e altri), il continuo problema dei food deserts, la mancanza di posti di lavoro e di opportunità e molto altro ancora. Tutto questo sotto il tetto di un’università la cui forza gentrificatrice era stata, fin dall’inizio, una fra le cause principali dei loro problemi.
Uno dopo l’altro, le giovani persone di colore sono state chiamate a recitare pezzi di spoken word e poesie sulla loro vita. Una dopo l’altra, abbiamo sentito parlare della vita nel “ghetto” – una parola che mi è sembrata completamente fuori luogo e fuori tempo, anche se pronunciata da un* giovane ner* – e di tutte le difficoltà che hanno dovuto sopportare. Ho sospirato interiormente, e con simpatia: ormai avevo partecipato a troppi eventi di quel tipo e sapevo che l* giovani, che rappresentavano varie organizzazioni non profit, erano costrett* a drammatizzare le loro vite in questo modo, a recitare i loro traumi per autenticarsi come soggetti meritevoli di simpatia e finanziamenti. Ognun* di loro è stat* costrett* a raccontare una storia di trauma, a cantare per il loro divertimento.
Ma la presentazione di un* giovane mi ha colpito per la sua strana dissonanza. Chiamiamol* X4. La storia di X raccontava della paura di fare coming out coi propri genitori e di aver finalmente avuto il coraggio di farlo. Il fatto che i suoi genitori si siano rivelati più che solidali non è stata una sorpresa né per me né, sospetto, per la maggior parte delle persone presenti in sala: X è figli* di genitori estremamente privilegiati e conosciuti, che annoverano tra i loro familiari e amici politici di sinistra e liberal, studios* queer e attivist*. Ha ricevuto un’educazione tra le migliori della città e del mondo, dà del tu a studios* di spicco in diversi campi, tra cui gli studi di genere e femministi, e ha assimilato la teoria critica e la politica di sinistra fin dalla nascita. Il coming out è un processo diverso in ogni situazione e in ogni famiglia, e non voglio negare la grande paura descritta da X, ma c’è una differenza sostanziale tra il coming out in una serie di circostanze così progressiste e il coming out in un quartiere che è sempre sotto attacco da parte della città e dello stato e che offre poche opportunità di istruzione o di lavoro.
Se ricordo bene, la storia di X è stata l’unica a parlare dell’essere queer e di coming out, e ha conferito un’ulteriore patina di inclusività all’intero evento – il che ha permesso all’università e all’attivista di presentarsi compiaciut* come se avessero “rappresentato” ogni tipo possibile di gioventù. Ma la loro presentazione ha nascosto ogni tipo di privilegio (come il loro) e ha oscurato la rapace gentrificazione dell’università dandole un volto più morbido, gentile e diversificato.
E le altre persone che erano salite sul palco? La maggior parte o tutt* finiranno molto probabilmente per passare il resto della loro vita e della loro carriera a ripetere, per un pubblico infinito, le loro storie traumatiche di giovani svantaggiat*, fino a quando non saranno troppo vecchi*. Poche persone fortunate troveranno un impiego in luoghi dove potranno effettivamente mettere a frutto il loro talento, ma molte saranno abbandonate sul ciglio della strada da università, artist* e organizzazioni non profit per i quali, dopo un po’, si riveleranno inutili. Nel frattempo, i e le “narranti” – quelle persone già benestanti che di professione sfruttano le storie dei loro traumi per vivere – se la caveranno più che bene. Persone come X continueranno a fare da influencer politic*, quel nuovo tipo di figura organizzativa che passa da una causa all’altra, passando agilmente da un lavoro all’altro, sempre con il linguaggio della critica al neoliberismo, tirando fuori la storia di un trauma solo quando è assolutamente necessario, magari finendo a capo di un’organizzazione non profit che costringe l* giovani a ripetere le loro storie traumatiche.
Ogni volta che sono costrett* ad assistere a una Trauma Parade, il mio istinto è sempre quello di precipitarmi sul palco, urlando: “La tua storia traumatica ti ucciderà!”. E lo farà: se non in senso fisico, sicuramente in senso psichico. Per quanto tempo puoi continuare a ripetere la storia di ciò che ti ha reso più vulnerabile, di ciò che potrebbe averti quasi ucciso, di ciò che hai bisogno di elaborare piuttosto che di ciò che sei costrett* a fare per vivere? Per quanto tempo puoi rivivere la tua storia ogni giorno, ripetendola a sconosciuti che si leccano i baffi mentre continuano a chiedere porno-traumi? Chi usa le persone sopravvissute a un trauma, vulnerabili ed economicamente precarie, come strumento di raccolta fondi non si preoccupa mai di assicurarsi che abbiano, ad esempio, meccanismi di coping adeguati come l’analisi. Semmai, hanno bisogno e richiedono che queste persone, nei loro periodi di vita più vulnerabili, continuino a sanguinare su un palco. Il trauma sta diventando più grande del capitalismo e ci distrae dalle operazioni delle economie materiali, come quelle delle università e dei movimenti di “giustizia sociale”.
Cosa succederebbe se non avessimo storie da raccontare?
- Si veda “Satan’s Silence: Ritual Abuse and the Making of a Modern American Witch Hunt” di Debbie Nathan e Michael Snedeker. ↩︎
- Per essere chiari: questo non è vero per tutti coloro che sono diventati leader del movimento delle persone senza documenti, ma finora nessuno ha sottolineato pubblicamente questa questione di privilegio. ↩︎
- Altro su questo nel mio libro in corso di pubblicazione, Strange Love: Why Social Justice Needs to Die. ↩︎
- Nella maggior parte dei casi uso pronomi di genere neutro, in parte per oscurare l’identità delle persone. ↩︎