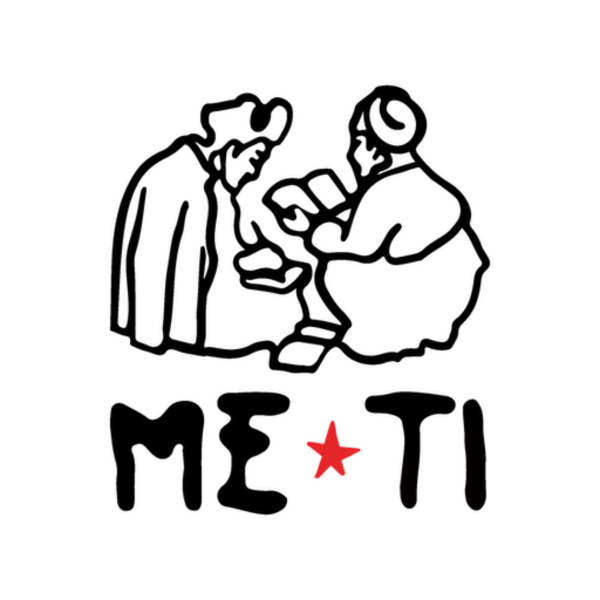Il dibattito che si è scatenato in queste settimane sul “Manifesto di Ventotene” è veramente surreale e soprattutto fuorviante, perché sposta l’attenzione dal tema del riarmo dei Paesi europei e riporta il tutto al gioco delle parti tra maggioranza e opposizione parlamentare. Giorgia Meloni ha infatti abilmente utilizzato alcuni passaggi dello scritto di Spinelli, Rossi e Colorni per mettere in difficoltà il PD, che, dal canto suo, ha utilizzato strumentalmente il “Manifesto di Ventotene” per giustificare le proprie posizioni in favore di un federalismo europeo di stampo liberista.
La narrazione della sinistra istituzionale, che descrive il processo di integrazione europea come nato da un anelito di pace e giustizia sociale dei popoli del vecchio continente e che avrebbe come testo fondativo il “Manifesto di Ventotene”, è semplicemente falsa. Questo presunto spirito originario basato su nobili ideali non è mai esistito. Quelli a cui assistiamo sono solo maldestri tentativi di creare dei miti fondativi intorno ai quali costruire un nazionalismo europeo a sostegno di politiche liberiste e belliciste. In questo momento storico invece è fondamentale aprire un dibattito sulla reale natura dell’Unione Europea e per farlo non si può prescindere da un’analisi storica del fenomeno fuori da ogni retorica.
All’ombra di Washington
Quando ci si trova ad analizzare un fenomeno è sempre difficile decidere da quale momento storico si debba iniziare. È evidente che si tratta sempre di una scelta arbitraria, ma allo stesso tempo è innegabile che ci siano momenti storici che segnano un prima e un dopo. Pertanto non apparirà un’eccessiva forzatura utilizzare come punto di partenza per l’analisi del processo di integrazione europea la fine del secondo conflitto mondiale.
Come tutte e tutti sanno, la seconda guerra mondiale termina con la vittoria degli Alleati (Unione Sovietica, USA e Gran Bretagna in primis) sulle potenze dell’Asse (Germania, Italia e Giappone). Nel 1945, alla fine delle ostilità, l’Europa si trovava sostanzialmente divisa in due aree di influenza: da una parte quella orientale, liberata dalle forze armate sovietiche e, dall’altra, quella occidentale controllata dagli USA. Il territorio tedesco, a differenza degli altri Paesi, era occupato da entrambi gli schieramenti (rispetto al territorio dell’attuale Germania circa il 30% sotto controllo sovietico e 70% controllato da USA, Gran Bretagna e Francia). In particolare, la capitale Berlino, situata nella parte est del Paese, all’interno dell’area occupata dall’Urss, per decisione presa nel 1945 durante la conferenza di Yalta, era a sua volta divisa in quattro settori amministrati da Unione Sovietica, USA, Gran Bretagna e Francia.
Come dimostrano una serie di conferenze fra i più alti rappresentanti delle forze alleate, di cui quella di Jalta è sicuramente la più celebre, già prima del termine della guerra la comunità internazionale e soprattutto le grandi potenze cominciarono ad interrogarsi su cosa fare dei Paesi che sarebbero usciti sconfitti, con particolare riguardo alla Germania, che aveva capitanato le forze dell’Asse. Nella prima metà del ‘900 la Germania aveva infatti tentato per ben due volte di estendere il proprio dominio sul resto del continente e le conseguenze in entrambi i casi erano state pesantissime. I popoli europei nutrivano un odio profondo verso i tedeschi, mentre le varie borghesie nazionali erano seriamente preoccupate da una possibile ricostruzione dell’economia tedesca, che avrebbe potuto dare nuova linfa alle sue velleità imperialistiche.
Mentre i sovietici avevano ben chiaro che fare della porzione di territorio tedesco da loro occupata, ovvero instaurare una repubblica socialista sotto il controllo di Mosca, diverso era il caso di Stati Uniti, Regno Unito e Francia, dove il dibattito fu lungo e animato. Prima della fine del conflitto e nell’immediato dopoguerra, prevalsero posizioni durissime, che miravano a indebolire strutturalmente l’economia tedesca della parte occidentale attraverso una deindustrializzazione forzata con conseguenze pesantissime per la popolazione. Ne è prova il piano Morgenthau, dal nome dall’allora Segretario del Tesoro USA (in carica dal 1934 al 1945). Tale piano, elaborato nel 1944, prevedeva di ridurre la Germania a un “Paese a vocazione soprattutto agricola e pastorale” oltre lo smembramento in diversi stati. Il piano Morgenthau non fu mai ufficialmente adottato. In compenso i suoi contenuti di fondo trovarono ampio spazio nel memorandum siglato da Churchill e Roosevelt al termine della seconda conferenza del Québec (tenutasi tra il 12 e il 16 settembre dello stesso anno) e soprattutto nella direttiva 1067 del Joint Chiefs of Staff (JCS 1067), approvata dal presidente Truman il 10 maggio del 1945, con cui venivano trasmesse ai comandi militari le indicazioni sulle modalità di gestione e le finalità dell’occupazione della Germania occidentale da parte delle forze armate statunitensi.
Gli anni dell’immediato dopoguerra furono durissimi per i tedeschi sotto occupazione USA e produssero un forte malcontento tra la popolazione civile. Popolazione, questa, in gran parte ridotta alla fame e priva di prospettive economiche, a causa delle restrizioni imposte dagli occupanti. Gli stessi vertici militari segnalarono quanto fosse pericoloso per gli interessi americani persistere con un approccio tanto violento e spietato, che alienava qualsiasi possibile simpatia verso gli Stati Uniti e che faceva invece guardare con favore all’URSS. In una celebre battuta del Generale Lucius Clay, Governatore dell’Amministrazione militare della Zona di occupazione americana della Germania dal 1946 al 1949: “È meglio essere comunisti con millecinquecento calorie al giorno che democratici con mille”. Lo stesso Clay dovette poi ammettere che: “non c’era dubbio che il JCS 1067 contemplò la pace cartaginese che dominò le nostre operazioni militari in Germania nei primi mesi di occupazione”.
Le riflessioni dei militari e dei funzionari del dipartimento di Stato impegnati sul terreno e soprattutto il corposo “Report sulla Germania” di Lewis H. Brown (commissionato proprio dal Generale Clay), in cui veniva sottolineata la fortissima interconnessione nell’ambito della produzione e del commercio tra i Paesi dell’Europa occidentale e la conseguente impossibilità di una ripresa economica del vecchio continente senza una contemporanea ripresa della Germania, portarono ad un rapido cambio di orientamento della presidenza Truman. Continuare ad umiliare il popolo tedesco e impedire la ricostruzione economica sarebbe stata, infatti, una scelta autolesionista, perché avrebbe dato un importante vantaggio politico e sociale ai partiti comunisti, in primis in Germania e poi nel resto del continente, mettendo a rischio gli interessi dell’imperialismo USA in Europa. Dall’altro canto, però, rimettere semplicemente in sesto l’economia tedesca sarebbe stato altrettanto rischioso. Cosa fare allora?
L’unica soluzione possibile, dal punto di vista degli USA, era associare forzatamente la Germania agli altri Paesi europei sotto la propria ala protettrice. In sintesi, quindi: il processo di integrazione nasce dalla volontà e dalle necessità dell’imperialismo statunitense e di alcune borghesie del vecchio continente di contenere l’avanzata del movimento comunista, di rilanciare il ciclo di accumulazione e contemporaneamente di limitare l’autonomia del capitale tedesco.
Una storia travagliata
Il primo passo in questa direzione fu la rinuncia già dal 1946 ad ulteriori riparazioni di guerra da parte americana. Nel 1947 il nuovo segretario di Stato George Marshall abrogò la direttiva 1067 del Joint Chiefs of Staff che, ricordiamolo, prevedeva di “non prendere alcuna misura per la riabilitazione economica della Germania [o] progettata per mantenere o rafforzare l’economia tedesca”. Venne quindi diramata la JCS 1779 che invece partiva dal presupposto contrario, in cui si affermava che “un’Europa ordinata e prospera richiede i contributi economici di una Germania stabile e produttiva”. Si arrivò così nel 1948 all’avvio dell’European Recovery Program, meglio conosciuto come “Piano Marshall”, che prevedeva trasferimenti ai Paesi dell’Europa occidentale per 13,3 miliardi di dollari (equivalenti a circa 173,8 miliardi di dollari nel 2024). Il Piano Marshall aveva come obiettivo dichiarato non solo la ripresa economica e l’ammodernamento del sistema produttivo, ma l’integrazione economica del vecchio continente.
Per consolidare la propria egemonia in Europa occidentale gli USA si mossero non solo sul piano economico, ma anche su quello militare. Nel 1949 venne quindi fondata la Nato, di cui facevano parte inizialmente Stati Uniti, Gran Bretagna, Canada, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Norvegia, Islanda e Danimarca (la Germania Ovest aderirà nel 1955).
L’altro passo fondamentale fu l’europeizzazione dell’industria del carbone e dell’acciaio, il cosiddetto trattato Ceca, entrato in vigore il 23 luglio del 1952. Carbone e Acciaio infatti sono i settori strategici per l’industria bellica e lo scopo era quindi rendere impossibile un eventuale nuovo riarmo della Germania. In particolare, era fondamentale costruire un’industria pesante franco-tedesca, in modo da rendere materialmente impossibile immaginare un conflitto tra i due. Concetto, questo, espresso in modo adamantino da Robert Schuman, allora Ministro degli esteri francese, in una dichiarazione del 1950: “la solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà sì che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile”.
Sempre nell’ottica di risollevare la Germania, nel 1953, ci fu l’accordo di Londra sul debito, dove venne deciso che tutti i debiti delle riparazioni della seconda guerra mondiale venissero congelati fino a quanto non ci fosse stata la riunificazione della Germania (una volta riunificata nel 1990 la Germania non pagò nulla, perché i debiti furono condonati). Seguirono poi i trattati di Roma del 1957, che andarono a formalizzare l’integrazione anche rispetto ad un altro settore altamente strategico, come quello dell’energia atomica dando vita all’Euratom. Il suo scopo era quello di coordinare i programmi di ricerca nucleare e soprattutto di assicurare un uso pacifico della possibilità di estrapolare energia dalla fissione degli isotopi dell’uranio.
Sempre ai trattati di Roma si deve l’istituzione della Comunità Economia Europea, che, a differenza delle precedenti forme di connessione reciproca fra Paesi europei, aveva obiettivi molto più ambiziosi, volti cioè alla possibilità di avviare un processo di vera e propria unificazione in senso federale. Con la Cee vennero infatti introdotte anche notevoli novità dal punto di vista dell’architettura istituzionale. Fu creata la Commissione, concepita come quello che in prospettiva sarebbe stato il governo del nuovo possibile Stato, il Consiglio dei Ministri e l’Assemblea Parlamentare. Venne così adottato “un nuovo equilibrio fondato su un “triangolo” dove le istituzioni sono tenute a collaborare tra loro: la Commissione emana le norme, il Consiglio prepara le proposte, il Parlamento ha un ruolo consultivo”. In particolare, l’Assemblea Parlamentare, che poi diventerà il Parlamento Europeo, non solo aveva un ruolo meramente consultivo, ma per di più non era elettiva. I suoi membri erano parlamentari dei Paesi membri scelti dai propri esecutivi.
A differenza della Ceca e dell’Euratom la vita della Cee ed in particolare della Commissione non fu affatto facile. Non fu facile perché le borghesie nazionali degli stati membri ed in particolare quella francese non avevano alcuna intenzione di cedere ulteriori quote di sovranità. Già nel 1960 De Gaulle mise in discussione le “potenzialità sovranazionali” dei Trattati di Roma e il concetto stesso di integrazione, preferendo parlare di cooperazione in un’ottica puramente intergovernativa. Posizione, questa, che venne esplicitata attraverso una nota al Presidente tedesco Adenauer, in occasione del bilaterale di Rambouillet del 29 e 30 luglio:
Per essere efficace, per essere sostenuta dal sentimento e dall’adesione dei popoli, per non perdersi nelle brume delle teorie, l’“Europa” attualmente non può consistere che in una cooperazione organizzata fra gli Stati. Tutto impone che questo si realizzi a partire da un accordo tra la Francia e la Germania, al quale aderiranno subito l’Italia, l’Olanda, il Belgio e il Lussemburgo. Adottare questa concezione significa ammettere che gli organismi “sovranazionali”, che sono stati costituiti fra i Sei e che tendono inevitabilmente e arbitrariamente a diventare “sovra-Stati” irresponsabili, vanno riformati, subordinati ai governi e utilizzati per i normali compiti della consultazione e della tecnica. Adottare questa concezione significa, d’altra parte, porre fine all’integrazione americana, visto che in ciò consiste attualmente l’Alleanza atlantica, e che è in contraddizione con l’esistenza di un’Europa dotata di una sua personalità e responsabilità dal punto di vista internazionale. L’Alleanza atlantica deve essere fondata su basi nuove. È compito dell’Europa proporle.
Tale visione venne formalizzata l’anno successivo, con la presentazione del Piano Fouchet. Come si capisce dalla stessa nota di De Gaulle, nella proposta francese era centrale la creazione di una Politica Estera Comune finalizzata a ridimensionare l’egemonia degli USA, che si realizzava soprattutto attraverso la Nato. In sintesi, la Francia era del tutto contraria a qualsiasi ipotesi di tipo federale che potesse limitare la sovranità dei singoli stati nazionali, ma favorevole ad una cooperazione tra i Paesi membri in materia di politica estera e di difesa, nella convinzione di potervi esercitare una funzione di leadership.
La discussione del Piano Fouchet fu estremamente complicata. Proseguì un anno per poi terminare con un nulla di fatto. La Germania aveva inizialmente appoggiato il progetto francese, che in qualche modo rendeva possibile incrementare la propria autonomia rispetto agli USA, ma successivamente, su pressione di Washington, desistette dal seguire la linea gollista. Fu proprio il rapporto con gli Stati Uniti a rappresentare lo scoglio principale della discussione. I francesi si scontrarono con la fortissima ostilità degli altri partner, in primis Paesi Bassi e Italia, che non avevano alcuna intenzione di sganciarsi dall’orbita del Patto Atlantico e temevano che nella nuova configurazione Parigi e Bonn potessero acquisire un eccessivo peso in ambito continentale in virtù della propria capacità economica, finanziaria, produttiva e militare.
I contrasti però non furono solo sul Piano Fouchet, ma riguardarono anche l’adesione del Regno Unito alla Cee e la PAC (Politica Agricola Comune). Inizialmente Londra non aveva investito nella possibilità del mercato unico e non aveva partecipato ai Trattati di Roma. Tuttavia, successivamente, capendone le potenzialità, aveva chiesto di aderirvi. La Francia però pose il veto all’ingresso del Regno Unito, che vedeva come troppo ingombrante, troppo legato agli USA e ostile a destinare risorse al settore agricolo.
In quegli anni lo scontro interno alla Cee tra i “federalisti” e la Francia fu molto forte, tanto che portò nel 1965 a quella che è passata alla storia come “Crisi della Sedia Vuota”. Il tutto partì dalla proposta dell’allora Presidente della Commissione Hallstein di creare un mercato agricolo comune sovranazionale, finanziato con risorse proprie controllate dal Parlamento europeo. L’approvazione di tale proposta doveva passare per un voto del Consiglio a maggioranza qualificata. Per protesta la Francia decise di disertare per sei mesi le sedute del Consiglio dei Ministri della Cee. La crisi ebbe fine nel gennaio del 1966 con il Compromesso di Lussemburgo, che ritardò l’autofinanziamento della PAC e i poteri di controllo del bilancio da parte del Parlamento, introducendo un diritto di veto informale nei casi in cui una decisione poteva minacciare gli interessi nazionali.
L’architettura politica e la vera natura dell’Unione
Come testimoniano la trattativa sul Piano Fouchet e la Crisi della Sedia Vuota, all’interno della Cee la Commissione venne sistematicamente esautorata a favore invece di un organismo informale di carattere intergovernativo non presente nell’architettura istituzionale precedentemente immaginata: il Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo nasce, infatti, nel 1961 quando i capi di Stato e di Governo della Comunità iniziano a riunirsi in modo informale e senza una cadenza predeterminata, al di fuori del contesto delle istituzioni comunitarie, senza dover rispettare regole e iter che gli stessi Paesi membri si erano dati con i trattati istitutivi. Tali vertici fra capi di Stato e di Governo, che poi prenderanno il nome di Consiglio Europeo, diventano quindi il luogo realmente decisionale alle cui volontà il resto delle istituzioni comunitarie non potevano far altro che adeguarsi. Dal 1974 verrà deciso di rendere stabili le riunioni dei capi di Stato e di Governo e nel 1992 con il Trattato di Maastricht il Consiglio Europeo verrà istituzionalizzato, rendendolo a pieno titolo un Organo dell’Unione. Con il Trattato di Lisbona (noto ufficialmente come il trattato sull’Unione europea, 2009) il Consiglio Europeo diviene una vera e propria istituzione dell’Unione Europea e ne vengono definiti i compiti: “Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali” (articolo 15). Quindi non un organismo sovranazionale, ma un organo intergovernativo, che delibera all’unanimità (tranne in alcuni casi contemplati dai Trattati).
Il Consiglio Europeo ufficialmente non svolge alcuna funzione legislativa all’interno dell’Unione Europea, ma di fatto, come si diceva in precedenza e come testimoniano anche le vicende delle ultime settimane, è l’istituzione che decide e dirige il processo di integrazione e non a caso “adotta le proprie decisioni in modo totalmente indipendente e nella maggior parte dei casi non richiede né l’iniziativa della Commissione né la partecipazione del Parlamento europeo”. Il Consiglio Europeo svela, fuori da ogni retorica, la vera essenza del processo di integrazione.
Per chiudere, se guardiamo la sua storia sul lungo periodo, l’Unione Europea nasce come progetto per assicurare la stabile appartenenza dell’Europa occidentale al campo atlantico, in netta opposizione a quello che era, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il blocco orientale a egemonia sovietica. In questo quadro di fondo, i processi di integrazione sono stati e restano tutt’oggi la mera somma di interessi e compromessi tra i singoli Stati membri. L’idea di un’Unione Europea rispondente a un progetto politico “federale”, che possa quindi affondare le proprie radici in un’ideale politico genuino, è così priva di fondamento.
I governi dei Paesi che compongono l’Unione Europea restano ad oggi rappresentanti delle singole borghesie nazionali. Queste sono in ovvia competizione tra loro, hanno interessi spesso diversi e collaborano solo negli ambiti e nelle circostanze in cui esiste una convenienza comune – come, ad esempio, nel momento in cui si è trattato di utilizzare le politiche europee come protezione ideologica per l’introduzione di riforme di stampo fortemente neoliberista, che hanno smantellato lo stato sociale e le tutele all’interno del mondo del lavoro. Un altro esempio è stata l’emissione da parte dell’UE di debito comune con il Next Generation EU, per ridare linfa al processo di valorizzazione e di accumulazione continentale interrotto dalla pandemia di Covid-19, tentando, da un lato, di non perdere la propria posizione privilegiata nella competizione economica internazionale e, dall’altro, di stroncare sul nascere le possibili conseguenze politiche dovute al disagio sociale generato dalla gestione dell’epidemia. È su questa base che sono stati redatti i trattati ed è questa, fuori da ogni retorica, la natura profonda dell’Unione Europea.
Lo sviluppo delle forze produttive e la maggiore socializzazione del lavoro hanno reso le economie europee sempre più interdipendenti tra loro, inducendo gli Stati a forme sempre più strette di integrazione economica e politica, fino a cedere alcune, parziali e limitate, quote di sovranità. Tale integrazione però non riesce a fare quel salto di qualità che porterebbe l’UE ad essere una reale unione politica, proprio perché si scontra con gli interessi contrapposti delle diverse borghesie nazionali.
Europeismo o sovranismo: una falsa alternativa
In questo quadro, le opzioni politiche che ci vengono proposte sono sostanzialmente due. La prima è quella di una maggiore autonomia nazionale, attraverso cui le singole borghesie nazionali sperano di evitare il proprio collasso. La seconda – portata avanti dai partiti cosiddetti progressisti o europeisti – che invece punta a una maggiore integrazione economica e finanziaria, il cui scopo effettivo è la possibilità che il capitale europeo possa reggere alla competizione del capitale internazionale, soprattutto statunitense. Nessuna di queste opzioni tiene conto delle necessità delle classi sociali subalterne dei Paesi del vecchio continente, perché sono solo espressione di settori diversi e contrapposti della borghesia europea.
Si tratta quindi di affrontare il difficile compito di trovare la contraddizione all’interno di questi processi contrari e contrapposti, per recuperare progressivamente quote di sovranità per le classi popolari. La sovranità di cui parliamo non è però quella dei “sovranisti”, cioè di quei gruppi politici che, anche quando si spacciano per forze di sinistra, non fanno altro se non proteggere gli interessi delle borghesie nazionali di turno. La sovranità, il potere sociale e politico da recuperare coincide con la riacquisizione degli strumenti di governo e di decisione collettiva su come dirigere il processo di integrazione produttiva, perché sia al servizio dei bisogni comuni e non invece del profitto di pochi.
In quest’ottica, il nostro obiettivo deve essere quello di approfondire le contraddizioni esistenti nella lotta fra i diversi campi della borghesia. Ciò si realizza, in primo luogo, impedendo che le scissioni e le contraddizioni interne al fronte padronale si proiettino sulle classi popolari, dividendole o sfruttandole per sostenere battaglie che non fanno, in realtà, i loro interessi. Questo, a sua volta, è possibile solo nella misura in cui vengano costruiti strumenti di rappresentanza sociale capaci di dare voce effettiva ai gruppi subalterni attraverso la loro organizzazione politica. Nella situazione attuale, uno dei compiti di tali strumenti di rappresentanza è quello di sfruttare in modo tattico, se vogliamo opportunistico, quel poco di virtualità politica positiva che il processo di integrazione parziale mette a disposizione, cioè la possibilità, data dalle attuali istituzioni europee (soprattutto il Parlamento), di creare alleanze e interconnessioni fra quei gruppi politici che lottano per un’Europa diversa. La battaglia contro i nazionalismi e lo strapotere del capitale finanziario va infatti combattuta su tutti i terreni a disposizione, cercando di ottenere vittorie che possano prefigurare un’alternativa politica e sociale concreta allo stato di cose presente.
È solo all’interno di questo contesto, in cui le classi subalterne dei singoli Paesi avranno una rappresentanza politica che faccia davvero i loro interessi e che sia connessa a una rete di alleanze e di supporto continentale, che sarà possibile sfruttare i momenti di crisi e le battute d’arresto del processo d’integrazione, in modo da consentire alla classe lavoratrice di diventare gruppo egemone a livello politico almeno in quelli che saranno gli anelli deboli della catena produttiva del capitale europeo (pensate all’occasione mancata, per l’assenza di strumenti politici adeguati sia all’interno che all’esterno, della crisi del debito in Grecia a partire dal 2009). Solo una volta che le classi popolari avranno recuperato per loro il potere politico e sociale sarà davvero possibile dare vita a un’unione fra Paesi europei, basata sulla solidarietà popolare, su di una produzione davvero integrata perché collettiva e sul soddisfacimento dei bisogni comuni.