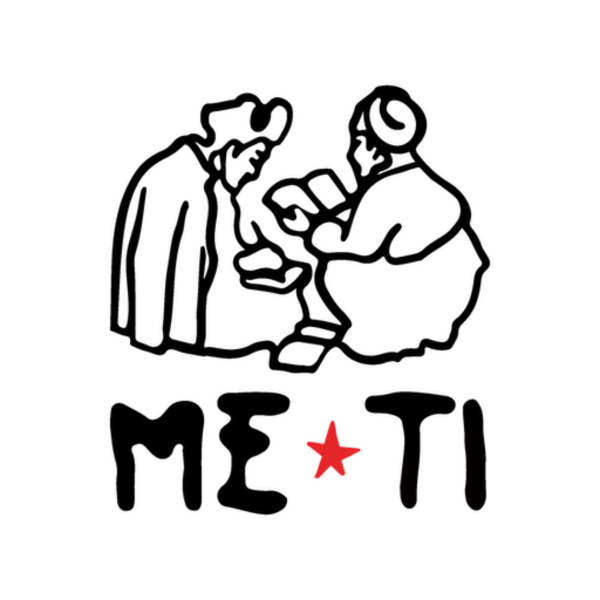Nell’articolo che segue, Martín Mosquera – docente all’Università di Buenos Aires e caporedattore della rivista Jacobin América Latina – analizza, alla luce delle esperienze rivoluzionarie del secolo scorso, la “via democratica al socialismo” che il teorico marxista greco Nicos Poulantzas (1936-1979) propone come alternativa alla socialdemocrazia e al modello insurrezionale della Rivoluzione d’Ottobre del 1917. Mosquera coglie l’attualità del ragionamento di Poulantzas, ma individua anche i punti deboli, in particolare in riguardo alla questione del “dualismo di potere” (cioè la distinzione fra potere della leadership istituzionale o rivoluzionaria e potere delle strutture di mobilitazione popolare) nel processo rivoluzionario.
L’articolo è stato pubblicato prima in spagnolo su Jacobin America Latina e poi tradotto in francese da Contretemps in occasione di una re-edizione di “Lo Stato, il potere, il socialismo” di Poulantzas nella collana Lignes rouges delle Éditions Amsterdam. L’illustrazione in copertina è di Francois Thevenet.
***
La strategia socialista in Occidente soffre di un deficit storico dovuto in primis all’assenza di vittorie rivoluzionarie nei Paesi capitalisti avanzati. Questo ha prodotto un divario tra i riferimenti strategici dominanti all’interno della sinistra marxista tratti dalle rivoluzioni di successo nei paesi periferici e le forme di dominio politico realmente esistenti nel capitalismo occidentale. Come osserva Perry Anderson:
Lo Stato rappresentativo che è gradualmente emerso in Europa occidentale, Nord America e Giappone dopo la complessa catena di rivoluzioni borghesi i cui episodi finali risalgono solo alla fine del XIX secolo era ancora un oggetto politico ampiamente sconosciuto ai marxisti quando ha avuto luogo la rivoluzione bolscevica.1
Il XX secolo è stato accompagnato da una graduale “occidentalizzazione” del mondo. Di conseguenza, il problema della strategia socialista in Occidente – che all’inizio del secolo scorso si limitava a una manciata di paesi industrialmente avanzati – ora si estende a gran parte della periferia capitalista. È quindi necessario formulare un approccio strategico che corrisponda a un mondo in cui uno Stato complesso si è consolidato e ramificato nella società civile, in cui la borghesia dispone di una forza sociale di gran lunga superiore a quella dei Paesi che hanno conosciuto vittorie rivoluzionarie (Russia, Cina, Vietnam, Cuba), in cui prevale un contesto di legalità per la lotta politica e in cui regna la democrazia liberale come meccanismo di metabolizzazione statale delle rivendicazioni sociali.
Negli ultimi anni un’ondata di ampie mobilitazioni sociali e l’emergere di forze di sinistra che ambiscono al potere governativo attraverso le elezioni (Grecia, Spagna, America Latina) hanno portato a un parziale rinnovamento del dibattito strategico. Quello attuale riflette una polarizzazione tra la “via democratica al socialismo” e il tradizionale approccio “insurrezionale” che risale a Lenin e Trotsky. Si tratta di due “modelli” alternativi che sembrano essere diametralmente opposti: la via al potere (elettorale o insurrezionale), il tipo di partito che serve (partito di massa o partito d’avanguardia), il tipo di polarizzazione politica prevista (un conflitto che porta a una scissione dello Stato dall’interno o una lotta tra lo Stato e un contro-Stato esterno), il tipo di regime politico post-rivoluzionario (radicalizzazione della democrazia parlamentare o democrazia sovietica).
A prescindere dal merito delle riflessioni in corso, questa discussione riproduce abbastanza fedelmente il dibattito degli anni Settanta, probabilmente l’ultima grande controversia sullo Stato e la rivoluzione in Occidente. La svolta eurocomunista, la scoperta del pensiero di Gramsci al di fuori dell’Italia e l’impatto delle esperienze dell’Unità Popolare cilena e della Rivoluzione portoghese, entrambe molto lontane dai canoni classici, sono state al centro delle discussioni che hanno segnato quegli anni. In questo contesto sono emerse opere importanti, come per esempio quelle di Nicos Poulantzas e Ralph Miliband sulla teoria marxista dello Stato, l’eurocomunismo di sinistra rappresentato da figure come Christine Buci-Glucksmann o Pietro Ingrao, così come i saggi critici di Perry Anderson ed Ernest Mandel contro l’eurocomunismo, il dibattito tedesco sulla derivazione dello Stato o gli approcci neo-francofortesi [relativi alla Scuola di Francoforte] di Jürgen Habermas o Claus Offe.
Oggi non disponiamo ancora di lavori dello stesso calibro. La mancanza di avanzamenti rispetto alla discussione degli anni Settanta è forse il sintomo di un’impasse che risiede nelle “cose stesse”. Da un lato, la dinamica degli attuali processi di radicalizzazione politica e sociale assume effettivamente i contorni previsti dall’ipotesi del percorso della via democratica: le ampie lotte sociali non portano all’eruzione vulcanica di Consigli degli operai e dei soldati, ma in genere pongono all’orizzonte la possibilità di un governo di sinistra nel quadro dello Stato capitalista. Ma, dall’altro lato, questi esperimenti si sono sempre scontrati con gli stessi ostacoli: la capitolazione socialdemocratica della leadership (Austria, Svezia, Portogallo, Francia, Brasile, Grecia, etc.) o l’incapacità di rispondere alla reazione delle classi dominanti (Cile). L’accumulazione di esperienze fallite è troppo grande per ignorarle; e non si può neanche semplicemente sperare di avere più fortuna “la prossima volta”.
In queste condizioni, è prevedibile una polarizzazione tra le due opzioni. Gli “insurrezionalisti” che criticano la “via democratica” mettono in discussione la tendenza delle forze elettorali di sinistra a capitolare di fronte alle classi dominanti; gli argomenti a loro favore non mancano. I sostenitori della “via democratica al socialismo” invece fanno spesso riferimento all’osservazione di Carmen Sirianni secondo cui non solo non ci sono state rivoluzioni di successo nei paesi democratici, ma che in una democrazia capitalista l’idea dell’insurrezione armata contro il governo non ha mai raggiunto consensi al di là di una piccolissima minoranza della classe operaia, anche in periodi di intensa mobilitazione sociale2. Non esistono vie democratiche vittoriose, ma non ci sono state neanche insurrezioni, nemmeno fallimentari.
Purtroppo, se guardiamo al problema senza produrre auto-illusioni o falsi ottimismi, dobbiamo riconoscere che, in una certa misura, entrambe le posizioni sono corrette. La situazione sembra quindi portare a un’impasse strategica. Di seguito cercherò di formulare un punto di partenza che indica un approccio parzialmente alternativo alle due principali opzioni e che è organizzato intorno a queste cinque ipotesi interdipendenti:
- L’osservazione di Sirianni è indubbiamente corretta: in una democrazia capitalista l’idea di un’insurrezione armata contro il governo non ha mai ottenuto un sostegno significativo, nemmeno in forma simbolica. È quindi irragionevole aspettarsi che le rivoluzioni del nostro secolo siano simili a quelle del periodo 1917-1921.
- A livello teorico, la tradizione insurrezionale soffre di un deficit fondamentale nella comprensione dello Stato capitalista e della democrazia; questo la porta all’obiettivo strategico di “distruggere” l’intero Stato e all’aspettativa di una sua graduale estinzione.
- Ciononostante, esiste un punto d’incontro con importanti conseguenze politiche tra la tradizione leninista e la critica “socialista-democratica”: entrambi identificano erroneamente la direzione di un processo di cambiamento radicale e gli organi politici di un eventuale regime di transizione al socialismo (soviet, parlamento, etc.).
- I sostenitori della “via democratica” (paradigmaticamente Nicos Poulantzas) tendono a privilegiare una concezione socio-centrica secondo cui lo Stato si riduce a una condensazione dei rapporti di forza senza alcun potere proprio. Spogliandolo della sua capacità d’azione, il problema della lotta strategica per il controllo dello Stato tende a spostarsi verso una maggiore o minore forza del movimento popolare che esercita pressione su di esso, il che implica il rifiuto di qualsiasi forma di dualismo di potere.
- Ne consegue che è necessario ripensare un approccio strategico adatto a una democrazia capitalista consolidata, il che implica dare importanza centrale alla lotta politica all’interno delle istituzioni democratiche, ma anche ripensare un concetto di dualismo di potere spogliato di alcune inutili connotazioni che gli sono state attribuite nella tradizione insurrezionale.
Democrazia e rivoluzione
Esiste una nozione ampiamente condivisa, anche se spesso tacitamente, che identifica l’organo di direzione politica di un processo rivoluzionario con le istituzioni di un regime politico post-rivoluzionario, siano esse i consigli (soviet), il parlamento o il partito.
Questa identificazione si manifesta in modo esemplare nella concezione dei consigli di Lenin: i soviet non sono solo gli strumenti della mobilitazione di massa nel contesto di una crisi rivoluzionaria, ma anche gli embrioni del nuovo Stato proletario. Per gli autori che si differenziano dal sovietismo russo (come Kautsky, gli austro-marxisti e gli eurocomunisti) il ragionamento è simile: il parlamento o il governo esecutivo, dominato dai socialisti, deve guidare il processo politico, in ogni caso sostenuto dalla mobilitazione sociale.
Questa idea è spesso generalmente accettata senza che vengano sufficientemente esaminate o valutate le conseguenze politiche che comporta. A mio avviso, contrariamente a quanto pensano sia i sostenitori della via democratica che quelli della via insurrezionale, non è necessario che la dirigenza di un processo rivoluzionario sia identica al potere politico socialista che ne deriva. L’analisi concreta delle esperienze rivoluzionarie dimostra che tale continuità non è esistita.
Nel corso di un processo rivoluzionario emergono forme di auto-organizzazione che mobilitano e unificano le masse (consigli, assemblee, comitati di fabbrica, etc.). Sebbene una rivoluzione vittoriosa abbia bisogno di un sostegno sociale di massa, gli organi che dirigono il processo si basano sempre su un attivo gruppo d’avanguardia. Di conseguenza, la natura progressiva di questi organi e il loro carattere democratico sono inseparabili dallo sviluppo di una crisi rivoluzionaria. Una rivoluzione può essere “il più gigantesco atto democratico” (Trotsky) nella misura in cui un ampio settore delle classi popolari passa all’azione politica e distrugge il vecchio ordine. Ma questa è la dinamica di un’insurrezione di massa, non quella di un regime politico. Un potere politico democratico e stabile necessita di una legittimità sociale anch’essa democratica; non può dipendere dall’iperattivismo di un gruppo d’avanguardia, e ancor meno dall’iperattivismo permanente della società nel suo complesso.
Così, l’emergere indispensabile di organi di auto-organizzazione durante una crisi rivoluzionaria non li rende necessariamente organi di governo. Dal loro legame inscindibile con il momento della spinta rivoluzionaria deriva che questi organi hanno un’esistenza transitoria. La loro vitalità dipende da un clima politico dinamico e straordinario, ma che è provvisorio. Infatti, se si esamina l’esperienza storica in modo rigoroso e onesto, essi non hanno mai sistematicamente svolto un ruolo di governo, nemmeno in Russia nel periodo tra il 1917 e il 1923, come si può facilmente evincere dalla progressiva perdita di centralità dei soviet e dall’improvvisa disaffezione politica seguita alla Rivoluzione d’Ottobre.
Tuttavia, non ne consegue, come sostengono Poulantzas e altri teorici della “via democratica”, che la polarizzazione politica caratteristica di un processo di trasformazione possa fare a meno degli organi del doppio potere durante un periodo di rottura anticapitalista. Le istituzioni del doppio potere devono svolgere un ruolo strategico, anche se non devono essere necessariamente intese come organi proto-statali.
Lo Stato e la strategia socialista in Poulantzas
In Lo Stato, il potere, il socialismo3, Poulantzas sostiene che lo Stato dovrebbe essere analizzato in termini simili alla concettualizzazione del capitale in Marx. Come il capitale, lo Stato non è una cosa o uno strumento, ma una relazione sociale. O, più precisamente, è “la condensazione materiale di un rapporto di forza tra classi”4.
Lo Stato cristallizza l’egemonia strutturale delle classi dominanti ma anche le lotte e la forza delle classi dominate. Lo Stato capitalista non è una fortezza da conquistare come se fosse un territorio straniero. Il rapporto tra lo Stato e le classi popolari non è di totale esteriorità: le classi popolari e le loro lotte sono presenti in esso in modi diversi, le loro conquiste sono integrate in varie forme istituzionali e politiche pubbliche (libertà democratiche, diritti sociali, etc.). Lo Stato non è solo un “guardiano notturno” o una “banda di uomini armati”, ma una struttura capillare inserita nella società civile, sensibile alle contraddizioni sociali e ai rapporti di forza tra le classi.
Questa concettualizzazione dello Stato ha dato origine a un nuovo quadro strategico che rompe con la tradizione leninista del doppio potere. La “via democratica al socialismo” propone una duplice strategia che opera sia all’interno dell’apparato statale – concepito come “campo strategico” – che nella lotta di massa. La concezione leninista di un “contro-Stato” operaio si basava sul fatto che lo Stato era considerato un mero strumento delle classi dominanti.
Invece, intendere lo Stato come una “condensazione” implica un approccio alla strategia socialista inteso come un processo che comporta sia la conquista di posizioni al suo interno – compreso l’accesso al governo attraverso le elezioni – che lo sviluppo di mobilitazioni di massa e di esperimenti di autogestione che esercitino una pressione dal basso per una transizione al socialismo. Questo processo di lungo respiro non potrà però evitare conflitti e momenti di rottura.
Lo Stato dispone di un suo proprio potere?
Nonostante i meriti di questa rielaborazione, permangono dei problemi teorici e politici. Per Poulantzas, lo Stato ha un’autonomia “relativa” a una condizione invariante: è determinato “in ultima istanza” dall’economia. Ciò colloca Poulantzas nella lunga lista di teorie che Michael Mann definisce “riduzioniste”, cioè la tendenza comune delle teorie liberali, pluraliste e marxiste che riducono lo Stato “a delle strutture preesistenti nella società civile”, in questo caso al potere della classe dirigente5.
Il marxismo ha tradizionalmente inteso la natura relativa dell’autonomia dello Stato come una forma di garanzia ultima nei confronti dell’ortodossia. Ammettere un potere statuale autonomo, cioè non soggetto a una “istanza determinante in ultima istanza”, è visto come identico alla concezione riformista della socialdemocrazia che fa dello Stato un’entità neutrale, arbitro della competizione tra gruppi sociali. L’autonomia tout court – o una riconcettualizzazione del concetto di “autonomia relativa” che non faccia riferimento a una “determinazione in ultima istanza” – ci avvicinerebbe, in questa visione tradizionale, a una problematica riformista-pluralista secondo la quale le diverse classi possono esercitare un’influenza paritaria sul governo e in cui lo Stato è in grado di regolare gli squilibri economici o sociali generati dal capitale.
Poulantzas lo ammette nella sua ultima intervista con Stuart Hall e Alan Hunt: “Io stesso non sono assolutamente certo di essere marxista. Chi può esserne sicuro? Ma se si è marxisti, il ruolo determinante dei rapporti di produzione, nel suo senso più complesso, deve avere un significato; e se lo ha, si può solo parlare di ’autonomia relativa’, questa è l’unica soluzione”6. Come dimostra la sua famosa polemica con Ralph Miliband sulla New Left Review7, per Poulantzas questo significa che lo Stato non ha alcun potere proprio. Le istituzioni statali “possono essere riferite solo alle classi sociali che detengono il potere” o, in altre parole, lo Stato è “un luogo e un centro per l’esercizio del potere, ma senza possedere alcun potere proprio”.
Riducendo il “potere di Stato” al “potere di classe”, Poulantzas va incontro a grandi difficoltà nell’affermare contemporaneamente l’autonomia relativa e il carattere strutturalmente capitalista dello Stato. Attaccandosi al concetto di autonomia relativa come mezzo per preservare il carattere di classe dello Stato, Poulantzas non riesce a identificare il modo concreto in cui lo Stato capitalista svolge effettivamente il suo ruolo di classe prestabilito. In realtà, il concetto di autonomia relativa di Poulantzas è un ostacolo piuttosto che una risorsa per stabilire il legame strutturale tra Stato e capitale.
Contrariamente a quanto suggerisce un’interpretazione diffusa, un’analisi che afferma l’irriducibilità dell’autonomia dello Stato al potere di classe può dare alle fondamenta strutturalmente capitalistiche dello Stato una base più solida. A tal proposito l’approccio di Fred Block sembra più appropriato. Block afferma che i “gestori dello Stato” dispongono di un’autonomia effettiva che non è riducibile al potere di classe.
Ma l’inserimento dello Stato nell’economia capitalista li obbliga, nel loro stesso interesse, a ricercare le condizioni favorevoli alla riproduzione del capitale. Il monopolio privato sugli investimenti crea una pressione oggettiva sulle autorità politiche affinché promuovano norme favorevoli agli interessi capitalistici. Il rischio di scioperi degli investitori e di fuga dei capitali, con i loro effetti destabilizzanti sulla politica e sul governo, li incoraggia a mantenere un “clima favorevole agli affari”8. L’autonomia del potere statuale non contraddice il suo carattere di classe che dipende fondamentalmente dal suo inserimento nei rapporti di produzione capitalistici.
Il rifiuto di Poulantzas della distinzione tra potere di classe e potere statale nel tentativo di difendersi dal riformismo conduce in un vicolo cieco. Minimizzando l’azione dello Stato, il problema della lotta strategica per il suo controllo tende a spostarsi sulla maggiore o minore forza del movimento popolare che esercita pressione su di esso. Inevitabilmente, l’autore di Lo Stato, il potere, il socialismo si aspetta che la pressione sociale porti alla radicalizzazione delle dirigenze riformiste di maggioranza.
Poulantzas prosegue così l’analisi classica che considera il carattere relativo dell’“autonomia relativa” come un limite per stabilire il carattere di classe dello Stato. Tuttavia, a ben vedere, vi è una curiosa complicità tra una riserva ortodossa nella teoria e una “svolta a destra” nella politica. Se Poulantzas avesse ragione, come dovremmo valutare l’esperienza storica che sembra mostrare che le mobilitazioni popolari al di fuori dello Stato, per quanto intense, si scontrano sempre con il margine di libertà disponibile e utilizzato da qualsiasi leadership politica? Non è forse questo l’effetto ultimo del potere proprio dello Stato? Il prezzo che Poulantzas paga per la sua concezione dello Stato come condensazione non è forse l’attenuazione della lotta propriamente politica tra progetti strategici antagonisti?
Per fare un esempio classico, la rivoluzione del novembre 1918 in Germania – conclusasi con l’ascesa al potere della maggioranza socialdemocratica e con l’assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht da parte dei Freikorps sotto il comando del socialdemocratico Noske – è fallita per la mancanza di pressione popolare sul governo Ebert o perché i socialdemocratici avevano preso il potere per contenere la rivoluzione, utilizzando lo Stato proprio a questo scopo?
Poulantzas non ignora il problema del riformismo. A suo avviso, esso può assumere due forme: quella della capitolazione della dirigenza (“socialdemocratizzazione”) o quella della tipica incapacità del riformismo di affrontare la reazione delle classi dominanti (come nel caso di Allende). Tuttavia, la sua risposta a questi rischi è l’esistenza di un “ampio movimento popolare” che eserciti pressione dal basso. Poulantzas risolve così troppo frettolosamente la questione dei rischi più gravi per la strategia socialista. Scrive:
Possiamo affrontare questo rischio solo facendo attivamente affidamento su un ampio movimento popolare. Sia chiaro: in ogni caso, e di fronte alla strategia ’avanguardista’ del doppio potere, la realizzazione di questa via e degli obiettivi che essa implica, l’articolazione dei due approcci che mirano a evitare lo statalismo e l’impasse socialdemocratica, presuppone il sostegno decisivo e continuo di un movimento di massa fondato su ampie alleanze popolari. Se questo movimento implementato e attivo (la rivoluzione attiva, diceva Gramsci, in opposizione alla rivoluzione passiva) non esiste, se la sinistra non riesce a costruirlo, nulla potrà impedire la socialdemocratizzazione di questa esperienza. Questo ampio movimento popolare costituisce una garanzia di fronte alla reazione dell’avversario, anche se non è sufficiente e deve sempre essere legato a trasformazioni radicali dello Stato.9
Aggiunge inoltre che questo movimento popolare può svolgere il suo ruolo solo nella misura in cui non pretende di porsi come centro politico alternativo che sfida lo Stato, in altre parole come doppio potere. Il potere popolare deve limitarsi a essere un fattore di pressione sullo Stato. Il suo rifiuto del doppio potere è una conseguenza naturale della sua definizione dello Stato come condensazione priva di potere autonomo. Quindi, l’emergere del doppio potere non è improbabile in una democrazia consolidata, ma è semplicemente considerato come una cosa indesiderabile. Su questo punto Poulantzas è categorico:
Una situazione di doppio potere, anche tra due poteri di sinistra, non ha nulla a che fare con un gioco di poteri e contropoteri che si bilanciano per il bene del socialismo e della democrazia. Questa situazione porta rapidamente a una contrapposizione aperta tra i due, con il rischio di eliminare l’uno a favore dell’altro. In un caso, si tratta di socialdemocratizzazione (il caso del Portogallo), nell’altro (eliminazione della democrazia rappresentativa) non si tratta del deperimento dello Stato e del trionfo della democrazia diretta, ma, a più o meno lungo termine, di un nuovo tipo di dittatura autoritaria.10
Qui Poulantzas ragiona in modo simile alla tradizione insurrezionale, cioè identificando gli organi di dirigenza di un processo rivoluzionario con la forma istituzionale di un potere politico socialista, anche se modifica la valutazione dei due termini dell’equazione. Lo Stato capitalista contiene conquiste politiche che devono essere conservate in un futuro potere politico socialista, principalmente la democrazia rappresentativa (parlamento, suffragio universale, sistema multipartitico, libertà democratiche, etc.).
Invece la delega della leadership a un’istanza extra-statale non significa “il trionfo della democrazia diretta”, bensì “l’eliminazione della democrazia rappresentativa” e “a più o meno lungo termine, un nuovo tipo di dittatura autoritaria”. Come la tradizione insurrezionalista, Poulantzas deduce che se nel corso del processo rivoluzionario la leadership viene delegata a un organo di “democrazia diretta”, questa logica si imporrà all’intero regime politico successivo, ma, a differenza degli “insurrezionalisti”, a suo avviso non si tratterà di una forma di democrazia di base, bensì di una nuova “dittatura autoritaria”.
Gli organi che emergono e prendono il controllo della situazione politica in una situazione rivoluzionaria hanno certamente un impatto sulla futura vita politica e istituzionale. Ma l’eterogeneità dell’esperienza storica non conferma il fatalismo suggerito da Poulantzas che ricorda le critiche di Kautsky alla rivoluzione russa. Si pensi al Comitato Centrale della Guardia Nazionale di Parigi che ha guidato l’insurrezione del 1871 e che si è poi dimesso a favore della Comune di Parigi; o alle Rivoluzioni di Febbraio e Ottobre in Russia, con i loro diversi rapporti tra soviet, governo provvisorio e Assemblea Costituente (la combinazione di soviet e Assemblea Costituente è stata difesa da gran parte della leadership bolscevica prima e dopo la rivoluzione). Sebbene Poulantzas non menzioni la questione, l’esempio storico più rilevante che contraddice il suo fatalismo è quello delle stesse rivoluzioni borghesi che hanno avuto come corollario la nascita di istituzioni liberali e repubblicane. Non c’è stata una “via democratica” verso le istituzioni democratiche dello Stato capitalista.
Dobbiamo a Poulantzas un progresso decisivo verso una concezione relazionale piuttosto che strumentale dello Stato. Ma il processo, storicamente senza precedenti, di “separazione” dei rapporti sociali che dà origine allo Stato moderno (cioè la separazione dello Stato e dell’economia come sfere indipendenti) conferisce al potere statuale – e quindi alle leadership politiche che lo dirigono – una vera e propria autonomia che implica che lo Stato non sia mai preda di rapporti di forza esterni, ma agisca su di essi, così come ne sia costituito. Se lo Stato è solo la condensazione dei rapporti di forza tra le classi, “una condensazione non può esercitare il potere” (Block). Comprendere la legalità e le dinamiche proprie a livello politico ci riporta al terreno della lotta tra progetti strategici antagonisti. E, in ultima analisi, al problema del riformismo.
Ripensare il dualismo di poteri in un nuovo quadro strategico
Se abbandoniamo il rifiuto poulantziano del potere autonomo dello Stato, la questione del doppio potere si pone sotto una nuova luce. Se lo Stato non si comporta mai come un semplice riflesso dei rapporti di forza, può agire in reazione contro di essi fino a romperli. Sia mantenendo un nucleo irriducibile dell’apparato repressivo dello Stato, anche quando questo viene indebolito o smantellato, sia, cosa che succede più spesso, utilizzando il proprio potere autonomo per contenere politicamente una situazione critica. Il ruolo della socialdemocrazia lo dimostra in innumerevoli occasioni: la Repubblica di Weimar, la rivoluzione portoghese, etc.
È chiaro che Poulantzas non rigetta la centralità della mobilitazione popolare. Né aderisce a una sorta di gradualismo riformista, contrariamente a quanto molte delle sue critiche “insurrezionaliste” hanno regolarmente affermato. Ciò che rifiuta è piuttosto la centralizzazione degli organi della democrazia di base e la loro trasformazione in un punto concentrato di potere popolare indipendente. Egli comprende bene le conseguenze della centralizzazione nei contesti di spinta rivoluzionaria. Quando gli organi di auto-organizzazione vengono centralizzati, emerge un potere che può prendere l’iniziativa, diventare indipendente e presentarsi come centro politico alternativo: si crea una situazione di doppio potere, capace non solo di esercitare pressione sul governo, ma anche di sfidare l’orientamento stesso del processo politico.
La vera utilità storica degli organi del doppio potere è la loro capacità di esprimere meglio le relazioni di potere nel contesto di una spinta rivoluzionaria. Le vecchie istituzioni resistono all’impatto di un improvviso cambiamento delle relazioni di potere. Un enorme potere sociale può esprimersi attraverso rivolte, mobilitazioni o esplosioni sociali. Ma se questa forza sociale non è centralizzata in una forma istituzionale che possa decidere di agire in modo coordinato, la mobilitazione sociale più impetuosa può svanire nel nulla e l’iniziativa è interamente lasciata alle istituzioni e alle organizzazioni preesistenti.
Lo Stato (soprattutto ai vertici: il governo esecutivo, il parlamento, l’alta burocrazia) è, generalmente, lo spazio in cui la pressione ad adattarsi e a capitolare è più forte. D’altra parte, il potere che viene dal basso, basato sulla partecipazione massiccia dei settori popolari, permette di esprimere in modo più diretto e chiaro i rapidi cambiamenti nelle masse, la modifica degli equilibri di potere e quindi di cambiare l’equilibrio tra le correnti moderate, che hanno più peso negli organi dello Stato, e le correnti radicali, che tendono a farsi strada nelle istanze di auto-organizzazione.
Alcuni esempi storici permettono d’illustrare meglio questo punto. Negli anni Venti, dopo la Rivoluzione tedesca, l’Internazionale Comunista aveva formulato un approccio strategico molto simile alla “via democratica”. In Germania, nel 1923, i governi eletti nei Länder a guida socialdemocratica (SPD) e comunista (KPD), così come l’accerchiamento da parte delle istituzioni borghesi loro imposto, hanno fornito l’impulso alla lotta rivoluzionaria. A Chemnitz si era tenuta una conferenza dei consigli operai sassoni. Si era formato un embrione di doppio potere capace di prendere l’iniziativa dell’insurrezione. Tuttavia, la SPD, che aveva una minoranza nei consigli, ma una maggioranza nel governo, aveva chiesto che la conferenza non assumesse poteri che appartenevano al parlamento. Il KPD aveva deciso di subordinare la possibilità di insurrezione a un accordo unitario, che non si è mai realizzato, e così la rivoluzione tedesca è fallita.
Sebbene ci fosse un embrione di auto-organizzazione – e, a questo livello, il KPD aveva più peso della SPD – la dinamica era stata vanificata dall’autolimitazione e dalla delega (“poulantziana”, si potrebbe dire) dei poteri al governo del Land della Sassonia. I riformisti, anche a sinistra, non erano disposti a guidare l’insurrezione, né a delegare questa iniziativa a un organo di potere alternativo. Sapendo che il KPD non era disposto ad andare avanti da solo, controllavano la situazione. Nella misura in cui l’avversario sa di avere l’ultima parola, la possibilità di esercitare pressione su di lui diminuisce improvvisamente. D’altra parte, se la pressione s’iscrive in un principio di straripamento o di contestazione che sfugge al loro controllo, la situazione cambia e la leadership minacciata può essere costretta a sostenere la radicalizzazione in corso. Ecco perché l’autolimitazione “poulantziana” è l’ostacolo maggiore, anche per la tattica di pressione sulle leadership egemoniche che Poulantzas postula.
Un fenomeno simile si è verificato durante il fallimento della rivoluzione spagnola, in particolare durante l’esperienza catalana tra il luglio e il settembre 1936. In quel periodo, il Partito Operaio di Unificazione Marxista (POUM) aveva accettato di entrare nel governo della Generalitat guidato dal Fronte Popolare Spagnolo e aveva proceduto allo scioglimento del Comitato Centrale delle Milizie con l’intermediazione – a sorpresa – di Andreu Nin, il leader del POUM. L’insurrezione del luglio 1936 contro il colpo di stato fascista aveva dato vita a forme di auto-organizzazione: i comitati locali delle milizie e il Comitato Centrale delle Milizie Antifasciste (CCMA). Come organi unitari erano rappresentate tutte le correnti, comprese quelle riformiste. Come alla conferenza di Chemnitz, le correnti riformiste – tra cui Esquerra Republicana, la famosa “ombra” della borghesia – avevano poca influenza in queste istanze, ma controllavano il governo della Generalitat. La decisione del POUM e di Nin di accettare lo scioglimento della CCMA aveva distrutto la possibilità di un potere alternativo in grado di superare le indecisioni della Generalitat.
Lo schema si ripete: negli organi di auto-organizzazione le correnti radicali trovano un’eco più favorevole e l’evoluzione dei rapporti di forza e il radicalismo delle masse nei periodi di conflitto rivoluzionario vi si riflettono meglio. Al “vertice” invece, le tendenze alla moderazione e all’adattamento e l’influenza dei riformisti sono più forti. In un simile contesto, quando la “base” è subordinata al “vertice”, anche sotto forma di pressione dell’una sull’altra, i riformisti controllano generalmente il processo politico.
In conclusione: una via rivoluzionaria al socialismo democratico
Le critiche all’approccio insurrezionale che si concentrano sulla sua irrealizzabilità politica in contesti di democrazie liberali consolidate mi sembrano sostanzialmente corrette. L’idea di una crisi rapida dovuta al crollo dell’autorità dello Stato e alla presa di potere statale da parte dell’insurrezione armata a oltre cent’anni dalla Rivoluzione d’Ottobre non è mai stata ripetuta con successo.
Come dimostrano le intuizioni di Gramsci, il quadro in cui deve collocarsi qualsiasi strategia socialista in Occidente, almeno per il momento, è quello di uno Stato complesso e ramificato nella società civile, di una democrazia capitalista consolidata e di un quadro di legalità per la lotta politica. Nel periodo attuale, quando la lotta di classe si intensifica, tende a manifestarsi nelle grandi mobilitazioni sociali combinate alle competizioni elettorali. È necessario e inevitabile costruire l’orizzonte strategico attorno a questa dinamica.
Le ragioni invocate dai sostenitori della “via democratica” per abbandonare il tentativo di “ripetere l’ottobre” sono a mio avviso convincenti. Erano convincenti anche per gli stessi bolscevichi e per la maggior parte dell’Internazionale Comunista fin dagli anni Venti, quando sono stati messi di fronte ai dibattiti sulle specificità della rivoluzione in Europa occidentale.
D’altra parte, la tipica maniera in cui è stata formulata la via alternativa al “leninismo tradizionale” presenta notevoli problemi teorici e politici. Sul piano strategico, essa porta a puntare tutto sulla radicalizzazione delle leadership riformiste egemoniche sotto la pressione popolare e a rinunciare alla costruzione di un doppio potere indipendente. Ma un potere popolare centralizzato è essenziale per superare la paralisi imposta dalla politica riformista, anche in uno scenario “poulantziano” di radicalizzazione delle leadership riformiste maggioritarie.
In uno Stato democratico rappresentativo, qualsiasi eventuale processo di transizione al socialismo emergerà probabilmente da una crisi prolungata, durante la quale le istituzioni liberali continueranno a funzionare attivamente. È quindi probabile che emergerà una rappresentanza elettorale o governativa della radicalizzazione in corso.
Da questo punto di vista, la “via democratica” è quella giusta. Ma è sbagliato dedurne la necessità per il vertice dello Stato (il governo eletto di sinistra) di controllare gli eventi – un errore simmetrico a quello degli “insurrezionalisti”. Al contrario, è necessario accompagnare un processo di radicalizzazione sociale con la costruzione di un centro di potere alternativo, basato sugli organi delle masse che possa decidere sia di fare pressione sulla leadership politica precedentemente stabilita, sia di superarla, nel corso degli eventi.
Ma questo ruolo strategico del doppio potere non significa che debba necessariamente diventare un organo di governo. Un’eventuale vittoria rivoluzionaria non dovrebbe portare alla distruzione delle libertà democratiche che si basano sul suffragio universale e sulla cittadinanza politica, ma all’inizio di un nuovo potere politico democratico che non può ridursi a organi d’auto-organizzazione nati da un momento d’eruzione vulcanica delle masse.
Possono sorgere tensioni tra gli organi che hanno assunto il controllo della vita politica durante una crisi rivoluzionaria (come il partito e gli organi di auto-organizzazione) e la necessità di costruire istituzioni per una democrazia socialista a lungo termine. Di fronte a queste tensioni, è fondamentale riconoscere che l’illusione di una sorta di democrazia diretta di massa permanente rischia di portare al suo opposto: lo statalismo generalizzato della vita sociale e l’emergere di un potere burocratico e bonapartista.
La democrazia comprende la dimensione del suffragio universale e della rappresentanza parlamentare, ma non si limita a queste. Come avevano anticipato gli austro-marxisti negli anni Venti, è possibile concepire forme miste di democrazia che articolano istituzioni di democrazia rappresentativa (assemblee legislative), democrazia diretta (referendum) e democrazia economica (sul posto di lavoro). Esplorare l’interrelazione tra rottura rivoluzionaria, transizione al socialismo e democrazia è una sfida centrale del nostro tempo. Restano da fare nuove esperienze.
- Perry Anderson, The Antinomies of Antonio Gramsci, Londres & New York, Verso, 2017 [1976], p. 103. ↩︎
- Carmen Sirianni, Councils and Parliaments: The Problems of Dual Power and Democracy in Comparative Perspective, in Politics & Society, 12/1, 1983, p. 83-123. ↩︎
- Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, Paris, Éditions Amsterdam, 2024. La traduzione italiana è stata pubblicata dalle Edizioni Pgreco nel 2023 [ndt]. ↩︎
- “Lo Stato è anche una condensazione materiale e specifica di un rapporto di forza, che è un rapporto di classe”, ibid., p. 119 [ndt]. ↩︎
- Michael Mann, The autonomous power of the state : its origins, mechanisms and results, European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv für Soziologie, Vol. 25, n° 2, 1984, p. 185. ↩︎
- Parcours: vers un eurocommunisme problématique, entretien avec Stuart Hall et Alan Hunt, in Nicos Poulantzas, Repères. Hier et Aujourd’hui. Textes sur l’État, Paris, Maspero, 1980 , p. 24. [prima pubblicazione in Marxism Today, luglio 1979]. ↩︎
- Nicos Poulantzas, The Problem of the Capitalist State, New Left Review, I/58, 1969; la versione francese è disponibile su Contretemps (22 settembre 2015); Ralph Miliband, The Capitalist State. Reply to Nicos Poulantzas, New Left Review, I/59, 1970 ; versione francese disponibile su Contretemps (5 ottobre 2015). La discussione è poi andata avanti con il testo di Miliband Poulantzas and the Capitalist State, New Left Review, I/82, 1973 e la risposta di Poulantzas, The Capitalist State: A Reply to Miliband and Laclau, New Left Review, I/95, 1976. ↩︎
- Fred Block, The Ruling Class Does Not Rule: Notes on the Marxist Theory of the State, in Fred Block, Revising State Theory: Essays in Politics and Postindustrialism, Philadelphia, Temple University Press, 1987, p. 67. ↩︎
- Nicos Poulantzas, L’État, le pouvoir, le socialisme, cit., p. 349-350. ↩︎
- Ibid., p. 351. ↩︎