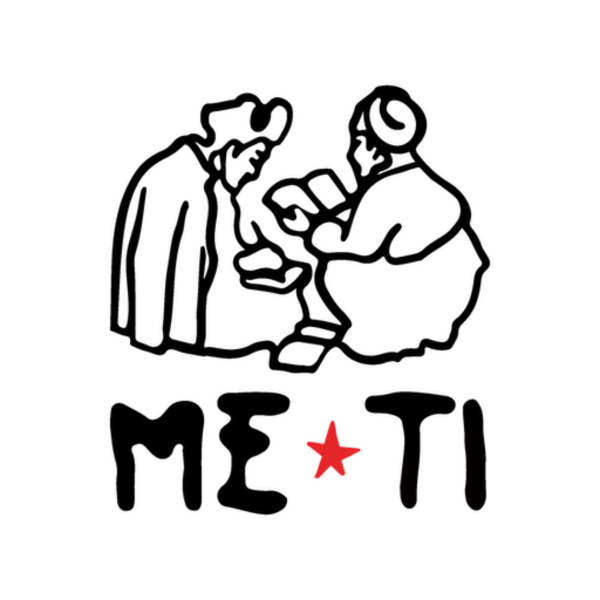L’entrata delle forze di opposizione nella capitale Damasco, la resa e la conseguente ritirata dell’esercito di Assad nonché la partenza di quest’ultimo per Mosca l’8 dicembre 2024 hanno costituito la caduta ufficiale del regime siriano che tra padre (Hafez) e figlio (Bashar) è durato oltre 50 anni. In tante zone del Paese, così come in diverse città europee in cui i siriani si sono rifugiati nell’ultimo decennio, migliaia di persone si sono rovesciate nelle strade per festeggiare: il sentimento di gioia per la caduta del regime ha prevalso, almeno temporaneamente, su quello della paura di fronte all’incertezza del futuro e alla fase di transizione a guida jihadista. Malgrado le tante difficoltà e contraddizioni, molte persone siriane oggi credono all’avvio di un processo democratico volto a ricostruire il Paese distrutto da decenni di capitalismo clientelare (crony capitalism)1, ingerenze straniere e guerra civile.
Gli anni dieci del Duemila avevano dato inizio a un vero e proprio nuovo ciclo di lotte politiche e sociali a livello globale: la contemporaneità delle Primavere Arabe 2010-2011 (Tunisia, Egitto, Libia, Yemen, Iraq, Bahrein, Siria), le proteste di Gezi in Turchia del 2013, i movimenti popolari che erano sfociati in governi progressisti in America Latina, ma anche le occupazioni delle piazze nei Paesi occidentali – da Occupy Wall Street negli USA al 15-M in Spagna, le possibilità di rottura con l’Unione europea che si erano create in Grecia, i cicli di lotte sociali e sindacali in Francia – e la ripresa delle Primavere Arabe 2018-2020 (Sudan, Algeria, Iraq, Libano) erano l’espressione di una profonda crisi del capitalismo mondiale, sia nel suo centro, ma anche e soprattutto nelle sue “periferie”.
Gli sconvolgimenti nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA) che chiedevano democrazia e giustizia sociale hanno scatenato un dibattito intorno all’autenticità e legittimità delle proteste e, di conseguenza, prodotto una forte polarizzazione della sinistra mondiale. Da un lato si trovano le correnti politiche che definiscono le sollevazioni popolari eterodirette dalle potenze occidentali interessate a modellare la regione a seconda dei loro bisogni (geo)politici ed economici. Le Primavere Arabe vengono in questo modo classificate come “Rivoluzioni colorate”. Di conseguenza, si devono “difendere” i governi al potere perché fattori di stabilità e/o difensori di posizioni antimperialiste.
Dall’altro lato, invece, esistono correnti di sinistra che riconoscono il carattere popolare delle proteste in atto e l’autenticità delle rivendicazioni di democrazia e giustizia sociale, ma che allo stesso tempo sono consapevoli delle grandi difficoltà che quel tipo di movimenti dovevano affrontare, vale a dire la mancanza di strutture democratiche organizzate e capaci di rappresentare le istanze popolari, il pugno duro della repressione dei rispettivi governi e gli interventi delle superpotenze regionali e internazionali.
Il caso siriano è diventato emblematico per la complessità delle diverse fasi che ha attraversato la mobilitazione popolare: trasformazione rapida delle sollevazioni sociali in una vera e propria guerra civile, violenta repressione da parte del regime, oppressione degli attori genuinamente popolari da parte di componenti strutturate e appartenenti a diversi poli di potere – dai militari dissidente dall’esercito regolare siriano all’islamismo politico, dalle forze regionali (Arabia Saudita, Qatar, Turchia, Iran, Israele) alle potenze imperialiste (USA, Russia) –, frammentazione politica, etnico-religiosa e geografica interna al Paese, una dilagante povertà che oggi colpisce circa il 70% della popolazione siriana, oltre 6 milioni di rifugiati e altrettanti sfollati interni.
Un ultimo elemento chiave per comprendere il caso siriano è la nascita, a partire dal 2014, di una zona autonoma in cui – tra tante difficoltà e contraddizioni – il movimento curdo sta costruendo una nuova società democratica e multietnica. Nata in un contesto di guerra civile (o, forse, grazie alla guerra civile che ha ridotto drasticamente la capacità del governo centrale di controllare l’intero territorio siriano), i curdi sono riusciti a creare l’Amministrazione autonoma democratica nella Siria del Nord-Est (DAANES) grazie a una forte organizzazione politico-popolare e un progetto di società maturato nei decenni di lotta per l’indipendenza. Anche il caso curdo è diventato oggetto di scontro nel dibattito della sinistra: il campo antimperialista critica la collaborazione delle forze curde siriane (YPG/YPJ/SDF) con l’imperialismo statunitense, mentre altre aree della sinistra radicale difendono l’esperienza del confederalismo democratico, e alcune lo considerano persino un modello da replicare in Occidente.
Gli obiettivi di questo approfondimento sono perlopiù tre: 1. offrire una breve ricostruzione storica delle tappe fondamentali della Primavera siriana; 2. inquadrare gli attori in campo e i loro interessi (geo)politici ed economici; 3. proporre una riflessione sui nostri attuali e futuri compiti politici da un punto di vista internazionalista.
Cosa è successo negli ultimi anni in Siria?
In seguito al gesto di protesta del fruttivendolo tunisino Mohamed Bouazizi il 17 dicembre 2010, il quale si diede fuoco dopo i maltrattamenti subiti da parte della polizia, in pochi mesi le proteste sociali si sono espanse anche in altri Paesi del MENA. Hanno raggiunto la Siria nel marzo del 2011 dopo che alcuni studenti erano stati arrestati per aver scritto su un muro “il popolo vuole la caduta del regime” nella città di Daraa, nel sud della Siria. Come negli altri Paesi, il governo siriano ha risposto reprimendo violentemente le piazze, arrestando i leader del movimento e iniziando a sparare sui manifestanti.
Come per la Tunisia – dove Ben Ali ha governato tra il 1987 al 2011 – e l’Egitto – Mubarak perfino dal 1981 al 2011 –, i manifestanti chiedevano la fine del regime della famiglia al-Assad iniziato nel 1971 con un colpo di Stato militare da parte di Hafez; il figlio Bashar aveva preso le redini del governo siriano nel 2000, in seguito alla morte del padre. I manifestanti rivendicavano inoltre la rimozione della legge d’emergenza che Hafez aveva introdotto pochi anni dopo la presa del potere – in vigore quindi da ormai 48 anni e usata per arrestare arbitrariamente gli oppositori –, il rilascio dei prigionieri politici e la fine della corruzione all’interno del governo e delle istituzioni dello Stato. Malgrado qualche concessione di Assad, la miccia ormai era stata accesa e, come in Tunisia ed Egitto dove Ben Ali e Mubarak erano stati costretti a lasciare il potere e dove era stato avviato un processo, anche se precario, di democratizzazione, il popolo siriano non aveva intenzione di fermarsi.
Già ad aprile del 2011 gli scontri hanno iniziato ad intensificarsi. Le Forze armate siriane (FAS) di Assad hanno iniziato ad assediare le città in cui le manifestazioni avevano assunto un carattere più radicale, schierato carri armati contro il popolo e arrestato e torturato manifestanti, giornalisti e attivisti politici. A luglio anche i manifestanti hanno iniziato ad utilizzare armi contro le FAS: alcuni colonnelli e ufficiali, con propri interessi materiali e di potere che il clan di Assad non garantiva più, hanno iniziato a disertare le forze armate regolari per fondare l’Esercito siriano libero (ESL) che si diceva rappresentare il “braccio armato” delle proteste sociali.
Assad aveva perso ogni legittimità popolare e la sua caduta sembrava essere imminente; ne erano una prova le strutture di democrazia diretta e i comitati autogestiti di cooperazione e mutualismo sviluppati sin dai primi momenti delle proteste popolari. Ma allo stesso tempo si era prodotto uno scollamento tra le ambizioni di queste ultime e l’agire dell’ESL. Quest’ultimo aveva ricevuto sin dalla sua formazione supporto economico e militare dall’Occidente, in primis dagli Stati Uniti, e da alcuni Paesi del Golfo (Qatar, Arabia Saudita). La trasformazione delle proteste popolari in uno scontro quasi esclusivamente armato tra le FAS e le milizie riunite nell’ESL ha aperto la strada alle milizie islamiste che si sono rapidamente imposte nell’ESL. Di seguito, gli USA hanno man mano ritirato il supporto; al suo posto è subentrata la Turchia che aveva bisogno di un proxy per difendere i propri interessi in Siria. Infatti, nel 2017 alcune milizie appartenenti all’ESL hanno formato l’Esercito nazionale siriano (ESN) sotto la diretta direzione della Turchia, che da allora fornisce finanziamenti, addestramento e supporto militare.
Già a metà del 2012, quindi, lo scenario siriano si era trasformato in una vera e propria guerra civile che ha completamente oscurato le rivendicazioni politico-sociali del popolo siriano. L’ingerenza estera era aumentata progressivamente, ognuno provava a imporre i propri interessi armando e offrendo supporto alle milizie sul campo: i Paesi del Golfo supportavano gli oppositori di Assad che era sempre stato fedele all’Iran, il grande competitor regionale; la Turchia appoggiava le milizie islamiste legate ai Fratelli musulmani (una fazione ultra-conservatrice della piccola borghesia siriana) per rompere il fronte curdo e imporsi come attore regionale prioritario; gli USA supportavano opportunisticamente l’ESL, le milizie islamiste e druse e il fronte curdo a geometria variabile, sempre con l’obiettivo di indebolire Assad e l’Iran, combattere l’islamismo politico e non perdere il predominio regionale; la Russia e l’Iran invece appoggiavano le FAS per difendere Assad e i propri interessi regionali e internazionali; sin da subito, inoltre, erano entrate in campo le forze jihadiste, sia quelle legate allo Stato Islamico che quelle più vicine ad al-Qaeda.
La frammentazione politico-militare ha inoltre prodotto una rapida frammentazione territoriale. Le diverse componenti di quella che viene chiamata “opposizione siriana” hanno iniziato a conquistare porzioni di territorio importanti. Nel 2013, lo Stato Islamico ha conquistato Raqqa, liberata dalle Forze democratiche siriane (SDF) solo nel 2017, grazie anche all’aiuto aereo e di artiglieria da parte degli USA; nel 2015 invece l’allora Fronte al-Nusra (più tardi Hayat Tahrir al-Sham, HTS) ha occupato Idlib che si trova ancora oggi sotto il suo controllo.
Nel 2014 invece è stata la volta della Siria del Nord-Est che, con i tre cantoni Afrin, Jazira e Kobane, si è dichiarata Amministrazione autonoma democratica della Siria del Nord-Est (DAANES). Il processo era già iniziato nel 2012, praticamente agli inizi della guerra civile, quando le zone a maggioranza curda si erano emancipate dal controllo del governo centrale siriano. Progressivamente sono state integrate anche le aree a maggioranza araba, assira e turcomanna. Da questo processo, alla fine del 2015 si sono formate le Forze democratiche siriane (SDF) che tutt’ora si scontrano regolarmente sia con l’Esercito turco che con l’ESN supportato militarmente dalla Turchia.
Negli anni 2015-2017 la Siria è diventata il principale teatro di guerra contro le forze jihadiste dello Stato Islamico. Una larga alleanza arabo-occidentale guidata dagli USA ha iniziato a bombardare massicciamente il Paese (ma anche l’Iraq); al Nord-Est gli USA hanno supportato le forze curde rifornendole di armi e assicurando protezione aerea. Ma anche le FAS di Assad hanno condotto la loro guerra contro il jihadismo, supportate dall’aviazione russa e da una fanteria in larga parte guidata da Iran e Hezbollah. Alla fine di questa prima fase bellica, Assad era riuscito a riprendere sotto il suo controllo circa due terzi del territorio siriano. Eppure, da quel momento è diventato chiaro che il suo regime riusciva a sopravvivere solo grazie al supporto delle forze estere alleate.
Mentre il mondo teneva gli occhi puntati sulla guerra contro lo Stato Islamico, il presidente turco Erdoğan aveva iniziato ad attaccare il progetto curdo in Siria. Già nel 2016 aveva invaso il Rojava in risposta alla creazione della DAANES; nei primi tre mesi del 2018 aveva poi scatenato un massiccio attacco su Afrin chiamato “Operazione Ramoscello d’Ulivo”, di seguito Afrin era passato sotto il controllo dell’ENS fino al 2022 quando quest’ultimo è stato rimpiazzato da HTS.
Le diverse tappe di questa guerra che ormai aveva assunto un carattere internazionale sono state accompagnate da vari tentativi di trattative di pace. Nel 2011-2012 la Lega araba aveva indotto un processo che però era fallito per una mancanza di volontà di tutte le parti. Il processo di pace di Astana del 2016 aveva invece avuto le conseguenze più importanti sullo scenario siriano. Le forze di opposizione proponevano di indire elezioni sotto osservazione internazionale per garantire la transizione verso la democrazia. Il primo tavolo di trattative non era arrivato a nessuna soluzione. Il secondo tavolo di Astana è stato poi avviato alla fine del 2016 da Turchia, Iran e Russia con l’obiettivo di trovare una tregua e dare avvio a un processo democratico. I dialoghi sono continuati per mesi, ma alla fine non è stato possibile trovare una soluzione di pace. Questo avvenne soprattutto per due motivi: 1) perché Assad continuava a considerare “opposizione politica” solo coloro che riconoscevano il suo ruolo indiscusso di presidente; tutte le altre forze venivano considerate “terroristiche” e quindi da reprimere anche con la violenza; 2) perché erano state escluse sia le forze curde della Siria del Nord-Est che quelle jihadiste che controllavano diverse parti del Paese e che non erano intenzionate a fermare la propria espansione. Il popolo siriano rimaneva vittima di una guerra civile che nel frattempo continuava a causare morte, distruzione, sfollamenti e povertà.
I primi due decenni del Duemila avevano dato ulteriore centralità ai tre grandi progetti che tentano di modellare l’intera regione secondo i loro interessi politici ed economici. Il primo è il neo-ottomanesimo che ha trovato nuova forza con la presa del potere da parte di Erdoğan in Turchia nel 2002. Si tratta di un maggiore coinvolgimento militare, economico e politico nelle aree precedentemente sotto il controllo dell’Impero ottomano, dai Balcani a parti del Nord Africa (Libia) e nell’area del Medio Oriente (soprattutto in Iraq e Siria). Il secondo è la Mezzaluna sciita con a capo l’Iran e i suoi collegamenti con forze e regimi come gli Hezbollah libanesi, Hamas a Gaza, gli Houthi yemeniti e le milizie irachene. La Siria a guida Assad faceva parte di quest’asse, e con la caduta del regime l’Iran ha perso un’importante pedina nello scacchiere regionale. Il terzo progetto è quello sionista della Grande Israele che ha utilizzato la propria forza militare per occupare territori interi e instaurare un regime coloniale, di apartheid e genocidario in Palestina sin dalla fine dell’800/inizi del ‘900, creare zone cuscinetto come nel Sud del Libano e della Siria (Alture del Golan) volte a difendere il proprio progetto e, in momenti espansionistici, occupare e controllare nuovi territori e bombardare i Paesi della regione (Iraq, Iran, Yemen) in nome della “difesa della democrazia”.
Gli sviluppi internazionali dal 2022 in poi hanno prodotto un rapido cambiamento dei rapporti di forza in campo. Con l’invasione russa in Ucraina e l’intensificarsi dello scontro Russia-NATO, Putin ha man mano dovuto concentrare le sue forze militari al confine occidentale del suo Paese. La guerra totale condotta da Israele nel MENA a partire dal 7 ottobre 2023 ha dall’altro lato indebolito fortemente Iran e Hezbollah. Gli alleati di Assad hanno potuto supportarlo militarmente ed economicamente sempre di meno2.
L’annuncio del cessate il fuoco in Libano il 27 novembre 2024 è stato utilizzato dalla Turchia per spingere i suoi alleati in Siria a fare pressione sul regime di Assad dopo che quest’ultimo aveva rifiutato ancora una volta di sedersi al tavolo delle trattative con Erdoğan fintanto che le truppe turche si fossero trovate in territorio siriano. Israele ha subito colto la palla al balzo per intensificare i bombardamenti sulla Siria, offrendo così supporto aereo a HTS nell’avanzata verso Damasco e, allo stesso tempo, minando le capacità militari di un futuro governo siriano.
Gli Stati Uniti e la Turchia hanno sempre continuato a supportare economicamente e militarmente milizie e componenti dell’opposizione siriana. Il ruolo dell’ENS nella presa delle maggiori città siriane (Aleppo, Hama, Homs e Damasco) è stato determinante; le milizie druse partite dalla base militare statunitense di al-Tanf hanno occupato Damasco venendo dal sud3. Il ruolo giocato da Stati Uniti, Turchia e Israele è quindi stato centrale.
Ma un regime cade anche e soprattutto per le sue contraddizioni interne: il basso riconoscimento materiale e la corruzione interna alle FAS hanno iniziato a pesare fortemente sulla motivazione di colonnelli, ufficiali e soldati siriani. Il loro definitivo abbandono di Assad è stato l’ultimo tassello di un processo in corso da 14 anni che ha portato alla totale frammentazione della Siria. E così, dopo oltre 53 anni, l’8 dicembre 2024 il regime della famiglia Assad è caduto definitivamente.
Il nuovo scenario in cui si trova il Paese comporta molte incertezze. È ancora difficile prevedere come sarà la Siria del futuro. Si tratta però di identificare le nuove contraddizioni che si sono create con la caduta del regime e il modo in cui gli attori in campo si muovono al loro interno.
L’Asse della Resistenza in crisi
Malgrado la retorica utilizzata dai leader di Teheran, il grande sconfitto di questa situazione è sicuramente l’Iran che perde “l’anello dorato” della catena della Resistenza. Oggi, i flussi di uomini e armi della Mezzaluna sciita rischiano di rimanere bloccati. Proprio nel 2015/2016 l’Asse della Resistenza sembrava aver raggiunto il suo momento di maggior forza grazie al recupero di una gran parte del territorio siriano da parte di Assad, alla capacità militare che avevano raggiunto le milizie libanesi, alla moltiplicazione delle milizie irachene e alle capacità degli Houthi di difendersi contro i bombardamenti della coalizione guidata dall’Arabia Saudita.
Il 7 ottobre 2023 però ha costituito una cesura importante per le forze sciite. Sulla scia del genocidio palestinese, Israele ha colto l’occasione per indebolire l’Iran e i suoi alleati. In Libano, Israele ha praticamente decapitato la leadership di Hezbollah con gli attacchi “mirati” attraverso l’esplosione dei cercapersone (18 e 19 settembre 2024) e l’assalto militare su vasta scala a partire dal 23 settembre e durato oltre due mesi; Israele parla di una riduzione della capacità militare di Hezbollah dell’80%.
La situazione iraniana è fortemente interconnessa con quella delle milizie libanesi. Come riportato dal Council of Foreign Relations, già nel 2020, dopo l’assassinio del generale Qassem Soleimani, Teheran aveva ritirato gran parte dei suoi militari dalla Siria, considerando la situazione di nuovo stabile, dando a Hezbollah il compito di garantire supporto militare a Damasco. Ma il genocidio in Palestina e la regionalizzazione del conflitto ha poi costretto le milizie libanesi a mettere in primo piano la difesa dei propri territori in Libano e, di conseguenza, a ritirare, a sua volta, i proprio uomini dalla Siria. Il 31 luglio 2024, poi, è stato ucciso l’allora leader politico dell’alleato Hamas Ismail Haniyeh a Teheran, scoprendo la debolezza dell’Iran di fronte alle capacità di Israele. Inoltre, quest’ultimo in diverse occasioni ha bombardato territori iraniani per far intendere che una reazione iraniana su larga scala in sostegno di Hamas non sarebbe stata tollerata in nessun modo.
A queste difficoltà createsi a causa della “guerra totale” israeliana si aggiungono altre crisi – sia etero-prodotte che interne – che colpiscono l’Iran. A causa delle sanzioni economiche imposte dall’Occidente e del forte scollamento della popolazione iraniana rispetto al progetto della Mezzaluna sciita, l’Iran sta attraversando un momento travagliato che gli impedisce di divenire realmente la potenza politica e militare egemone nella regione. Nelle discussioni sulla transizione siriana, la Repubblica islamica è attualmente la grande esclusa.
Il ruolo della Russia
L’altro alleato prestigioso della Siria di Assad – e proprio per questo l’altro grande sconfitto con la caduta del regime – è la Russia. La situazione in cui si trova oggi la Russia è perfettamente rappresentata da due immagini (contraddittorie) che segnano l’indomani della caduta di Assad, l’8 dicembre 2024. Da un lato, Assad ha trovato rifugio a Mosca sotto la protezione (più simbolica che veramente politica) del presidente Putin; dall’altro, il giorno dopo la fuga di Assad, all’ambasciata siriana a Mosca ha iniziato a sventolare la bandiera dell’opposizione siriana.
Ed è proprio in queste contraddizioni che si muove oggi la Russia che nel 2015/2016 aveva giocato un ruolo determinante nella stabilizzazione di Assad. Grazie agli interventi militari dell’aviazione russa erano stati respinti gli attacchi delle diverse fazioni dell’opposizione siriana. Le ragioni per il massiccio intervento russo in Siria volto a difendere il suo alleato erano molteplici. Nel 2016 Damasco aveva concesso ai russi l’utilizzo gratuito per 49 anni del porto di Tartus, lungo la costa meridionale siriana, e l’aeroporto di Hmeymim. La Russia ha investito diversi miliardi di rubli nella modernizzazione della sua infrastruttura militare siriana che ospita attualmente circa 7000 militari russi. Proprio il porto di Tartus garantisce alla Russia uno sbocco sul Mediterraneo, centrale nella “geopolitica delle pipeline” e nella proiezione di potenza e influenza nella regione MENA e nel continente africano (dove la Russia è presente in Libia, e anche con un ruolo centrale in Burkina Faso, Mali e Niger, nella Repubblica Centrafricana e in Sudan). Inoltre, la Russia aveva partecipato agli interventi militari per limitare le capacità dei gruppi jihadisti e ridurre il rischio di terrorismo islamico in Asia centrale, nei territori dell’ex Urss e nella Russia stessa.
L’accordo siglato per l’utilizzo delle basi portuale e aeroportuale continuerà ad essere in vigore anche sotto il nuovo governo transitorio e per il momento HTS non sembra intenzionato a scacciare la Russia con forza. Anche per questa ragione Putin ha già contattato il nuovo governo transitorio. Dal suo punto di vista, sarà centrale garantire la continuità della presenza russa in Siria4. In gioco ci sono sia le capacità logistiche di rifornire i suoi alleati nel continente africano (in caso di perdita delle due basi, la Russia sta già valutando una maggiore concentrazione logistica nelle sue basi libiche) che l’autorevolezza stessa di Putin: Mosca non può correre il rischio che la sua sconfitta in Siria venga paragonata a quella statunitense in Afghanistan nel 2021, cosa che confermerebbe sia l’errore strategico di Putin che la sua debolezza nei confronti degli alleati internazionali. Per questo a Putin non resta altro che agire opportunisticamente: abbandonare Assad e trattare con le nuove forze del governo transitorio siriano.
Gli interessi della Turchia
Sin dai primi momenti dell’incursione delle forze di opposizione siriane – prima su Aleppo e Hama, poi su Damasco – i commentatori hanno sottolineato il ruolo centrale svolto dalla Turchia nel supporto dei due attori principali di questa fase: HTS ed ENS. Come spiegato nella ricostruzione storica della situazione siriana, già negli anni precedenti Erdoğan non aveva mai esitato a utilizzare i proxy per raggiungere i suoi obiettivi principali in Siria. Il progetto neo-ottomano è la cornice politico-ideologica in cui si muove il governo turco. I suoi obiettivi in Siria sono principalmente tre.
I primi due obiettivi sono realizzabili nello stesso modo, avendo a disposizione una fascia di terra in territorio siriano da usare sia per gestire i rifugiati siriani che come “cordone sanitario” in funzione anti-curda. Riguardo al primo punto, l’Unione europea aveva finanziato il sultano turco – alla faccia dei diritti umani – per bloccare i rifugiati siriani alle porte dell’Europa. Oggi in Turchia ne vivono circa 3,5 milioni e negli ultimi anni sono stati strumentalizzati continuamente per le campagne nazionaliste, cosa che ha aumentato la violenza anti-araba in territorio turco. Erdoğan ambisce ad avere a disposizione una striscia di territorio siriano su cui collocare in un primo momento i rifugiati siriani di rientro nel loro Paese.
Questa zona deve inoltre avere la funzione di interrompere territorialmente il legame tra il Partito dei lavoratori curdi in Turchia (PKK) e le unità di difesa popolare dei curdi siriani nel Nord-Est della Siria (YPG/YPJ). L’affermazione del progetto di confederalismo democratico in Siria del Nord-Est è una spina nel fianco che “disturba” il progetto neo-ottomano e nazionalista della Turchia; l’autonomia curda in Siria funge da ossigeno per i curdi in Turchia che da anni lottano per una loro indipendenza e autonomia.
La terza ragione5 è collegata alla crisi economica che la Turchia vive ormai da diversi anni, con l’inflazione e i prezzi dei beni di prima necessità alle stelle, la disoccupazione ufficiale costantemente attorno al 10% e la presenza di lavoro povero in gran parte del Paese. La Siria assume un’importanza proprio in quest’ottica: investire in Siria significa poter sfruttare le potenzialità economiche e commerciali del Paese che fa da snodo tra Ankara e il mercato regionale del mondo arabo. Solo pochi giorni dopo la caduta di Assad il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha partecipato a una conferenza internazionale in Giordania in cui si è parlato di ricostruzione e futuro della Siria.
La ricostruzione del Paese con un PIL più che dimezzato durante i 13 anni di guerra civile e una situazione di deprivazione e povertà che colpisce circa il 70% della popolazione siriana è quindi una priorità. Ed è proprio in questa contraddizione tra stabilità politico-istituzionale necessaria a lungo termine per rilanciare economicamente la Siria e la lotta, nell’immediato, contro il movimento curdo nel Nord-Est del Paese che la Turchia deve trovare un equilibrio. Il secondo obiettivo però rischia di minare il primo, perché è raggiungibile solo con l’intensificazione del conflitto armato (con conseguenze per tutta la Siria).
I piani israeliani in Siria
Se dalla sponda settentrionale è la Turchia a imporre i propri interessi sulla Siria, da quella meridionale è Israele a fare altrettanto. Lo Stato sionista è la seconda potenza che prova ad approfittarsi della fine del regime di Assad. In primo luogo perché la sua caduta ha interrotto il corridoio logistico dell’Asse della Resistenza: oggi l’Iran è obbligato a trovare nuove rotte terrestri per rifornire gli alleati libanesi, cosa che comporta il rischio di esporsi ancor di più al monitoraggio israeliano e statunitense. In questo senso con la caduta di Assad si è realizzato un indebolimento degli avversari strategici di Israele.
Ma Israele si sta anche “rafforzando” direttamente in questa situazione di instabilità siriana. Netanyahu non ha esitato un momento ad avanzare in territorio siriano invadendo la fascia di sicurezza sulle Alture del Golan. Questa incursione è un’ulteriore violazione degli accordi del 1974 sulla zona cuscinetto del Golan visto che non c’era nessuna attività militare nella fascia demilitarizzata che avrebbe messo in pericolo Israele. Questo avanzamento territoriale si inserisce perfettamente nella “guerra totale” che Israele – con l’aiuto militare e finanziario incondizionato degli Stati Uniti e dell’UE – sta conducendo sui 7 fronti nemici (Gaza, Cisgiordania, Libano, Iraq, Siria, Yemen, Iran); i motivi che si celano dietro a questa forzatura sono molteplici.
Dal punto di vista militare, Israele – che ormai agisce impunemente violando costantemente il diritto internazionale – allarga e rafforza le sue frontiere nel nord-est. A partire dall’ottobre 2023, l’aviazione israeliana ha condotto più di 70 bombardamenti sulla Siria; dalla tregua con le milizie libanesi e l’avanzamento delle forze di opposizione siriana gli attacchi si sono moltiplicati a dismisura (si parla di quasi 700 bombardamenti in pochi giorni). Tali attacchi erano volti a distruggere gli arsenali di armi e le infrastrutture logistiche della Siria che, secondo le dichiarazioni ufficiali, rischiavano di cadere in mano a forze islamiste poco prevedibili. Tuttavia, Tel Aviv voleva soprattutto indebolire il nuovo regime di uno stato in cui la maggioranza della popolazione è fortemente antisionista. Dal punto di vista delle risorse energetiche, Israele punta a prendere sotto il proprio controllo il Monte Hermon dove si trovano importanti fonti d’acqua che riforniscono tutta la zona. Si tratta di un metodo di accaparramento di territori già applicato nei territori occupati in Cisgiordania dai coloni contro la popolazione palestinese (colonialismo verde). Dal punto di vista ideologico invece, l’avvicinamento a Damasco corrisponde alla realizzazione del sogno della Grande Israele (si vedano le dichiarazioni del ministro Bezalel Smotrich) e viene utilizzato per ricompattare la popolazione israeliana attorno all’immagine dell’imbattibilità del progetto sionista.
Nel medio e lungo termine la situazione può cambiare. Il giorno prima della caduta di Assad il Jerusalem Post auspicava di vedere un suo indebolimento, senza però che il regime venisse completamente rovesciato. Secondo diversi analisti, per molti versi Assad era il “nemico ideale” (vedi qui e qui), perché era un leader dipendente dai suoi alleati russi e iraniani e praticamente incapace di rispondere militarmente ai bombardamenti israeliani sul territorio siriano. A questa sua debolezza corrispondeva una prevedibilità politica e militare. Inoltre, il riavvicinamento alla Lega Araba aveva spinto Israele – i cui servizi segreti da anni avevano ormai infiltrato il regime di Assad – e gli USA a negoziare un suo distacco dall’Iran con la rimozione delle sanzioni (il cosiddetto Caesar Act imposto dagli USA nel 2019 e che era seguito alle prime sanzioni imposte da Barack Obama nell’aprile del 2011). Tale rapporto con la Siria è ora radicalmente cambiato e la caduta di Assad ha prodotto uno scenario incerto, anche per Israele, nonostante la situazione generale sviluppatasi dal 7 ottobre 2023 ponga lo Stato sionista in una netta posizione di forza di fronte agli altri attori politici della regione.
Al-Julani e il jihadismo di HTS
L’origine di Hayat Tahrir al-Sham (HTS) risale al 2012 con l’arrivo di Abu Muhammed al-Julani in Siria per costruire il ramo siriano dello Stato Islamico, il Fronte al-Nusra. Ben presto però al-Julani rompe con il leader al-Baghdadi e si avvicina ad al-Qaeda, guidata all’epoca da al-Zawahiri, con cui rompe a sua volta per formare un’entità indipendente dalle due maggiori organizzazioni jihadiste. Nel 2015 il Fronte al-Nusra prende il controllo di Idlib e due anni dopo, nel 2017, forma il Governo di Salvezza Siriano, una forma di Stato parallelo all’interno della Siria6.
Anche se lo Stato Islamico, al-Qaeda e HTS non sono (più) connesse a livello politico-organizzativo, continuano a condividere un’ideologia, il salafismo sunnita-revivalista (Sunni revivalist Salafism). Pensare però alla galassia jihadista come un monolite sarebbe un errore: ambizioni di potere, contesto nazionale ed evoluzione ideologica hanno prodotto una ramificazione all’interno del jihadismo politico. Lo jihadismo di matrice HTS ha subito una torsione pragmatica, localista e perfino nazionalista, orientamento contestato duramente dallo Stato Islamico che incarna invece l’altra tendenza jihadista contemporanea, cioè quella transnazionale, globalista, aliena al compromesso e nata come espressione dell’islamismo politico negli anni Sessanta e Settanta7.
L’anno 2017 è stato un momento chiave: l’organizzazione di al-Julani – l’allora Jahbat Fatah al-Sham, nome che aveva assunto il Fronte al-Nusra al momento della rottura con al-Qaeda nel 2016 – compie un’ulteriore trasformazione, cambiando sia il nome in HTS che l’orientamento strategico. La jihad viene ora affiancata da una strategia basata sulla diplomazia e sulla governance. Un cambiamento che rende l’organizzazione jihadista appetibile agli Stati Uniti, che sono alla ricerca di un loro riferimento in questa fase transitoria, e alla Turchia, che ha fortemente influito sullo sviluppo di HTS, soprattutto all’indomani del fallimento dei dialoghi di Astana: oltre a coprire un ruolo determinante nel rifornimento di armi e nell’addestramento militare, la Turchia funge anche da primo partner commerciale della formazione jihadista “con il sorriso”.
Sono stati proprio gli Stati Uniti ad aver permesso a HTS di diventare il gruppo di opposizione siriana dominante. Attorno al 2015, lo Stato Islamico era in una fase espansiva importante e stava diventando la fazione egemone. La coalizione militare anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti ha consapevolmente evitato sia di prendere sistemanticamente di mira le infrastrutture di HTS che di uccidere i suoi leader più importanti, in particolare al-Julani.
Nelle sue prime prese di posizione pubbliche, al-Julani non ha speso mezza parola contro Israele che, mentre HTS prendeva il controllo delle maggiori città della Siria, bombardava l’intero Paese per distruggere le sue capacità militari e logistiche. Anzi: pochi giorni dopo la presa di Damasco il leader di HTS ha ingiunto alla resistenza palestinese di smantellare le proprie basi in territorio siriano e le loro organizzazioni armate in cambio di un futuro riconoscimento politico e supporto sociale da parte del nuovo Stato siriano. La situazione politico-economica non permette ad al-Julani di farsi troppi nemici: ricostruire la Siria e le sue istituzioni pubbliche con le casse dello Stato vuote8 e le infrastrutture militari ridotte al minimo appare praticamente impossibile senza l’aiuto delle potenze internazionali.
La sua retorica a favore di un modello economico che si basa sul mercato libero e di un modello politico che rispetta l’esistenza delle minoranze religiose ed etniche va interpretata in questa prospettiva. Però il sorriso, la barba curata e l’apparente integrazione di valori occidentali non deve far dimenticare che il programma di HTS non rifiuta la sharia come quadro legale della Siria del futuro; al-Julani parla semplicemente di una sua “evoluzione”.
Nell’immediato, al-Julani punterà a due cambiamenti che costituirebbero una svolta politico-economica fondamentale per il rilancio del Paese: la rimozione delle sanzioni contro la Siria (Caesar Act) e di HTS dalla lista delle organizzazioni terroristiche. Questo riconoscimento internazionale rafforzerebbe la sua posizione nella Siria del futuro.
E l’imperialismo yankee?
Storicamente gli USA hanno occupato il Medio Oriente, bombardato governi nemici e stretto accordi politico-economici con vari regimi per assicurarsi una posizione strategica e il controllo sulle riserve petrolifere più importanti. A partire dalla metà degli anni Sessanta, lo Stato coloniale di Israele ha svolto sempre di più il ruolo di “cane da guardia” degli interessi USA nella regione.
In Siria, la presenza statunitense conta diverse basi militari all’est e al sud del Paese con 900 soldati. Gli Stati Uniti hanno avuto un ruolo determinante nella frammentazione della Siria negli ultimi 15 anni, finanziando e armando varie milizie anti-Assad, anche quelle appartenenti al mondo dell’islamismo politico/jihadismo. La partecipazione militare alla guerra civile è iniziata con l’allora presidente Obama che si era schierato nettamente a fianco della cosiddetta opposizione siriana. Il suo successore, Trump, aveva utilizzato una retorica di non ingerenza negli affari interni nei Paesi arabi e quindi anche in Siria e durante la campagna elettorale aveva chiarito che la sconfitta del regime di Damasco non sarebbe stata una priorità della politica statunitense. Pochi mesi dopo il suo insediamento, nell’aprile del 2017, è stato però proprio Trump a bombardare il Paese. Questa imprevedibilità di Trump è attesa anche con il suo secondo mandato da presidente USA che inizierà il 20 gennaio 2025.
Contrariamente al racconto dominante nei media mainstream, gli USA hanno giocato un ruolo centrale anche in questa ultima fase della caduta del regime Assad. Già settimane prima dell’8 dicembre, gli USA avevano informato alcune milizie che si stavano verificando grandi cambiamenti nel Paese. Le milizie druse che tra il 7 e l’8 dicembre 2024 hanno assediato Damasco provenendo da sud sono state addestrate e supportate proprio dai militari USA nella loro base militare di al-Tanf al confine con l’Iraq. Inoltre, già dopo il primo colloquio diplomatico ufficiale tra gli USA e il governo transitorio di al-Julani, i diplomatici statunitensi hanno annunciato di aver tolto la taglia di 10 milioni di dollari per l’arresto di al-Julani stesso.
Questo è solo l’ultimo segnale di una collaborazione più stretta tra l’imperialismo yankee e le nuove forze del governo siriano: gli Stati Uniti sono orientati a mantenere il controllo della regione impiegando lo sforzo economico e militare minimo; per fare ciò, gli USA contano senz’altro su Israele, ma puntano anche opportunisticamente sugli attori che più difendono i loro interessi – e in Siria oggi sembra proprio al-Julani a poter svolgere questo ruolo: indebolire i nemici regionali (in primis l’Iran), garantire la presenza militare nella regione e l’accesso ai pozzi petroliferi più rilevanti, non avviare un conflitto con Israele, vero prolungamento degli interessi USA nella regione.
La questione curda nel contesto mediorientale
Il movimento curdo ricopre un ruolo centrale in Medio Oriente. Nel 1978 nasce in Turchia il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) sotto la guida di Abdullah Öcalan. Fino agli inizi degli anni 2000, il movimento curdo9 – convinto che senza la soluzione della questione palestinese e di quella curda l’intero Medio Oriente non poteva avviare un vero processo democratico verso il socialismo (sul rapporto tra i due movimenti si veda questa sintetica ricostruzione) – seguiva una dottrina marxista-leninista ortodossa e connessa alla più tradizionale idea di liberazione nazionale: i curdi ambivano a creare uno Stato curdo che integrava le quattro regioni curde della Turchia, della Siria, dell’Iraq e dell’Iran. Dopo i primi anni di carcere e isolamento, il leader Öcalan ha iniziato a sviluppare l’idea del confederalismo democratico, una svolta ideologica del movimento. L’obiettivo non era più uno Stato-nazione proprio, bensì un’autonomia all’interno di una Turchia (e quindi anche di una Siria, Iran, Iraq) democratica, in cui tutte le etnie e religioni possano convivere.
In Siria, le proteste popolari prima e soprattutto la guerra civile poi sono state l’occasione per il movimento curdo di avviare un processo di autonomizzazione. Qui ritroviamo un primo elemento fondamentale della rivoluzione curda: senza la frammentazione del territorio e delle istituzioni statali della Siria dovuta al rapido approfondimento della guerra civile, difficilmente il movimento sarebbe stato capace di proclamare la DAANES già a partire dal 2012. Il Contratto Sociale del Rojava rappresenta l’elemento attorno a cui è nata la democrazia radicale che supera la divisione etnica della Siria del Nord-Est e rende partecipi tutti i gruppi etnici presenti in quella porzione di territorio siriano. Ed è sulla base di questa esperienza che si parla di Rojava come esempio per la Siria e per tutto il Medio Oriente.
Malgrado l’esperienza del Rojava incontri l’ostilità generale (turca, jihadista, del regime di Assad prima e del governo di transizione ora), il braccio armato del movimento curdo, le Unità di protezione popolare e delle donne (YPG/YPJ), è sempre stato capace di difendere il suo progetto politico. In diverse occasioni gli interessi curdi e quelli statunitensi si sono incontrati, dalla guerra contro lo Stato Islamico passando dall’ostilità per il regime di Assad alla protezione del territorio della Siria del Nord-Est che detiene la grande maggioranza dei giacimenti di petrolio e gas del Paese. Soprattutto durante l’avanzata feroce dello Stato Islamico il movimento curdo ha potuto contare sul supporto dell’aviazione statunitense. Questa alleanza tattica nata in uno specifico momento della guerra civile siriana ha però un carattere profondamente precario: gli USA intervengono in difesa dei curdi solo quando lo ritengono opportuno; ne è una prova la loro “tolleranza” verso le aggressioni feroci della Turchia – un alleato NATO – al progetto curdo.
Se la presa di Damasco da parte di HTS ha significato la fine della guerra civile in Siria, questa tregua non vale per la Siria del Nord-Est dove l’avanzata dell’ENS e dell’Esercito turco è continuata e si è perfino intensificata dopo l’8 dicembre. In una dichiarazione di metà dicembre, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dichiarato che lo scioglimento delle Unità di protezione curde YPG/YPJ è priorità assoluta dell’intervento turco in Siria; con questo intende che i combattenti internazionali devono partire, le forze del PKK presenti in Siria si devono ritirare e che i siriani del Nord-Est devono deporre le armi. Per fare ciò, la Turchia si appoggia all’ENS, i cui rappresentanti sono ormai ospiti fissi dei salotti e delle TV turche. Alcune città sotto controllo delle SDF come Manbij sono già state annesse dall’ESN, per evitare lo spargimento di sangue le SDF si sono ritirate ad est dell’Eufrate. Gli attacchi dei droni turchi il 19 dicembre hanno ucciso i due giornalisti Nazim Dastan e Cihan Bilgin. Un’operazione militare su larga scala contro il Rojava sembra quindi essere imminente – e dipendente dagli USA (incognita Trump!) che potrebbero dare il via libera nello spazio aereo per bombardare la Siria del Nord-Est.
La repressione turca nei confronti del movimento curdo continua anche all’interno della Turchia stessa. A fine ottobre 2024 il leader del partito di ultradestra turco Mhp, Devlet Bahçeli, alleato di Erdoğan, ha invitato Öcalan a parlare in Parlamento: in cambio della sua scarcerazione, Öcalan dovrebbe annunciare lo scioglimento del PKK e la fine della lotta per la liberazione del popolo curdo e per la sua autonomia territoriale e istituzionale. Vanno anche avanti i commissariamenti dei comuni in cui alle ultime elezioni di fine marzo 2024 ha vinto il partito filo curdo Dem (ex Hdp) e gli arresti dei sindaci e dei militanti curdi.
Consapevoli della quasi impossibilità di difendere il progetto curdo in un confronto esclusivamente militare – quindi senza perdere vite umane e territorio e senza produrre centinaia di migliaia di sfollati –, la DAANES ha subito avviato un processo di pacificazione con i diversi attori in gioco. Dopo il ritiro ad est dell’Eufrate, le SDF hanno proposto una tregua militare permanente alla Turchia che però ha rifiutato. Le autorità hanno anche innalzato la bandiera dell’opposizione siriana in Rojava, non semplicemente per non inimicarsi al-Julani, ma come espressione del suo orientamento strategico: confederalismo democratico significa costruire un’autonomia popolare curda all’interno di una Siria democratica e confederale che riconosce tutte le minoranze religiose ed etniche. Il DAANES ha inoltre revocato i dazi doganali con il resto della Siria come segnale di aperture nei confronti del processo che è stato avviato a Damasco. Ma i segnali che vengono dalla capitale siriana non sono positivi: il governo di transizione ha dichiarato che delle forze armate parallele a un futuro esercito regolare non saranno assolutamente tollerate.
I cambiamenti in Siria e la questione palestinese
Non è possibile parlare di Siria senza fare un focus specifico sull’impatto che i cambiamenti in atto avranno sulla questione palestinese, soprattutto dopo l’accelerazione del genocidio a partire dal 7 ottobre 2023.
Un punto importante è stato sicuramente che dopo la tregua libanese e l’avanzamento di HTS e dell’ENS verso Damasco, fino alla sua presa l’8 dicembre 2024, le atrocità commesse da Israele a Gaza e in Cisgiordania sono temporaneamente scomparse dall’attenzione dei media mainstream. Mentre Israele bombardava la Siria, le Forze di occupazione israeliane (IOF) hanno continuato a bombardare anche Gaza, uccidendo diverse centinaia di persone in pochi giorni. A un certo punto sembrava che si stesse per arrivare a un cessate il fuoco permanente tra Hamas e Netanyahu; Hamas aveva perfino accettato la presenza dell’IOF a Gaza in una prima fase di transizione verso la tregua e la restituzione degli ostaggi ancora in vita. Tuttavia, i continui bombardamenti di Israele su scuole e ospedali diventati rifugi per i gazawi sopravvissuti agli ultimi 15 mesi di massacro sembrano essere piuttosto un indizio che la volontà di Israele è quella di “terminare il lavoro più velocemente”.
Le diverse reazioni delle componenti della resistenza palestinese hanno inoltre dimostrato che non c’è mai stata unità politico-ideologica riguardo agli alleati strategici delle forze palestinesi. Hamas e la jihad islamico-palestinese, per esempio, si sono complimentati con al-Julani per la presa di Damasco e per aver restituito al popolo siriano dignità e prospettiva di una reale liberazione del Paese. Il FPLP, invece, è stato nettamente più cauto nel suo giudizio e ha guardato soprattutto all’instabilità che la caduta di Assad avrebbe provocato. Non senza ambiguità (si ricordi, ad esempio, l’atteggiamento della Siria durante le prime fasi del conflitto libanese fra il 1975 e il 1982), nel corso della sua storia il regime siriano ha comunque sostenuto la causa palestinese ed effettivamente è stato uno dei pochi regimi arabi a non aver avviato un processo di normalizzazione con Israele. Se la Siria è stata importante come zona di passaggio per il rifornimento militare della resistenza palestinese, d’altro canto Assad non ha mai agito direttamente a favore dei palestinesi, neanche quando l’aggressione di Israele ha raggiunto i massimi livelli. Possiamo dire che il regime di Assad rappresentava il classico “silenzio arabo” sulla questione palestinese che ha caratterizzato i regimi regionali negli ultimi decenni.
Di fronte alla precarietà del governo di transizione di HTS e alle tante difficoltà da risolvere in Siria, al-Julani avrà poco tempo per prestare attenzione alla causa palestinese. I bombardamenti israeliani sulla Siria hanno inoltre avuto un ruolo di monito verso i nuovi governanti che non hanno nessun interesse a entrare in conflitto con il vicino, detentore – grazie all’incondizionato sostegno degli USA – dell’egemonia militare nella regione. I cambiamenti siriani avranno quindi un impatto diretto sulla causa palestinese, perché Israele sta approfittando dell’instabilità siriana per avanzare nella sua guerra totale. Questo allargamento della guerra israeliana in altri territori nasconde l’enorme rischio di un isolamento ancora maggiore della resistenza palestinese.
La Siria nel contesto internazionale – che fare?
Sviluppare una prospettiva politica antimperialista e internazionalista sulla situazione siriana ci impone di prestare attenzione a tre elementi.
Primo. Tra le potenze regionali e imperialiste, quelle che più di tutte approfittano dell’instabilità siriana sono gli Stati Uniti, la Turchia e Israele – e per questo i progetti imperialista, neo-ottomano e sionista sono i fattori problematici principali. La Turchia agisce contro il progetto di emancipazione curda; il piano di Israele rimane l’occupazione coloniale della Palestina e la realizzazione del progetto sionista della Grande Israele; gli Stati Uniti in questo momento sembrano i più riservati, quasi degli spettatori, ma il loro ruolo storico nella regione è sempre stato un fattore di instabilità e di impedimento all’emancipazione dei popoli. Anche i piani non ancora chiari di Trump in Siria non cambieranno nulla a questo dato di fatto. Gli sforzi politici devono quindi essere rivolti al sostegno dei progetti di emancipazione del movimento curdo e della resistenza palestinese e al moltiplicarsi delle lotte di liberazione antimperialista.
Secondo. Dall’esplosione della guerra civile, la Siria è stata martoriata non soltanto dal regime di Assad, ma anche dalle diverse potenze regionali e imperialiste. Le due potenze che hanno subito il più grande indebolimento con la fine del regime Assad – Russia e Iran – hanno partecipato alla frammentazione e all’instabilità del Paese. È stato Putin a definire le Primavere Arabe una replica delle Rivoluzioni colorate e i suoi bombardamenti in nome della lotta al jihadismo a partire dal 2015 ha causato migliaia di morti tra la popolazione civile. L’amicizia di Putin con Assad ha solo velato l’opportunismo del leader russo volto ad affermare e rafforzare la sua posizione nello scacchiere internazionale. Questo opportunismo viene oggi svelato nel momento in cui la Russia prova a trovare velocemente un accordo con il governo transitorio per assicurarsi le proprie basi logistiche militari in Siria e alcune indiscrezioni indicano che Assad era disposto a staccarsi dalla Russia e dall’Iran. Nell’attuale momento non esiste altro modo per rafforzare una posizione antimperialista e internazionalista che su basi politiche ed etiche forti volte a conquistare i cuori e le menti delle persone. Per la sinistra rivoluzionaria questo ha delle implicazioni concrete: non schierarsi con i resti del regime o con le forze locali, regionali e internazionali della controrivoluzione, bensì affermare il principio della solidarietà con le lotte dal basso per una Siria progressista e inclusiva e costruire connessioni politico-organizzative con le classi oppresse dell’intera regione.
Terzo. Oltre a riconoscere la centralità del progetto curdo, che va difeso non da ultimo poiché è capace di fungere da modello per la costruzione di una Siria democratica che vada oltre le divisioni settarie, esiste un altro attore di cui si sta parlando ben poco (e che merita maggiore approfondimento): il popolo siriano. La guerra civile e la repressione hanno di fatto impedito che negli ultimi anni si formasse un blocco sociale realmente progressista e indipendente. È però prevedibile che l’attuale situazione di instabilità politica ed economica, l’incapacità e la mancanza di volontà del governo di transizione di rispondere alle esigenze popolari – come già avvenuto sulla questione della partecipazione politica delle donne – nonché il ritorno di una parte dei rifugiati siriani saranno elementi capaci di scatenare nuove lotte sociali. La questione è quindi se emergeranno nuove organizzazioni in seno alla società siriana (organizzazioni che pongano al centro il potere popolare al di fuori delle strutture statali ora esistenti) in grado di rafforzarsi nell’attuale contesto o se la Siria scivolerà in nuovi conflitti violenti che mineranno, ancora una volta, la possibilità di un processo di democrazia radicale e favoriranno i piani imperialisti e regionali delle grandi potenze. Questa è la vera partita che si sta giocando in Siria oggi.
- Capitalismo clientelare (in inglese crony capitalism) definisce quel tipo di sviluppo capitalista che lega le opportunità di investimenti economici e accumulazione di ricchezza alla fedeltà al regime politico. Sul carattere clientelare e mafioso dell’economia e della politica siriana pre-2011, si veda Karry Alhayek, Crony Capitalism and Federalism in Syria’s Reconstruction: Interview with Joseph Daher, in Salon Syria, 21 novembre 2017. ↩︎
- Secondo i numeri iraniani, si parla di un supporto economico tra i 20 e 30 miliardi di dollari tra gli anni 2010 e 2019 per non far cadere il regime di Assad. ↩︎
- Map of Syrian Civil War: https://syria.liveuamap.com/ ↩︎
- Alberto Magnani, Mosca contatta HTS per mantenere le basi militari in Siria, in Il Sole 24 Ore, 14 dicembre 2024, p. 5. ↩︎
- Alberto Magnani, Erdoğan ha vinto la prima partita, ora la sfida è la stabilità, in Il Sole 24 Ore, 11 dicembre 2024, p. 6. ↩︎
- In quella fase esistevano diversi “governi paralleli” in Siria: quello ufficiale sotto la guida del presidente Assad; il Governo provvisorio siriano costituito prima in esilio, poi nelle aree siriane controllate dall’opposizione; il Governo di Salvezza Siriano di Idlib e nel nord-ovest della Siria; l’Amministrazione autonoma della Siria del Nord-Est a guida curda; zone controllate dallo Stato Islamico. ↩︎
- Giuliano Battiston, Pragmatici e nazionalisti, l’ultima torsione jihadista, in il manifesto, 11 dicembre 2024, p. 3. ↩︎
- Alberto Negri, Il potere è una scatola vuota per Al Julani, in il manifesto, 17 dicembre 2024, p. 3. Secondo Negri, le casse dello Stato siriano oggi contano 100 milioni di dollari, cioè solo 10 volte la somma che Netanyahu ha stanziato per intensificare gli insediamenti dei coloni israeliani nelle Alture del Golan dopo la caduta di Assad. ↩︎
- Se parliamo di movimento curdo intendiamo perlopiù quello legato alla tradizione del PKK in Turchia e alle organizzazioni siriane. Il Kurdistan iracheno ha avviato un processo di autonomia già nel 1991, guidato dai due potenti clan Barzani e Talabani, ed è supportato dagli Stati Uniti. Oltre a ospitare basi militari degli USA, il Kurdistan iracheno collabora con la Turchia per limitare le possibilità del PKK di utilizzare le zone di confine tra Turchia e Iraq per ritirarsi dagli attacchi repressivi dell’esercito turco. Infine, il governo curdo in Iraq mantiene ottimi rapporti con Israele che viene visto come esempio di costruzione di un proprio Stato. ↩︎