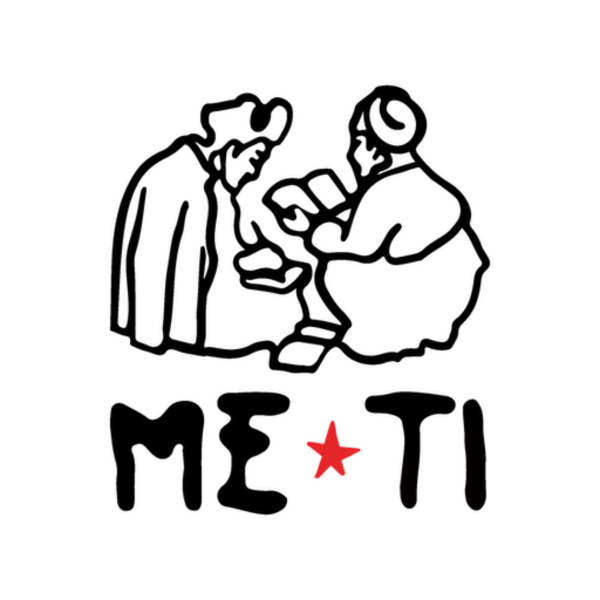Traduciamo dalla rivista francese Contretemps un articolo di Stathis Kouvélakis, filosofo e militante.
—
Cosa fare delle nostre esperienze, del nostro passato recente e più lontano, delle nostre lotte, speranze, fallimenti e vittorie? In questo denso testo, Stathis Kouvélakis non adotta un approccio malinconico. Al contrario, utilizza un’analisi ravvicinata per cogliere ciò che è accaduto sia in Francia negli anni Ottanta – in particolare durante la vittoria del movimento studentesco contro la legge Devaquet nel 1986 – sia durante la “primavera greca” – alla quale ha partecipato direttamente, lottando in particolare all’interno di Syriza – tra il 2010 e il 2015.
Queste riflessioni puntano sulla lucidità, senza disfattismo o fatalismo. E conducono a indicazioni strategiche per il nostro tempo, senza infingimenti.
Defatalizzare la sconfitta
Di un militante della sinistra radicale e dei comunisti della mia generazione, che aveva vent’anni nel bel mezzo del “grande incubo degli anni Ottanta” (François Cusset)1 e che ha iniziato il suo attivismo proprio alla fine degli anni Settanta, è giusto dire che è stato essenzialmente educato nelle e dalle sconfitte.
Tuttavia, questo processo non è stato né lineare né omogeneo. La temporalità politica della Grecia nei dieci, forse quindici, anni successivi alla caduta della dittatura dei colonnelli (1967-1974) differisce nettamente da quella della Francia o dell’Italia. In parole povere, gli anni Settanta sono stati un periodo di euforia e radicalizzazione a sinistra in ampi settori della società, soprattutto tra i giovani. Questa ondata si è attenuata nel decennio successivo, con l’arrivo dei socialisti greci al potere (ottobre 1981) e una certa normalizzazione, ma senza il senso di sconfitta che altrove ha sommerso tutto. Inoltre, la sinistra radicale – in grande maggioranza comunista – riuscì a mantenere posizioni significative in diversi settori sociali (movimenti giovanili studenteschi e liceali, sindacati) e anche a livello elettorale. Pur essendo politicamente una minoranza, godeva di un grande prestigio morale, frutto delle lunghe persecuzioni subite dai suoi militanti e del ruolo eminente che aveva svolto nella resistenza popolare al fascismo, all’imperialismo e al regime di emergenza introdotto durante la guerra civile, che durò fino alla caduta della dittatura. Lasciare la Grecia nel 1983 per venire in Francia e iniziare i miei studi è stato un vero e proprio shock per me, tanto che mi chiedo se, nonostante tutti gli anni trascorsi, non sia ancora attivo e nutra i miei pensieri e le mie azioni.
Quei terribili anni ’80, in particolare in Francia, sono stati indiscutibilmente quelli della grande crisi su tutti i fronti: la svolta neoliberista e i rinnegamenti della sinistra al potere, la disintegrazione del movimento operaio e la frammentazione delle classi popolari, il declino del Partito Comunista, l’unico partito di sinistra con autentiche radici operaie e popolari nella storia di questo Paese, il crollo senza precedenti del dibattito intellettuale a causa dell’egemonia del liberalismo della Guerra Fredda e la ritirata senza combattere (o quasi…) di tutto il pensiero critico, a partire dal marxismo, che era stato la spina dorsale del movimento, soprattutto in Francia, durante il “secolo breve” (1914-1989) di cui parla Eric Hobsbawm.2 In pochi anni, Parigi è passata dall’essere l’epicentro del radicalismo politico e culturale all’essere la “capitale della reazione intellettuale europea”, per citare un altro storico britannico, Perry Anderson3. Si parla spesso della “caduta del muro di Berlino” e della fine dell’URSS come delle date che hanno segnato la svolta, ma in realtà questi eventi, a cui si aggiunge la svolta capitalista della Cina, hanno solo suggellato un’evoluzione che era già largamente avviata dopo un buon decennio di controrivoluzione neoliberista su scala globale.
Tuttavia, c’è un altro modo di guardare a questo stesso periodo, che devo collegare anche a momenti della mia carriera politica. Perché anche durante i periodi di sconfitta, la lotta di classe continua! Ed è persino particolarmente feroce, perché le classi dominanti sconvolgono l’equilibrio sociale precedente e passano all’offensiva. Ma è anche, per le stesse ragioni, in parte “invisibilizzata”, perché è massicciamente rimossa dal discorso dominante, quello delle classi dominanti desiderose di vendetta (e dei loro ideologi), determinate a cancellare tutte le concessioni che sono state loro strappate nei decenni precedenti. C’è quindi un grande lavoro di ricostruzione da fare, e non si tratta di un lavoro “memoriale”, come quello che ha inondato i campi accademici e mediatici per molti anni, ma di un processo politico il cui obiettivo è quello di bucare il fitto silenzio che, ancor più delle distorsioni e dei pregiudizi di ogni tipo, circonda le lotte popolari di tutti i giorni, in particolare quelle dei lavoratori.
Mi sono modestamente cimentato in questo esercizio negli anni 2000, con una serie di testi raggruppati in una raccolta pubblicata nel 20074. L’obiettivo era quello di mostrare che tutto quel periodo è stato costellato da grandi lotte sociali che, ancora una volta, contrariamente a quanto alcuni credono, non si sono ridotte alla “resistenza”, anche se si trattava di lotte essenzialmente difensive. In altre parole, il mio obiettivo era quello di contrastare l’idea che l’unica via possibile fosse quella di impegnarsi in una sorta di atto esemplare, dal contenuto essenzialmente etico (o addirittura estetico), dando vita a pratiche frammentate, singolarità senza futuro e senza effetti sull’equilibrio generale del potere. Al contrario, ho voluto dimostrare che queste lotte avevano una posta in gioco reale, che hanno effettivamente avuto un impatto sul corso degli eventi e che tenerne conto è essenziale per comprendere il periodo.
Ritenevo, e ritengo tuttora, che intraprendere questo tipo di lavoro sia politicamente decisivo, perché ci permette di individuare ciò che è possibile in una determinata situazione, di valutare il più lucidamente possibile i fallimenti e i successi, insomma di rendere tangibile l’idea che, anche nei momenti di sconvolgimento, la storia non è scritta in anticipo e che, anche se non tutto è sempre possibile, ci sono sempre bivi e opportunità – troppo spesso mancate, è vero – per le forze di emancipazione popolare.
Il movimento studentesco del novembre-dicembre 1986
Per rendere più concreto quanto detto, prenderò due esempi dalla mia esperienza di attivista, relativi rispettivamente a situazioni in Francia e in Grecia, paesi in cui sono stato direttamente coinvolto nell’azione politica. Inizierò con il caso di una vittoria parziale ma significativa, il movimento studentesco del 1986 contro la legge Devaquet. Spesso lo ricordiamo ancora oggi perché il governo dell’epoca fu costretto a ritirare il suo progetto di legge – che fu il primo vero tentativo in Francia di introdurre tasse di selezione e di iscrizione all’università – e anche perché la manifestazione del 4 dicembre 1986, punto culminante del movimento, si concluse con una feroce repressione poliziesca che portò alla morte di Malik Oussekine.
Sebbene se ne parli raramente, gli effetti di questo movimento, a distanza di trentacinque anni, sono ancora presenti. Da un lato, i governi che si sono succeduti e che hanno tutti attuato politiche neoliberiste, non sono riusciti a mettere in discussione l’accesso libero e relativamente non selettivo all’università. Certo, una breccia è stata aperta con il “processo di Bologna”, deciso a livello di Unione Europea, e poi con la legge LRU sull'”autonomia universitaria”, tutte riforme che hanno messo l’istruzione superiore sul binario neoliberale. Macron ha raccolto la fiaccola di Devaquet, con l’introduzione del “Parcours sup” e delle esorbitanti tasse universitarie per gli studenti extracomunitari, primo passo verso la loro generalizzazione. Tuttavia, avendo insegnato per vent’anni in un’università britannica, posso dire che in Francia c’è ancora molta strada da fare prima di raggiungere il modello commercializzato e imprenditoriale dei Paesi anglosassoni.
Siamo riusciti a guadagnare tempo, tre o quattro decenni, l’equivalente di diverse generazioni che hanno beneficiato di una certa democratizzazione dell’accesso all’università, il che non è poco. D’altra parte, dopo la morte di Malik Oussekine, i governi hanno avuto paura di lasciare dei manifestanti a terra. Questo ha tracciato una sorta di linea rossa in termini di repressione da parte della polizia dei movimenti sociali e delle manifestazioni di piazza. Ancora una volta, è stato solo nel periodo recente, con la repressione del movimento contro la legge sul lavoro nel 2016 e l’apice raggiunto durante le mobilitazioni dei Gilets jaunes e la loro scia di feriti e mutilati, che questa linea è stata messa in discussione.
Guardando indietro a questo periodo, possiamo notare che, dopo il movimento studentesco del 1986, i movimenti sociali in Francia sono riusciti a ottenere alcuni successi parziali, il più significativo dei quali è stato il ritiro della riforma dei regimi speciali nel 1995, seguito nel 2006 dal ritiro del “Contrat première embauche” (CPE). Persino Macron, il più determinato neoliberista di tutti i presidenti fino ad oggi, è stato costretto a temporeggiare sulla riforma delle pensioni, e questo passo indietro non è stato dovuto solo alla pandemia di Covid. Senza la potentissima mobilitazione del dicembre 2019 e del gennaio 2020, la riforma sarebbe passata come una lettera alle Poste. Naturalmente, tutto questo non è bastato a fermare il neoliberismo, perché avrebbe richiesto un’alternativa politica che, come sappiamo, è mancata. Ma la Francia rimane un Paese in cui il modello neoliberista è stato fortemente contestato, e questo ha permesso di preservare meglio che altrove alcune “conquiste sociali” – preferisco il termine di Ambroise Croizat a quello di “diritti acquisiti”.
Tuttavia, se parlo del movimento del 1986, non è solo per la sua importanza, ma anche perché è stata la prima esperienza di mobilitazione su larga scala in cui sono stato coinvolto. Diventare protagonisti di un movimento di massa è certamente un’esperienza importante, che ci aiuta a capire il meccanismo che lo ha messo in moto. Per quanto posso ricordare, è così che l’ho vissuta. Il governo Chirac, appena eletto nelle elezioni legislative del marzo 1986, aveva preparato la sua riforma durante l’estate, come fanno di solito i governi per questo tipo di riforme antisociali. Quindi sapevamo già dall’inizio dell’anno accademico a che punto eravamo. All’epoca ero membro dell’Union des étudiants communistes (legata al PCF) e attivista sindacale nell’UNEF Solidarité étudiante, che in seguito si è fusa con l’UNEF indépendante et démocratique per formare l’attuale UNEF. Insieme ad altre organizzazioni sindacali e studentesche di sinistra, abbiamo iniziato a volantinare e informare gli studenti. A Nanterre, a partire da ottobre, abbiamo convocato un’assemblea dopo l’altra che, nonostante i nostri sforzi, non hanno avuto molto successo: eravamo tra i 100 e i 200, e anche nelle altre università, almeno nella regione di Parigi, le cose non andavano bene. Deluso dalla passività degli studenti, alla fine di novembre ho saltato un’assemblea. Il giorno dopo, un amico mi ha telefonato: “Ti sei perso davvero tutto, l’aula magna di Nanterre [con una capacità di 2.000 persone] era piena, abbiamo votato per lo sciopero e tutto il resto”. Qualcosa è scattato.
Perché è successo? Sartre parla del passaggio da uno stato di atomizzazione (che chiama serialità) a uno stato in cui si forma un gruppo, unito in un’azione comune5. Lo spiega attraverso due meccanismi. Il primo, essenzialmente reattivo, consiste nella consapevolezza che c’è una minaccia grave e imminente di fronte a noi – se non agiamo, ci colpirà direttamente. C’è stato un momento in cui la riforma Devaquet è diventata molto concreta: dall’anno prossimo la selezione, sia in base ai risultati sia in base ai soldi, arriverà all’università, e questo è qualcosa che non vogliamo. Alla fine, è sempre l’avversario a creare le condizioni perché l’azione collettiva prenda forma. Sono le classi dominanti a provocare le rivoluzioni, perché fraintendono la “lunga pazienza del popolo” di cui parla la storica della Rivoluzione francese Sophie Wahnich6 e pensano che sia sempre destinata a durare. È vero, in effetti, che ci vuole molto per farla finire.
Il secondo meccanismo che porta alla formazione di un gruppo è quello mimetico: inizialmente imitiamo il comportamento di qualcun altro, conosciamo qualcuno che va all’assemblea e lo seguiamo. Si è coinvolti in qualcosa di cui all’inizio non si è del tutto sicuri, ma si percepisce che è più grande di noi, che sta per diventare grande e che può avere un effetto. Poi, naturalmente, entrano in gioco altri processi più controllati: la discussione, l’accordo su obiettivi e mezzi d’azione condivisi, l’emergere di una forma di leadership e così via. Ma nulla può accadere se non si compie questo primo passo. Le grandi esplosioni possono sembrare spontanee, ma non lo sono mai del tutto: perché qualcosa scatti, deve esserci l’embrione di una risposta collettiva – in questo caso, il lavoro preparatorio che avevamo fatto. Per questo Sartre diceva che non esiste una spontaneità assoluta. Ogni situazione concreta è costituita da un misto di serialità e di gruppi, più o meno costituiti, più o meno sclerotizzati. Ma non c’è garanzia che ne esca qualcosa in termini di azione collettiva. Chiunque sia coinvolto in un attivismo a lungo termine lo sa bene: abbiamo questo tipo di sorprese miracolose e abbiamo anche molte delusioni perché molto spesso, nonostante la nostra perseveranza, le cose non funzionano.
Durante il movimento del 1986, il governo Chirac si è spaventato e si è ritirato, ma ci sono voluti l’omicidio di Malik Oussekine per mano del CRS e le immagini della brutalità della polizia il 5 e 6 dicembre perché ciò accadesse. In seguito, abbiamo iniziato a vedere scioperi nei servizi pubblici e nelle aziende, seguiti da un appello allo sciopero da parte delle confederazioni sindacali e dall’inizio di un collegamento con il movimento operaio. Improvvisamente l’atmosfera è cambiata, è riemerso lo spettro del 1968, che Chirac e i suoi consiglieri avevano vissuto, e la legge Devaquet è stata immediatamente ritirata per calmare le persone. La protesta sociale riemerse in seguito con gli scioperi dei ferrovieri e della RATP, del movimento degli infermieri e dei lavoratori di fabbriche come la Snecma. Queste agitazioni sociali ebbero un forte impatto sull’economia e contribuirono alla caduta della destra nel 1988, cosa che sarebbe stata difficile da immaginare due anni prima, tanta era stata la delusione del primo quinquennio della sinistra. Certo, furono Mitterrand e il Partito Socialista a tornare al potere, visto che non c’era nient’altro a portata di mano, ma la versione più brutale del neoliberismo, quella del “Thatcherismo alla francese”, si ritirò per un certo periodo. La ritirata del governo Villepin sul CPE [contrat première embauche, “contratto di primo impiego” – una forma contrattuale che precarizzava il rapporto di lavoro e che si sarebbe dovuta applicare solo a chi aveva meno di 26 anni – NdT], che ha seguito il doppio shock del referendum del 2005 sul CPE e della rivolta nelle periferie, ha confermato la persistenza della resistenza di ampi settori della società alle politiche del blocco borghese. È stato solo con Sarkozy che una “destra senza freni” ha ricominciato a presentarsi come tale, in gran parte come reazione autoritaria e razzista alla battuta d’arresto della ristrutturazione neoliberale che le lotte sociali erano riuscite a imporre.
Le lotte sociali hanno quindi un impatto reale, ma da sole non sono sufficienti a cambiare le coordinate di una situazione; per questo abbiamo bisogno di un’alternativa politica. Per emergere, questa alternativa deve essere alimentata dalle lotte e dall’esperienza collettiva, altrimenti rimarrà disincarnata e astratta, e non diventerà una forza reale. Quindi, se da un lato dobbiamo criticare quella che Daniel Bensaïd ha chiamato “illusione sociale”7, la fiducia nell’autosufficienza dei movimenti, dall’altro non dobbiamo ridurli a una semplice negazione, una sorta di “degagismo” generalizzato, come ha sostenuto in particolare Alain Badiou8. Perché la negazione stessa contiene un inizio, per quanto vago, di affermazione, da cui si dipana e che, a sua volta, può fungere da stimolo e da vettore per allargare l’orizzonte del possibile. Il rinnovamento di una politica emancipatrice veramente rivoluzionaria non può avvenire nel vuoto, ma richiede una costante interazione con l’esperienza viva delle lotte degli oppressi.
La primavera della Grecia in frantumi
Così non ho mai smesso di essere politicamente attivo nel quarto di secolo che ha seguito questo movimento. Piuttosto che ripercorrerlo, mi limiterò a un solo momento, quello che senza dubbio ha avuto il maggiore impatto su di me per il mio coinvolgimento personale, ma che mi sembra anche avere un significato più ampio. Si tratta dei cinque anni (2010-2015) della “primavera greca”, una sequenza di eccezionale densità e intensità, che si è conclusa con una cocente sconfitta quando il governo di Syriza si è arreso al diktat dell’Unione europea (UE) nel luglio 2015. Ero un membro di quel partito e ho persino fatto parte del suo comitato centrale tra il 2012 e il 2015. Ho quindi vissuto la sconfitta da una posizione di responsabilità, il che rende ancora più necessario spiegare e riflettere sul significato degli eventi, sia a se stessi che agli altri. Ciò solleva le inevitabili domande: perché le cose sono andate come sono andate? L’esito era inevitabile? Dove risiede la responsabilità?
Vorrei iniziare ricordando brevemente il contesto. Nella primavera del 2010, la Grecia ha dovuto affrontare una crisi legata alle dimensioni del suo debito pubblico e dei suoi deficit di bilancio, che l’hanno esclusa dai mercati finanziari. Poiché non era possibile che i suoi governi si confrontassero con i mercati, l’unica soluzione era chiedere “aiuto” ai “partner” dell’UE, che hanno concesso prestiti per rifinanziare il debito, ma a condizioni draconiane, formalizzate nei mostruosi memorandum adottati frettolosamente dal Parlamento greco nel maggio 2010 per il primo e nel febbraio 2012 per il secondo. Al Paese è stata imposta una vera e propria “terapia d’urto”, che solo i Paesi sovraindebitati del Sud e dell’ex blocco sovietico hanno mai sperimentato: una miscela esplosiva di austerità brutale, deregolamentazione di ogni tipo, privatizzazioni e messa sotto sorveglianza della politica economica e sociale per gli anni, se non i decenni, a venire.
Immediatamente sono scoppiate imponenti mobilitazioni popolari, le più grandi che il Paese abbia mai visto dagli anni ’70 – in particolare il movimento Occupy the Squares della primavera 2011 e non meno di 34 scioperi generali di 48 ore distribuiti nei primi due anni dei piani di austerità. Queste mobilitazioni si scontrano con un muro di rifiuto e repressione, ma scardinano il sistema politico consolidato, basato sull’alternanza di potere tra la destra e il PASOK, un partito socialista convertito al neoliberismo. Un partito di sinistra radicale, Syriza, il cui risultato elettorale non aveva mai superato il 5%, è entrato nella breccia, impegnandosi a rompere la gabbia di ferro dell’austerità e dell’amministrazione fiduciaria. Nelle due elezioni della primavera 2012, Syriza ha ottenuto prima il 17% e poi il 27%, a soli due punti dalla destra e molto più avanti del PASOK, crollato dal 44% del 2009 al 12%. Lo slancio era irresistibile e, infatti, meno di tre anni dopo, Syriza ha vinto le elezioni di gennaio, ha raggiunto (per un seggio) la maggioranza in Parlamento e ha formato un governo in alleanza con un piccolo partito sovranista di destra. La speranza cresceva, ben oltre i confini della Grecia. Syriza è diventata il punto di riferimento per la sinistra antiliberale europea e internazionale.
La reazione della Troika non si è fatta attendere. Il 4 febbraio, la BCE estrae la sua arma monetaria e taglia il principale accesso alla liquidità delle banche greche. Il 20 febbraio, il governo di Syriza firma un accordo umiliante in una riunione dell’Eurogruppo, che gli impedisce di attuare il suo programma. Le umiliazioni continuano durante interminabili sessioni di pseudo-negoziati, mentre la situazione finanziaria del Paese si deteriora visibilmente. A giugno è stato lanciato un ultimatum, con un nuovo piano di austerità presentato dalla Commissione europea. Alexis Tsipras, primo ministro e leader di Syriza, ha giocato la sua ultima carta, chiedendo un referendum, che si è tenuto il 5 giugno 2015 e che ha portato a un massiccio “no” (61,3%) al piano di austerità. Gli elettori hanno sfidato minacce di ogni tipo e il ricatto esercitato dal blocco economico a cui il Paese è di fatto sottoposto a seguito del blocco ormai totale dell’approvvigionamento di contante. Tuttavia, otto giorni dopo questa giornata di tripudio popolare, Tsipras ha firmato un terzo memorandum con l’UE, molto peggiore del piano respinto dagli elettori, e che ha completato la “terapia d’urto” dei due memorandum firmati dai governi precedenti. La primavera greca si è definitivamente spezzata.
Come possiamo spiegare questa capitolazione? In poche parole, la primavera greca è stata sconfitta perché non ha saputo e, a livello di leadership politica, non ha voluto, difendersi9. Qui ci sono due punti chiave. Il primo è che il confronto con l’Unione Europea e le sue istituzioni doveva essere preso sul serio. Lo strangolamento finanziario della Grecia, attraverso l’offensiva contro il suo sistema bancario lanciata dalla BCE pochi giorni dopo la formazione del governo Syriza, era perfettamente prevedibile. Se non si fosse attivato un piano B in risposta, era certo che, dati i rapporti di forza, la capitolazione sarebbe diventata inevitabile. Tale piano, che inevitabilmente doveva includere l’uscita dall’euro e il default sul debito, non poteva essere improvvisato. Era chiaro che doveva essere elaborato con cura e, soprattutto, spiegato ampiamente all’opinione pubblica.
Invece, Tsipras e la maggioranza della leadership di Syriza hanno fatto credere ai cittadini che un negoziato ostinato avrebbe sbloccato la situazione e attuato alcuni degli impegni presi. Si trattava del famoso “compromesso onorevole”, un obiettivo che non è mai stato assunto correttamente, poiché significava abbandonare (o rimandare all’infinito) il programma su cui Syriza era stata eletta, ma che le persone vicine a Tsipras hanno formulato quando si sono rivolte a platee mirate, in particolare alla comunità imprenditoriale e ai rappresentanti dei creditori. Al centro di questa illusione sulla possibilità di un’uscita negoziata c’era la convinzione – condivisa dalla maggioranza di Syriza e da quasi tutta la sinistra europea, compresa la sua ala radicale – che l’Unione Europea sia riformabile dall’interno e che, in ogni caso, trattandosi di un processo irreversibile, qualsiasi idea di rottura sia inevitabilmente nazionalista e reazionaria. Questo “europeismo di sinistra” è una delle pietre d’inciampo contro cui si schianta ogni seria idea di alternativa di sinistra, e purtroppo le cose non sembrano essere cambiate molto da allora.
Il secondo punto era che un piano di fuga, spesso chiamato “piano B”, doveva basarsi sulla mobilitazione popolare e, a sua volta, stimolarla. Non c’era nulla di illusorio in questa prospettiva perché, come ho detto prima, il periodo precedente alla vittoria di Syriza alle urne aveva visto una massiccia mobilitazione popolare. La possibilità di un movimento di massa era quindi molto concreta, e ciò è stato confermato dalle manifestazioni spontanee scoppiate all’inizio di febbraio all’annuncio della decisione della BCE. In Grecia era possibile avere ciò che era mancato nel 1981 in Francia, quando la sinistra aveva vinto controcorrente, in un momento in cui le sconfitte del movimento operaio erano già ampiamente avvenute. Di conseguenza, la vittoria di Mitterrand non aveva suscitato la grande mobilitazione che alcuni avevano sperato, guardando al giugno 1936 e al Fronte Popolare.
Questa ipotesi di congiunzione tra la mobilitazione popolare e la prospettiva concreta di una rottura con i dettami dell’Unione Europea è stata convalidata su larga scala durante la sequenza che ha portato al referendum del 5 giugno 2015. Quando Tsipras lo ha annunciato, pensando senza dubbio di perdere e di legittimare così la capitolazione che aveva già deciso di fare, ha creato uno slancio che è andato completamente oltre le sue intenzioni. L’appello ha dato vita a un’ondata popolare che si è riflessa in enormi manifestazioni e nella portata della vittoria del “no”, nonostante le minacce quotidiane dei governi europei, nonostante il blocco economico, nonostante l’impossibilità di prelevare denaro dai bancomat. I greci hanno detto “no”, ma i loro leader avevano già rinunciato, e questa rinuncia ha completamente disorganizzato il campo popolare e lo ha portato alla sconfitta.
Le conseguenze di quella sconfitta sono ancora presenti: è da quel momento che la sinistra ha iniziato a declinare in Europa, nonostante alcune esplosioni di energia, come gli effimeri successi di Podemos, i cui leader si sono affrettati a seguire le orme di Syriza, il 20% di Mélenchon nel 2017, e il “momento Corbyn” nel Labour britannico. Un momento che, per inciso, è crollato sulla questione della Brexit, ovvero sull’incapacità della sinistra di tenere una linea di rottura con l’UE, che di conseguenza ha abbandonato questa opzione, maggioritaria nell’elettorato popolare britannico, alla destra nazionalista e atlantista, che si è affrettata a egemonizzarla e a darle una direzione in linea con i propri interessi. Stiamo quindi assistendo al fatto che, dopo la fine della Primavera greca, la rabbia popolare in Europa viene sempre più catturata dalle forze della destra radicale e dell’estrema destra. Perché la gente dovrebbe riporre la propria fiducia in forze che si suppone siano diverse dalle élite tradizionali e, in particolare, dai socialdemocratici che si sono convertiti al neoliberismo ma che, una volta al potere, non fanno nulla di molto diverso dai loro predecessori? Il test su larga scala che è stato il disastro greco ci costringe ad affrontare questo fatto.
Le ragioni della sconfitta
Ma dobbiamo esaminare più da vicino le ragioni di questa capitolazione. Ho citato l’assenza di un piano di autodifesa, il rifiuto di affidarsi alla mobilitazione popolare quando si è al governo e le illusioni ideologiche sul possibile spazio di manovra all’interno dell’UE. Ma, in un certo senso, non ho fatto altro che descrivere il problema. Perché non si è agito diversamente quando il disastro era all’orizzonte? Perché non si è cambiata rotta nonostante una consistente ma crescente ala minoritaria all’interno di Syriza stesse lanciando l’allarme e proponendo le grandi linee di un simile piano di autodifesa? Da parte mia, ho poca fiducia nelle visioni psicologizzanti che riducono tutto al carattere (o piuttosto alla mancanza di carattere) di alcune persone, o che vorrebbero farci credere che tutto fosse scontato, che i leader di Syriza intendessero fin dall’inizio firmare un terzo Memorandum e che abbiano semplicemente mentito per arrivare al potere e completare il lavoro sporco. Certo, ci sono elementi provati in tutto questo: i leader, guidati da Tsipras, hanno effettivamente dimostrato una mancanza di coraggio, scegliendo di farsi strada tra le difficoltà e ricorrendo a doppi sensi e rassicurazioni che sapevano essere infondate. Ma questo non esaurisce la questione.
Non ho una spiegazione definitiva, che richiederebbe l’accesso a fonti che al momento non sono disponibili, ma, sulla base della mia esperienza personale, di ciò che ho letto e degli scambi avuti con altri compagni, il seguente scenario mi sembra il più probabile. Il momento in cui si è verificato un cambiamento decisivo, anche se non ancora irrevocabile, mi sembra sia stato la primavera del 2012. Nelle elezioni parlamentari di maggio e giugno, Syriza compie un balzo in avanti straordinario: fino a quel momento un piccolo partito che aveva ottenuto il 4% o il 5% dei voti, diventa la principale forza di opposizione e manca di poco il primo posto. Le ondate di mobilitazione popolare erano ancora molto fresche e il partito stesso non aveva ancora iniziato a normalizzarsi al suo interno e parlava ancora in termini di una rottura piuttosto decisa con il passato. All’inizio di giugno, pochi giorni prima delle elezioni, Tsipras ha dichiarato per l’ultima volta che anche la questione dell’euro, cioè l’uscita dalla moneta unica e quindi la rottura effettiva con il quadro esistente, non era un tabù per lui – il che corrispondeva alla posizione ufficiale del partito. Tra le elezioni di maggio e giugno 2012, un’ondata di panico ha attraversato l’Europa. Merkel, Hollande e gli altri capi di governo dell’UE lanciavano appelli quotidiani agli elettori greci affinché non eleggessero persone “irresponsabili” che avrebbero condotto il Paese nel caos. Le classi dirigenti e il loro personale politico a livello europeo hanno visto in questa situazione una minaccia reale.
Come si è sentita la leadership di Syriza in questa situazione? Per loro era il momento della verità, il momento in cui si dovevano fare delle scelte che avrebbero influenzato il futuro. Sono convinto che la possibilità di un confronto reale con le forze dominanti, sia all’interno che a livello europeo, abbia provocato una reazione di paura. Perché una cosa è dire qualcosa di radicale quando si è nella posizione – in un certo senso comoda – di una forza minoritaria, e un’altra è affrontare la possibilità di metterlo in pratica.
Un episodio, che ha ricevuto relativamente pochi commenti, è di particolare interesse per me. Nell’estate del 2012, subito dopo il suo fiammeggiante successo alle urne, Tsipras è scomparso dalla scena pubblica per diverse settimane: si supponeva che fosse oberato di lavoro e avesse bisogno di riposo. Quando è riapparso in autunno, è stato per inviare “segnali di moderazione”, come si suol dire, ai potenti a livello europeo e internazionale. Quando parlava loro durante i viaggi all’estero e quando si rivolgeva agli organismi paragovernativi o alle istituzioni internazionali, era per dire qualcosa del tipo: “Guardate, non siamo così cattivi o così radicali come sembriamo. Meritiamo di essere premiati per aver acquisito questo senso di responsabilità”.
Era una melodia familiare per chiunque avesse in mente la sconfitta dei governi di sinistra in altri Paesi europei. Da quel momento in poi, molti di noi di Syriza si sono resi conto che Tsipras stava preparando qualcosa di molto simile alla svolta delle sinistre francese e italiana degli anni ’80 e ’90. Solo che alla fine non ha attuato una “austerità” nello stile dei governi Mauroy-Fabius degli anni ’80, ma un piano di sanguinosa austerità e di messa all’asta del Paese, rispetto al quale persino le politiche di Macron sembrano relativamente moderate.
Ma facciamo un passo avanti in questo ragionamento: perché la leadership di Syriza si è spaventata? A questo punto dobbiamo guardare più da vicino di cosa era fatta Syriza, e in particolare la sua leadership. La persona di Tsipras creava un’illusione agli occhi del mondo esterno, perché all’epoca era l’unico giovane nel nucleo della leadership, ma allo stesso tempo stava diventando sempre più centrale. Appariva quindi come un uomo nuovo, rilassato, libero dal passato della sinistra tradizionale. Ma in realtà anche lui, nonostante la giovane età, aveva mosso i primi passi da militante nei primissimi anni ’90 nelle file del KNE, l’organizzazione giovanile del PC greco ortodosso. Dietro di lui si trova la leadership di Syriza, composta da quadri relativamente anziani (e in maggioranza uomini), la maggior parte dei quali proviene da vari strati che si sono separati dal Partito Comunista Greco. Si tratta di persone segnate dalla sconfitta della sinistra comunista nel “ventesimo secolo breve” e che, per la maggior parte, l’hanno interiorizzata. Non si sono schierati a favore dell’ordine esistente, come i social-liberali, ma non credevano davvero che le cose potessero cambiare radicalmente, che un altro ordine fosse possibile, o addirittura a portata di mano, e che quindi fosse necessario un grande confronto per raggiungerlo. Non vedevano questa crisi parossistica come una rara opportunità nella storia per cambiare tutto, semplicemente non era il loro modo di pensare. E se non la si pensa così, non c’è modo di tenere testa a personaggi come Merkel, Schäuble, Draghi e gli altri, perché, lasciata a se stessa, la logica spietata che scaturisce dall’equilibrio di potere esistente alla fine vince sempre.
Vorrei offrire una testimonianza personale su questo punto. Ho avuto un solo incontro diretto con Tsipras, nel maggio 2012. Gli ho fatto da interprete quando è venuto a Parigi, in particolare per una conferenza stampa con Pierre Laurent e Jean-Luc Mélenchon all’Assemblea nazionale.
Dopo questa memorabile conferenza stampa, Tsipras ha fatto il giro dei media e abbiamo fatto lunghe corse in taxi in una Parigi molto congestionata. La conversazione è stata rilassata, piuttosto calorosa, ma è arrivato ad un certo punto il momento in cui abbiamo toccato i nostri disaccordi sul piano B. Mi ha detto: “Ma perché hai questa idea che dovremo inevitabilmente rompere con l’euro? C’è qualcosa che non capisco nella tua logica [quella dell’ala sinistra di Syriza]”. E io gli ho risposto: “Ascolta, penso che a un certo punto gli altri non ti lasceranno altra scelta. Cercheranno di spezzarti, di bloccarti con ogni mezzo necessario e l’unica risposta possibile è proprio questa“. In quel momento rimasi perplesso dalla sua risposta. Ammetto che non mi aspettavo un commento del genere e lo ricorderò sempre. In modo del tutto spontaneo, cosa estremamente rara per un leader politico, si rivolse a me e disse: “Ma perché dovrebbero farlo? Per quale motivo?” Quindi era una persona che non prendeva sul serio non solo la lotta di classe ma anche, molto semplicemente, il realismo di base che è insito nel conflitto politico e sociale e di cui i politici borghesi sono perfettamente consapevoli. Ecco dove risiede il seme della sconfitta, in questa asimmetria di posizioni e nella cecità che essa rivela dal lato dei deboli.
Credo che quando è diventato Primo Ministro, Tsipras non volesse capitolare e subire l’umiliazione della notte tra il 13 e il 14 luglio 2015. Pensava di cavarsela con un “compromesso onorevole” e di poter continuare le piccole manovre tattiche che avevano funzionato così bene per lui. Non capiva, perché non voleva e, in un certo senso, non poteva capire, che di fronte a sé aveva avversari letteralmente pronti a tutto, decisi a schiacciarlo per farne un esempio, per dimostrare che nessun’altra politica era possibile all’interno dell’Unione Europea. Sono riusciti anche a superare questo obiettivo, poiché non solo lo hanno spinto a capitolare, ma lo hanno addirittura trasformato in un docile strumento per attuare i loro diktat in nome del “mi dispiace, ma non c’era altra scelta”.
Quali lezioni per oggi?
A mio avviso, la lezione del disastro greco sta in questa proposizione: qualsiasi forza politica di sinistra che sostenga di attuare una politica di rottura con il neoliberismo e non spieghi perché e come non farebbe come Syriza e Tsipras nel 2015 non merita un minuto di attenzione. Facciamo un esempio concreto: prendiamo il programma della France Insoumise, L’Avenir en commun. Non si tratta di una proposta marginale, ma di un programma approvato nel 2017 da quasi il 20% dell’elettorato e la cui essenza è stata ripresa da Mélenchon nella sua campagna per il 2022 – con una (nota) eccezione, su cui tornerò tra poco. Se non pensate che, per realizzare questo programma, solo questo programma e non di più, sia inevitabile un altissimo livello di confronto con le classi dirigenti francesi ed europee, allora non meritate di essere presi sul serio quando dite che lo attuerete “comunque vada”. Prendere sul serio questo confronto significa prepararsi, essere consapevoli che un certo tipo di misura deve essere attuata perché l’avversario reagirà in modo molto forte. Il vero potere in Francia non è all’Eliseo o a Matignon, ma è il potere economico, il potere delle grandi imprese, delle grandi banche, della finanza e il potere ai vertici dell’apparato statale – gli alti funzionari di Bercy hanno molto più potere del ministro delle Finanze. Per non parlare, naturalmente, dell’apparato di repressione, dell’esercito e della polizia, che sono i garanti ultimi dell’ordine esistente e che hanno svolto un ruolo di primo piano nella transizione verso l’attuale regime della Quinta Repubblica.
A ciò si aggiunge, naturalmente, l’enorme pressione internazionale che sarà inevitabilmente esercitata. La Francia non è un’isola, né la potenza che sostiene di essere. A questo proposito, oltre alla borghesia francese, i primi a salire sul fronte saranno senza dubbio i “mercati internazionali” e le istituzioni europee in quanto espressione concentrata delle classi dirigenti del continente. In particolare, hanno a disposizione un’arma formidabile, la moneta, che è nelle mani di un’istituzione, la BCE, che abbiamo visto come ha agito nel caso della Grecia – in precedenza aveva minacciato di fare lo stesso con l’Irlanda. Naturalmente, non bisogna trascurare i numerosi vincoli imposti dai trattati europei e dai loro organi di controllo, anche se gli strumenti pratici di sanzione sono più limitati. Questo quadro, una vera e propria “gabbia di ferro”, rende intangibili le politiche neoliberiste e, a causa della regola dell’unanimità richiesta per modificare i trattati, è concepito fin dall’inizio per essere irriformabile. Temporaneamente allentato per gestire la pandemia, non c’è dubbio che sarà riattivato non appena la pandemia non sarà più all’ordine del giorno, e in ogni caso sarà riattivato se il quadro neoliberale in quanto tale sarà messo in discussione in un qualsiasi Stato membro.
Non ha senso cercare di aggirare questo dato di fatto e pretendere, come implica il programma 2022 di Mélenchon, che si possa uscire selettivamente dai vincoli dei trattati e negoziare il resto senza impegnarsi in un vero confronto. Escludere in anticipo l’idea di uscire dall’euro, che è una differenza importante rispetto alla versione precedente del programma, significa accettare in anticipo di muoversi all’interno del quadro stabilito dalla BCE. Se siamo seriamente intenzionati a rompere con il quadro esistente, il piano B rimane inevitabile. Di fatto, è l’unico piano valido, anche se, da un punto di vista tattico, l’idea di un doppio piano A/piano B presenta alcuni vantaggi. L’arretramento del candidato Mélenchon su questi temi non è di buon auspicio, né per la France Insoumise né per la sinistra francese ed europea in generale.
Ma torniamo alla questione del confronto nel suo complesso. Di fronte all’enorme forza dei nostri avversari, qual è la forza essenziale che abbiamo dalla nostra parte, al di là delle necessarie armi programmatiche? La mobilitazione popolare. La conquista della maggioranza alle elezioni è certamente un passo essenziale – e Syriza avrà almeno dimostrato che non è insormontabile per la sinistra a certe condizioni – ma non è sufficiente. Contrariamente a quanto sembrano credere i fautori del “populismo di sinistra”, France Insoumise o, prima di loro, Podemos, non potremo affrontare la situazione con un movimento ridotto a una mera macchina elettorale (per giunta per una sola elezione, quella presidenziale). Abbiamo bisogno di un’organizzazione degna di questo nome, con radici reali a livello locale e nazionale, con una presenza nei quartieri popolari, dove vivono e lavorano gli uomini e le donne delle classi sfruttate e dominate. Abbiamo bisogno di legami solidi con il movimento sindacale, con il movimento sociale, con le forme di associazione e di partecipazione diretta… È necessario costruire un’intera rete se vogliamo poter contare sulla mobilitazione popolare. Non mi sembra che si tratti di credere aprioristicamente nell’intangibilità della “forma partito”, o nel ruolo delle “avanguardie”, ma di un elementare realismo politico, almeno equivalente a quello dell’avversario di classe.
L’organizzazione è quindi un concentrato di politica, ma non è nemmeno la totalità della politica. La politica richiede un orientamento che ci permetta di intervenire nella situazione immediata: qualcosa come un programma di transizione, con misure immediatamente applicabili che avviino un processo di rottura che modifichi l’equilibrio delle forze, apra possibilità di mobilitazione popolare e ci permetta di andare oltre. Ammettiamo, in via provvisoria, che in questo senso un programma come Il Futuro in Comune [il programma de LFI – NdT] o, nel 2015, il cosiddetto “programma di Salonicco” di Syriza svolga, o sia stato in grado di svolgere, questa funzione. Ma non possiamo fermarci qui: abbiamo bisogno di un orizzonte più a lungo termine. Diciamo più precisamente che questo orizzonte di lungo periodo si rivela in realtà una condizione per elaborare un programma di transizione coerente e, soprattutto, per costruire i mezzi per attuarlo: l’organizzazione e la messa in moto delle forze popolari. Non si tratta di consegnare un piano “chiavi in mano” per una società ideale, ma piuttosto le grandi linee di un progetto alimentato dall’esperienza storica e dai problemi concreti delle classi dominate, che renda credibile l’idea di un “ordine nuovo”, per usare lo slogan di Gramsci e dei suoi compagni di Torino.
È qui che parole come “socialismo” ed “ecosocialismo” sono importanti. Per iniziare a mettere in discussione le fondamenta dell’ordine attuale, bisogna dargli un nome e dire che è il capitalismo che va affrontato, passando per un controllo sociale dei principali meccanismi economici, che includa anche la dimensione di una transizione ecologica al servizio delle classi lavoratrici (e non di entità indifferenziate come “il pianeta” o “gli esseri viventi”). La nozione di “pianificazione ecologica”, con una forte componente partecipativa e la delocalizzazione delle attività produttive, apre una strada fruttuosa in questa direzione10. E poi c’è la strategia che collega questi elementi e dà loro una reale coerenza. Daniel Bensaïd ha parlato di “eclissi della ragione strategica” come dell’epicentro, insieme sintomo e causa, della crisi della sinistra anticapitalista, dello stato di impotenza in cui si trova dalla sconfitta del comunismo del XX secolo.
Da questo punto di vista, l’America Latina ha molto da insegnarci. A mio avviso, l’esperienza più avanzata rimane quella di Allende, del Cile di Unità Popolare. Non voglio assolutamente sottovalutare l’importanza di ciò che è successo dopo, delle esperienze della Bolivia, del Venezuela e, più in generale, dei movimenti sociali e dei governi progressisti latinoamericani degli anni 2000 e 2010, o di ciò che sta accadendo ora, in particolare in Cile. Ma Unità Popolare è stata un’altra cosa, è andata oltre. È stato un processo veramente rivoluzionario, emerso in condizioni che hanno qualcosa in comune con le nostre, molto più che, ad esempio, le rivoluzioni cinese o cubana o la rivoluzione dell’ottobre 1917. A volte è stata definita una “via democratica al socialismo”, nel senso che si basava sull’articolazione tra un movimento operaio e popolare in fase ascendente e una coalizione di forze della sinistra politica che era riuscita a conquistare posizioni all’interno dello Stato (in particolare la presidenza) attraverso il processo elettorale – pur essendo priva di una maggioranza in Parlamento, il che rappresentava ovviamente un grosso problema. Il punto principale, tuttavia, è che questo nascente processo rivoluzionario non è stato in grado di difendersi dalla feroce controffensiva degli Stati Uniti, dei suoi alleati e della borghesia cilena, che hanno fatto di tutto per soffocarlo, riuscendoci.
C’è un certo narcisismo, tipico di quella che si potrebbe chiamare “ideologia francese” e diffuso anche a sinistra, che consiste nel dire che la Francia è eccezionale e che quello che è successo in Cile con Allende o, in modo meno tragico ma comunque devastante, in Grecia con Tsipras, non potrebbe accadere qui. È vero che la Francia, come Paese, pesa più della piccola e molto indebolita Grecia del 2010-2012 e che gli Stati Uniti e le altre potenze capitalistiche non hanno le stesse leve di pressione nei suoi confronti. Tuttavia, da questo punto di vista, la differenza è minore di quanto si possa pensare: l’arma delle sanzioni economiche, sempre più utilizzata contro i Paesi ritenuti recalcitranti all’attuale ordine mondiale, ancora dominato dall’Impero statunitense, è formidabile. Tanto più formidabile nel contesto di economie fortemente estroverse come quelle plasmate dalla globalizzazione capitalista, e quella della Francia in particolare.
L’altro aspetto della questione è che la Francia ha una classe dirigente molto più potente e navigata della decadente classe dirigente greca, che ha sempre fatto affidamento sui suoi patroni e protettori stranieri per prevalere sul proprio popolo. La borghesia greca non avrebbe mai potuto vincere la guerra civile [1944-1949] senza il sostegno dell’imperialismo britannico e statunitense – il napalm fu usato per la prima volta contro i sostenitori dell’Esercito Democratico [formato dal Partito Comunista Greco]! Ma in Francia, nel maggio 1871, la classe dominante non esitò a mettere a ferro e fuoco Parigi e a massacrare la popolazione a decine di migliaia, perché la Comune rappresentava una minaccia reale all’ordine sociale. Né ha esitato a stringere un patto con il nazismo perché preferiva Hitler al Fronte Popolare. Nel maggio del ’68, de Gaulle, intuendo che la situazione stava sfuggendo di mano, si recò a Baden-Baden con le truppe di Massu per calmare la situazione in Francia. Anche di recente, sebbene siamo ben lontani da una situazione di insurrezione popolare, abbiamo visto un certo numero di militari, e non solo in pensione, firmare tribune che invocano la guerra civile. Abbiamo anche sentito un filosofo ed ex ministro dell’Istruzione invitare la polizia a usare le armi contro i manifestanti. Una dichiarazione che illustra perfettamente il continuo “imbestialimento” della borghesia francese! Se questa classe si sente minacciata, non c’è dubbio che farà di tutto per sottomettere un popolo che sa essere indisciplinato e incline alla rivolta.
Una strategia di trasformazione radicale della società non può non tenere conto della dimensione della violenza insita in qualsiasi impresa di questo tipo. Se si differenzia dalla via insurrezionale, la “via democratica” al socialismo non può in alcun modo essere equiparata a una via pacifica o a un’azione non violenta, perché la democrazia stessa, e la necessità di difenderla quando è minacciata dalla ribellione delle forze reazionarie, non esclude affatto l’uso della violenza. Un governo popolare, basato su una maggioranza nelle urne, non può rinunciare al diritto di difendersi “con ogni mezzo necessario”.
Tuttavia, l’esperienza storica ci dice anche dei rischi di deriva autoritaria che uno stato di eccezione comporta, anche quando è istituito da rivoluzionari sinceri. Occorre quindi creare le condizioni politiche per ridurne al minimo la necessità e la durata e ripensare le forme che assumono, subordinandole il più possibile al controllo popolare e a un quadro giuridico. Senza escludere l’uso della forza, la priorità costante data alla lotta di massa e alla costruzione dell’egemonia di un blocco maggioritario di subalterni che condivida tale strategia. Questo è l’unico modo per restringere il campo d’azione delle forze che si oppongono al cambiamento e per allargare le crepe nel nucleo stesso dello Stato, rendendone più facile lo smantellamento.
Ma torniamo al qui e ora. Perché pensare all’azione politica significa prendere le cose come sono, non come vorremmo che fossero, ma per trasformarle, non per sottomettervisi. Oggi, in Francia, le cose stanno così: negli ultimi anni ci sono state grandi lotte sociali, anche se nessuna di esse ha avuto successo. Inoltre, tutti i tentativi di costruire uno strumento politico per una sinistra radicale sono definitivamente falliti o hanno mostrato i loro limiti, ormai evidenti. Occorre quindi iniziare a costruire un’organizzazione e una convergenza più durature di questi movimenti sociali, una convergenza che non è spontanea e che può essere solo il frutto di un paziente lavoro. E questo fronte sociale deve interagire con un fronte politico; sono queste le due gambe su cui si basa una strategia di “guerra di posizione”, suscettibile di trasformarsi in una “guerra di movimento” se i termini e i tempi del confronto lo richiedono.
Per raggiungere questo obiettivo, per intensificare il livello della lotta di classe, abbiamo bisogno di una tattica in grado di ottenere successi parziali, un prerequisito per passare da una posizione di ritiro difensivo, come avviene attualmente, a una controffensiva. Tale tattica deve quindi dimostrare la sua capacità di cambiare i rapporti di forza nelle istituzioni. Le illusioni anarchiche devono essere combattute, anche se sono, in una certa misura, comprensibili dopo tutte le delusioni e i fallimenti politici che abbiamo vissuto. L’azione politica va ben oltre il terreno elettorale, ma le elezioni non sono un terreno da lasciare all’avversario. Certo, vincerle non è sufficiente per prendere effettivamente il controllo delle istituzioni statali, ma nei Paesi con un sistema parlamentare e una “società civile” ben consolidata, un tale risultato è un passo ineludibile. E purtroppo, in un certo senso, non possiamo perdere l’interesse per lo Stato – il nucleo duro dello Stato, non i servizi pubblici o i livelli amministrativi inferiori, che sono più facilmente trasformabili – perché lo Stato non perderà mai l’interesse per noi – ce lo troveremo sempre di fronte, contro di noi.
Quando nel 2010 è iniziato il grande sconvolgimento in Grecia, mi sono detto: “Ok, ora devo mettere da parte tutto il resto e concentrare le mie energie su questo, perché questa sarà la battaglia politica della mia vita, della mia generazione“. È finita con un fallimento, ma dovevo farlo e non me ne pento nemmeno per un momento. Non è nulla di molto originale, ma sono una di quelle persone che credono che la bellezza del mondo si riveli nella lotta per cambiarlo. Non abbiamo acque tranquille davanti a noi. Anche in questo caso, pur non essendo nulla di nuovo, dobbiamo continuare a scommettere sul fatto che, tra i più giovani, ci sono energie disponibili a condurre le lotte che possono permetterci di uscire dall’impasse. In questo senso, dobbiamo trasmettere la nostra esperienza passata, che comprende anche un patrimonio teorico. Sta a noi, alla vecchia generazione, trasmetterlo. Non farlo significa condannarsi all’impotenza, rassegnarsi al mortificante Zeitgeist dominante, un misto di cinismo, disperazione e malinconica autoindulgenza. Ma se vogliamo perpetuare l’esperienza del passato come qualcosa di diverso da un oggetto da museo, spoliticizzato e depoliticizzante, dobbiamo fertilizzarlo, illuminarlo alla luce del presente, metterlo in relazione con le esperienze attuali, e questo è un compito collettivo e transgenerazionale. E certamente ci terrà occupati per gli anni a venire.
Note
- François Cusset, La décennie. Le grand cauchemar des années 1980, Paris, La Découverte, 2006. ↩︎
- Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991, UK, Michael Joseph, 1994. ↩︎
- Perry Anderson, In The Tracks of Historical Materialism, Londres, Verso, 1983, p. 32. ↩︎
- Stathis Kouvélakis, La France en révolte. Luttes sociales et cycles politiques, Paris, Textuel, 2007. ↩︎
- Su questa questione rimando al mio testo «Sérialité, actualité, événement. Notes sur la Critique de la raison dialectique», in Stathis Kouvélakis, Vincent Charbonnier (dir), Sartre, Lukacs, Althusser. Des marxistes en philosophie, Paris, PUF, 2005, p. 47-61. ↩︎
- Sophie Wahnich, La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Paris, Payot, 2008. ↩︎
- Daniel Bensaïd, «Sur le retour de la question politico-stratégique» [2006], Contretemps, 11 gennaio 2020, disponibile su https://www.contretemps.eu/retour-question-strategique-bensaid. ↩︎
- Alain Badiou, «A propos de la conjoncture actuelle», Quartier général, 2 dicembre 2020, disponibile su https://qg.media/2020/12/02/a-propos-de-la-conjoncture-actuelle-par-alain-badiou. ↩︎
- Ho spiegato più approfonditamente questi punti nel libro di interviste con Alexis Cukier pubblicato nel settembre 2015 da La Dispute con il titolo La Grèce, Syriza et l’Europe néolibérale, e più recentemente in un articolo pubblicato online il 30 agosto 2021 sul sito web di Contretemps: «Grèce, quand l’occupation des places ouvrait une brèche. Réflexions stratégiques, dix ans après» disponibile su contretemps.eu/grece-occupation-places-syriza-rupture-anticapitalisme. ↩︎
- Cfr. Cédric Durand, Razmig Keucheyan, «L’heure de la planification écologique», Le Monde diplomatique, n° 794, maggio 2020, disponibile su monde-diplomatique.fr/2020/05/DURAND/61748. ↩︎