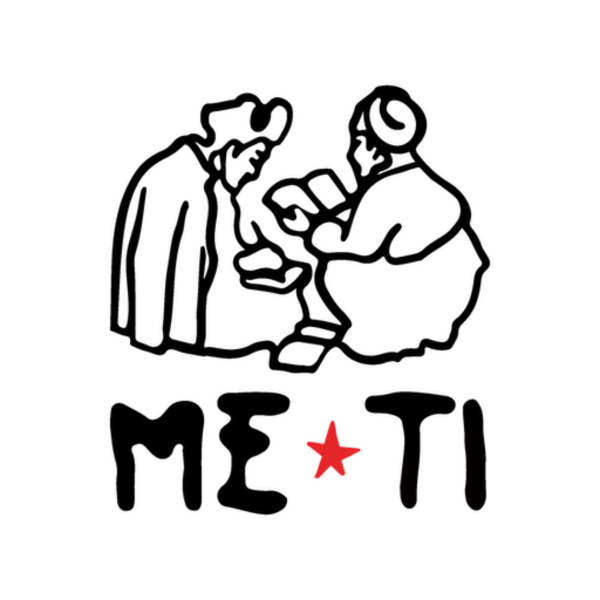Pensare dopo Gaza. Disumanizzazione, trauma e filosofia come freno d’emergenza
Vladimir Safatle*
Il testo che segue è la lezione inaugurale tenuta da Vladimir Safatle presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di São Paulo il 3 aprile 2024. L’autore, filosofo della tradizione della Teoria critica e uno tra i principali intellettuali pubblici brasiliani, analizza come la catastrofe di Gaza si iscrive nel nostro modo di agire e di pensare su scala globale. Ci vede una possibile rottura, un cambio di rotta verso l’erezione della disumanizzazione come modalità “normale” di governo, un segno della continua “palestinizzazione” del mondo a meno che, come il “freno a mano” evocato da Walter Benjamin, un soprassalto non possa fermare la corsa verso l’abisso.
***
Quando ho avuto l’onore di essere invitato dal nostro dipartimento a tenere questa lezione inaugurale, avevo inizialmente proposto un altro argomento di discussione. La mia idea iniziale era quella di parlare della tradizione del pensiero critico, a cui sono legato da quando ero studente di filosofia e mi trovavo nello stesso posto in cui vi trovate voi oggi. Voglio parlare della tradizione che ha usato la dialettica per capire l’impasse del processo di formazione e dello sviluppo nazionale. La stessa tradizione che si è dedicata a ripensare rigorosamente il potenziale del pensiero critico mobilitando la logica dialettica, proprio nel momento storico in cui questa dialettica veniva rifiutata nei Paesi centrali del capitalismo mondiale.
Vorrei parlare delle ragioni di questa discrepanza per comprendere meglio il nostro luogo di pensiero, nonché le crisi del presente e il loro potenziale di trasformazione. È stato anche il mio modo di rendere omaggio al notevole lavoro svolto nel nostro dipartimento da nomi come Paulo Arantes, Ruy Fausto, José Arthur Giannotti, così come Michel Löwy e, più lontanamente, ma non meno importante per la formazione di questo dibattito, da Rubens Rodrigues Torres Filho e, soprattutto, Bento Prado Júnior, a cui devo molto più di quanto possa esprimere qui. Nomi che spero tutti voi possiate conoscere e ammirare.
Tuttavia, dopo qualche giorno, ho chiesto al Dipartimento di cambiare il titolo della mia conferenza di benvenuto. Potrebbe sembrare, a prima vista, che tale cambiamento sia il risultato delle questioni più urgenti della cronaca, come se si trattasse di una capitolazione della filosofia di fronte ai titoli dei giornali. Al contrario, credo che questa decisione dica qualcosa su ciò che in ultima analisi dovremmo intendere per “filosofia”. È, a suo modo, un mezzo con cui ho cercato di rispondere a ciò che ci si aspetta da una conferenza inaugurale, ossia una riflessione sulla natura dell’attività filosofica e sul modo singolare in cui ciascuno di noi si relaziona ad essa.
Michel Foucault ci ha messo in guardia da chi intende la filosofia come una “perpetua ripetizione di se stessa, un commento infinito ai propri testi e senza alcun rapporto con l’esteriorità” [1], come se fosse possibile descrivere il sistema di motivazioni di un testo filosofico semplicemente sulla base di discussioni con i problemi ereditati da altri testi filosofici, in una sorta di catena chiusa di testualità che attraversa il tempo come un blocco intoccabile. Come se fosse auspicabile leggere i testi filosofici semplicemente cercando di esplicitare i loro ordini interni di ragioni, senza tener conto della loro capacità di risposta ai contesti e agli eventi sociali e storici.
Vorrei iniziare dunque suggerendo un’altra concezione dell’attività filosofica, da me appresa da un altro maestro che mi ha molto influenzato e al quale vorrei rendere omaggio: Alain Badiou. Badiou vede nella filosofia un certo modo di ascoltare gli eventi capace di far crollare il tempo presente. Questa formulazione insiste innanzitutto sul fatto che la filosofia sarebbe un ascolto del suo esterno: “una riflessione a cui è utile ogni materia estranea, o si potrebbe anche dire a cui è utile solo la materia che le è estranea” [2].
Questa frase è di Georges Canguilhem e credo sia il modo migliore per iniziare un corso di filosofia, in quanto risponde al problema dell’oggetto proprio della filosofia. Esiste, allora, un insieme di oggetti che potrebbero essere chiamati “oggetti filosofici”, così come diciamo che esistono oggetti e fenomeni specifici dell’economia, della teoria letteraria o della sociologia? E se esistesse un tale insieme di oggetti, un filosofo potrebbe parlare di un testo letterario, commentare un problema economico o discutere, ad esempio, della natura dei ruoli sociali? Così facendo, quindi, cesserebbe di essere un filosofo?
Quando Canguilhem dice che è utile alla filosofia solo la materia ad essa estranea, ci ricorda una caratteristica specifica del discorso filosofico, ossia che non ha oggetti propri. In un certo senso, la filosofia è un discorso vuoto perché non ci sono oggetti propriamente filosofici, il che forse spiega perché, ad esempio, non c’è teoria della conoscenza senza una riflessione approfondita sul funzionamento di almeno una scienza empirica, non c’è estetica senza critica d’arte, non c’è filosofia politica senza comprensione dei fatti politici e nemmeno ontologia senza logica. In tutti questi casi, la filosofia prende in prestito oggetti dal suo esterno, assorbendo conoscenze il cui sviluppo non le spetta direttamente.
Ma il fatto che non esistano oggetti propriamente filosofici non significa che non esistano domande propriamente filosofiche. Il fatto che la filosofia sia un discorso vuoto non significa che non sia pertinente. Al contrario, questa è la sua vera forza. Infatti, esiste un modo di costruire le domande che è peculiare della filosofia e che ammette praticamente qualsiasi oggetto. La caratteristica principale di una domanda filosofica è che si chiede come un fenomeno o un oggetto diventi un evento. In altre parole, non si tratta semplicemente di descrivere gli oggetti dal punto di vista funzionale, di giustificare la loro esistenza o di dare loro una ragione d’essere sulla base di una riflessione su ciò che dovrebbe essere.
La filosofia cerca di capire come la comparsa di certi oggetti e fenomeni produca cambiamenti nel nostro modo di pensare, nel senso più ampio possibile. Un evento non è un semplice avvenimento, ma è ciò che sfida la continuità del tempo, richiedendo l’emergere di un modo diverso di agire, desiderare e giudicare. È sempre una rottura che riconfigura il campo delle possibilità, portandoci ad abitare un mondo totalmente diverso, nonostante ci troviamo ad usare sempre le stesse parole.
In fondo, è di questi eventi, e solo di questi, che si occupa la filosofia. Per questo non è sbagliato dire che ogni esperienza filosofica è necessariamente legata a un evento storico: è la risonanza filosofica di un evento. La filosofia cartesiana deriva quindi dall’impatto filosofico della fisica moderna. È l’elaborazione, fino alle sue ultime conseguenze, della dissoluzione del mondo chiuso pre-galileiano e dell’avvento di un universo infinito di spazio omogeneo e a-qualitativo.
La filosofia hegeliana, da parte sua, può essere vista come il frutto delle aspirazioni emancipatrici della Rivoluzione Francese, delle sue tensioni e delle sue sfide. In altre parole, ogni esperienza filosofica originale nasce dall’elaborazione delle crisi del tempo, siano esse provocate da eventi politici, da sconvolgimenti nel nostro paradigma scientifico, da esperienze estetiche potenzialmente in grado di rompere il linguaggio o da nuovi ordini di desiderio. Queste crisi sono prodotte da eventi che hanno il potere di stabilire ciò che finora è stato nascosto alla rappresentazione, di rivelare ciò che mette in discussione il nostro modo di organizzare i nomi e le appartenenze.
Ma qui voglio parlare della fedeltà a un altro tipo di evento. E qui mi avvio su una strada che non è quella di Alain Badiou. È infatti possibile che un’epoca sia segnata da eventi che non sono portatori di nuove forme di relazioni, ma che sono espressione della dimensione dell’intollerabile. Sono quelle che di solito chiamiamo “catastrofi”. Chi vuole pensare agli eventi, deve anche saper smettere di pensare di fronte alle catastrofi. Non come se si trovasse di fronte all’incomunicabile e alla paralisi, ma come se capisse che si tratta di enunciare il segno finale di un’epoca che non può più durare. Il termine, che deriva dal greco, ha un’etimologia significativa. Kata “scendere” e strophein “girare”, termini originariamente utilizzati nella tragedia per indicare il momento in cui gli eventi si rivoltano contro il protagonista. In altre parole, il momento in cui la storia è costretta a cambiare bruscamente direzione.
Dove si trova Gaza?
Il nostro presente sta affrontando una catastrofe di questa natura. A mio avviso, sarebbe osceno utilizzare questa lezione inaugurale per parlare di qualcos’altro, come se questa catastrofe non fosse in mezzo a noi, a rosicchiare i nostri giorni, a urlare in faccia al nostro sonno dogmatico. Se parlassi d’altro, equivarrebbe a dire che la filosofia può ignorare il dolore, che può essere indifferente alla lacerazione dei corpi e al genocidio delle popolazioni, il che mi sembra un pessimo modo di iniziare un corso di filosofia. Sarebbe come insegnare l’indifferenza e dare l’impressione che possiamo continuare a fare il nostro lavoro come se nulla fosse. Ma non è certo mettendo a tacere il dolore che si comincia a pensare filosoficamente, bensì ascoltandolo, lasciando che il pensiero lo attraversi.
La catastrofe di cui parlo è legata a un luogo. Si chiama Gaza. Vorrei iniziare sottolineando che l’aforisma molto usato “ogni pensiero è pensato a partire da un luogo” ha diversi significati. Dobbiamo necessariamente particolarizzare i luoghi o mostrare come alcuni luoghi specifici ci permettano di cogliere la totalità funzionale del sistema sociale di cui facciamo parte? Il pensiero basato sul luogo ha una forza normativa limitata al luogo da cui emerge? In effetti, alcuni pensano che si debba partire dal principio secondo cui il pensiero sia limitato alla condizione di un punto di vista. Come se fossi necessariamente legato al luogo che occupo, che definirebbe il mio punto di vista, un luogo che un altro non potrebbe occupare, o un luogo che limiterebbe le mie pretese di parlare a nome di tutti e di chiunque. Alcuni chiamano questo “pensiero situato”. Ma io ho una concezione diversa dell’idea che “tutto il pensiero è pensato a partire da un luogo”.
Tutto il pensiero è pensato dal punto di vista della capacità di lasciarsi influenzare da certi luoghi che funzionano come sintomi della totalità sociale. Ci sono luoghi che sono come sintomi, nel senso di luoghi in cui una contraddizione globale diventa esplicita, in cui una verità espulsa ritorna, facendo zoppicare tutto il corpo. Un sintomo è ciò che ci impedisce di voltarci dall’altra parte, perché mette in evidenza qualcosa che può essere ignorato solo creando un dispositivo di “non voler sapere”, un sistema di silenziamento e cancellazione che fallisce sempre, e più fallisce, più diventa violento.
Se così fosse, allora “tutto il pensiero è pensato a partire da un luogo” non è necessariamente una proposizione che determina che solo chi si trova in un certo luogo (geografico, sociale) può pensare a certe situazioni. Piuttosto, ci ricorda che ci sono luoghi che ogni pensiero che aspira a un contenuto di verità non può ignorare e da cui non può deviare. Esiste quella che potremmo chiamare “universalità del combattimento”, che consiste nell’associarsi a un luogo da cui non proveniamo, abitato da persone che non hanno le nostre identità sociali e non condividono necessariamente i nostri modi di vita. Eppure la possibilità di un’umanità futura – e credo che questa idea abbia sempre più senso – dipende dal fatto che ci associamo a loro e che pensiamo in termini di luoghi. Per il nostro tempo, questo luogo è Gaza.
Potremmo iniziare chiedendoci cosa significhi che a Gaza è stato concesso uno status così eccezionale, quando ci troviamo di fronte al più grande massacro di civili del XXI secolo: ad oggi [il 03/04/2024] 32.700 persone. Mentre tutte le guerre messe insieme tra il 2019 e il 2022 hanno provocato la morte di 12.193 bambini, 12.300 bambini sono stati uccisi nei primi quattro mesi di guerra nella Striscia di Gaza. In questo momento, metà della popolazione di Gaza, ovvero 1,1 milioni di persone, si trova in uno stato di “fame catastrofica”, il livello più alto di fame secondo la Classificazione Integrata delle Fasi della Sicurezza Alimentare (IPC). “Si tratta del più grande numero di persone mai registrato come vittime di una fame catastrofica, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento”, secondo le parole del Segretario generale delle Nazioni Unite.
Ma non è la sua portata a fare di Gaza il punto di partenza per qualsiasi riflessione sulla catastrofe del nostro tempo. Dopo tutto, potremmo abbandonarci all’esercizio macabro e insensato di confrontare stermini e genocidi. A questo proposito, non posso che fare eco alle parole dell’antropologo Luis Eduardo Soares che, di fronte al paragone dei genocidi, che mira solo a limitare la nostra capacità di sentire l’intollerabile quando è proprio davanti ai nostri occhi, ha dichiarato in un testo memorabile: “i dolori non sono paragonabili, sono uguali” [3]. Sì, è vero. Non ha senso confrontare il dolore perché, fino a nuovo ordine, non esistono scale di intensità del dolore, misuratori di urla o termostati di esplosione degli edifici. Non possono essere paragonate cose che sono identiche.
In realtà, ciò che rende Gaza il punto di partenza della riflessione nel nostro tempo è la combinazione di quattro processi: la ripetizione, la desensibilizzazione, la de-storicizzazione e il vuoto giuridico. Vorrei parlare di ciascuno di essi perché non sono solo reazioni a ciò che proviene da Gaza, ma meccanismi governativi globali da applicare, su scala indefinita, a popolazioni poste in una situazione di estrema vulnerabilità. In altre parole, Gaza ci riguarda tutti perché siamo di fronte a una sorta di laboratorio globale per nuove forme di governo. Come abbiamo visto in altri momenti della storia, le pratiche e i meccanismi di violenza e asservimento dello Stato sviluppati in luoghi specifici vengono gradualmente generalizzati in situazioni di crisi. Quando pensatori come Berenice Bento affermano che è in atto una “palestinizzazione del mondo” [4], queste parole devono essere prese sul serio.
Permettetemi di offrire una breve analisi macrostorica per contestualizzare le mie osservazioni. Ci troviamo di fronte a una combinazione senza precedenti di crisi che non possono essere risolte all’interno del sistema capitalistico che le ha generate: crisi ecologiche, demografiche, sociali, economiche, politiche, psicologiche ed epistemiche. Crisi che, in larga misura, tendono a perpetuarsi e a diventare il normale regime di governo, come la lunga crisi politica delle istituzioni della democrazia liberale negli ultimi vent’anni, o la lunga crisi economica che dal 2008 incombe sulle giustificazioni delle politiche economiche dei nostri Paesi e delle nostre istituzioni.
Queste crisi non hanno impedito il mantenimento delle basi della gestione economica neoliberista, né l’approfondimento della sua logica di messa a tacere delle lotte sociali. Al contrario, si potrebbe addirittura dire che hanno fornito il terreno ideale per questi processi. Questa dinamica di normalizzazione delle crisi suggerisce che le nostre forme di governo cambieranno, perché possono normalizzare sempre più l’uso di misure eccezionali, violente e autoritarie nei processi di gestione sociale, dal momento che ci troviamo in una situazione di paura permanente.
Di fronte a una situazione di questo tipo, ci sono diversi esiti possibili. Uno è la trasformazione strutturale delle condizioni che hanno generato questo sistema di crisi combinate; l’altro è la generalizzazione del paradigma della guerra come strumento di stabilizzazione della crisi. Questa seconda opzione, che attualmente ci sembra la più naturale, richiede la generalizzazione della logica della guerra infinita come paradigma di governo. Infatti, la guerra infinita consente una sorta di corsa senza fine in cui il disordine permanente è l’unica condizione per preservare un ordine che non può più garantire orizzonti normativi stabili.
Di fronte alla decomposizione sociale, la guerra consente una certa forma di coesione, mentre naturalizza da un lato, dall’altro ripete e generalizza livelli di violenza e indifferenza che sarebbero inaccettabili in qualsiasi altra situazione. Ciò contribuisce a spiegare perché, a questo punto della storia, anche gli organismi di mediazione multilaterale come l’ONU sono crollati. Gaza ha segnato di fatto la fine delle Nazioni Unite come organismo vincolante, dal momento che anche una richiesta di cessate il fuoco da parte del Consiglio di Sicurezza viene accolta con sovrana indifferenza dallo Stato di Israele.
Ma al di là della generalizzazione della possibilità di guerre di conquista tra Stati con cartografie ridisegnate, il dato fondamentale del paradigma della guerra infinita è la riorganizzazione della società civile sulla base della logica della guerra. Ciò significa una forma di gestione sociale basata sulla militarizzazione delle soggettività, una militarizzazione che le porterà a naturalizzare l’esecuzione e lo sterminio, a organizzarsi in milizie, a identificarsi con la vuota virilità del debole armato, a trasformare l’indifferenza e la paura in affetti sociali centrali.
Questo si produce anche tramite la costruzione di nemici che non possono e non devono essere sconfitti, nemici eterni che devono periodicamente ricordarci la loro esistenza attraverso un attacco terroristico, un’esplosione spettacolare o un problema di polizia elevato a rischio di Stato. Infine, militarizzare le soggettività significa anche far implodere tutti i possibili legami di solidarietà in nome della difesa della mia comunità minacciata, della mia identità in pericolo che, proprio perché in pericolo, può produrre la peggiore violenza, come se avesse il diritto sovrano alla vita e alla morte contro un nemico che si fonde con l’altro. Quello che vorrei dimostrare è che questo processo inizia con la macabra operazione a cui assistiamo ogni giorno, che consiste nel far sì che le persone non si sentano Gaza. Questa è il vero esperimento sociale: desensibilizzare le persone alle catastrofi, fare in modo che non si indignino più e non agiscano per evitarli. Se ciò è possibile, Gaza sarà solo il primo capitolo di un’implosione sociale generalizzata.
Desensibilizzazione
Ciò che mi ha spinto a cambiare il tema di questa conferenza inaugurale è stata una scena che vorrei ricordare. È stata la scena del massacro di Al Rachid, dove più di 100 palestinesi sono stati uccisi dall’esercito israeliano mentre cercavano cibo. Come ha detto Benjamin Netanyahu a proposito di questo massacro: “succede”. In altre parole, è un evento ordinario che non merita la nostra attenzione.
Tuttavia, questo massacro ha avuto luogo due volte. Prima, attraverso l’eliminazione fisica di una popolazione ridotta a una massa affamata, che lotta per la propria sopravvivenza fisica. Poi, attraverso queste immagini. Il documento visivo che ha attraversato il mondo è stato la riduzione di questa popolazione a punti in movimento, che appaiono come un bersaglio in un videogioco. La prospettiva non è quella umana dei corpi che cadono. È la fredda prospettiva del drone che trasforma i corpi in entità indistinguibili, punti in movimento, macchie indistinte su uno schermo.
Ciò che ha documentato questa scena è un’immagine chirurgica, desensibilizzata dal punto di vista del drone, perché, dal punto di vista del drone, queste persone erano già morte. Erano punti e nulla più. Questo è il secondo massacro, il massacro simbolico, forse ancora più intollerabile del primo perché è l’espressione della riduzione dell’essere umano a una soglia tra il nulla e il qualcosa, la riduzione a un punto.
Tuttavia, questa immagine mostruosa ha rivelato la verità di un processo di desensibilizzazione che è una dimensione insormontabile del nostro discorso sulla giustizia, il suo punto cieco costitutivo. I nostri principi normativi di giustizia e riparazione includono necessariamente punti ciechi, aree di desensibilizzazione e disumanizzazione. Non si può vedere nulla in questi luoghi, i quali sono modellati da un bisogno fondamentale di prevenire il lutto collettivo, il lutto pubblico e l’indignazione.
È per questo che luoghi come Gaza sono parte integrante del nostro ordine politico: sono sempre esistiti e, in misura diversa, continuano a esistere. Gaza non fa che amplificare questa logica, esponendola in tutta la sua brutalità. Finora non c’è stato nessun ideale di giustizia senza cecità, nessuna difesa dell’integrità fisica dei soggetti senza il diritto di cancellarne altri. Non può essere altrimenti in un mondo soggetto all’estensione illimitata di un sistema di produzione in cui la possibilità di un’uguaglianza radicale è strutturalmente negata.
È interessante notare questa desensibilizzazione non solo nel discorso politico globale, ma anche tra i filosofi apparentemente impegnati nelle più alte concezioni emancipatorie del pensiero critico. Il 13 novembre 2023, figure chiave della teoria critica contemporanea – proprio quella a cui mi sento legato – come Jürgen Habermas, Rainer Forst, Nicole Deitelhof e Klaus Günther hanno ritenuto opportuno pubblicare un testo sul conflitto palestinese e le sue conseguenze intitolato “I principi della solidarietà”.
Iniziando con l’attribuire tutta la responsabilità della situazione agli attacchi di Hamas, come se tutto fosse iniziato il 7 ottobre 2023, difendendo il “diritto di risposta” del governo israeliano e facendo osservazioni procedurali sulla presunta natura controversa della cosiddetta “proporzionalità” della sua azione militare, il testo conclude affermando che sarebbe assurdo presupporre “intenzioni genocide” da parte del governo israeliano di estrema destra, invitando tutti alla massima cautela di fronte ai “sentimenti e alle convinzioni antisemite che si nascondono dietro ogni forma di pretesto”. Quello che posso dire [oggi], 3 aprile 2024, è che finora nessuno si è scusato per questo macabro articolo.
Ciò che mi interessa qui è il modo in cui questo articolo dimostra che i principi universali di giustizia possono benissimo essere usati strategicamente per espiare i fantasmi locali di responsabilità per i disastri del passato, creando così una strana desensibilizzazione per mezzo di argomenti morali. Il testo mostra come la fedeltà al trauma storico, il senso di responsabilità per il passato, possa portare a una profonda desensibilizzazione del presente. Soprattutto, mostra che la richiesta di memoria a cui il popolo tedesco fu sottoposto non fu un lavoro di elaborazione e riflessione. Si trattava piuttosto di un addestramento. Al contrario, c’è riflessione quando si comprende, ad esempio, che “l’odio si scatena su vittime indifese. E poiché queste vittime sono intercambiabili, a seconda delle circostanze: ‘zingari’, ebrei, protestanti, cattolici, ognuno di loro può prendere il posto degli assassini, con la stessa cieca voluttà di sangue, non appena si sente potente, perché è diventato la norma” [5].
Questo è un passaggio de La dialettica dell’illuminismo di Adorno e Horkheimer. Ci ricorda che non dobbiamo guardare agli attori dell’oppressione sociale, perché possono cambiare posto. L’esperienza dell’oppressione non è sufficiente a produrre pratiche di emancipazione e giustizia. Al contrario, spesso può portare a giustificare pratiche di autoconservazione della comunità di fronte alla memoria sempre ricorrente alle violenze passate. Siamo stati esposti alla violenza e abbiamo il diritto di fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire che l’ombra di quella violenza non incomba più su di noi. E potremmo ricordare diversi momenti in cui l’oppressione precedente ha finito per giustificare pratiche di separazione.
La società è in grado quindi di mobilitare tutte le sue risorse e forze per approfondire le divisioni tra i gruppi, rafforzare la sicurezza e stabilire i confini. Non è un caso che l’apartheid sia stato creato da un popolo, gli afrikaner, che in precedenza era stato vittima del primo uso sistematico dei campi di concentramento e delle pratiche di sterminio. Quando non siamo in grado di riflettere sui processi, ci conformiamo a un immaginario impermeabile. Invece di comprendere strutturalmente le dinamiche della violenza e dello sterminio e la possibile trasformazione dei suoi attori, ci fissiamo su immagini e rappresentazioni fisse, anche se oppressi del passato stanno massacrando nuovi popoli oppressi.
Di fronte a loro, dobbiamo ricordare che il “genocidio” si verifica ogni volta che viene negato il legame organico delle popolazioni con il genos, con ciò che abbiamo in comune. Quando il ministro della Difesa israeliano [Yoav Gallant] dice che di fronte ci sono “animali umani”, esprime pedagogicamente intenzioni genocide. Quando il Presidente di Israele dice che non c’è differenza tra civili e combattenti e sottopone l’intera popolazione palestinese a una punizione collettiva; quando i ministri del governo israeliano dicono che l’uso di bombe nucleari contro Gaza è plausibile e [per punizione] vengono semplicemente esclusi dalle riunioni ministeriali; quando scopriamo i piani per lo spostamento di massa dei palestinesi in Egitto; quando il ministro [israeliano] per l’uguaglianza sociale e l’emancipazione femminile dichiara di essere “orgogliosa delle rovine di Gaza” e che, tra 80 anni, tutti i bambini potranno raccontare ai loro nipoti ciò che gli ebrei hanno fatto lì, ecco, quando tutto ciò si verifica, non siamo solo di fronte a intenzioni genocide, ma a una delle più sordide e intollerabili dichiarazioni del culto della violenza che si possano immaginare. È una chiara e imperdonabile espressione di pratica genocida e tutto ciò non ha portato a nessuna minima pressione per rimuovere questi individui dal governo.
Il genocidio non è legato a un numero assoluto di morti; non esiste un numero al di sopra del quale siamo autorizzati a parlare di genocidio. Il genocidio si riferisce a una forma specifica di azione statale nella cancellazione dei corpi, nella disumanizzazione del dolore delle persone, nella profanazione della loro memoria, nel silenzio del lutto pubblico che priva queste persone della loro appartenenza al genos.
E non ha senso fare riferimento, in questo contesto, alla fallace teoria dello “scudo umano”, classica risposta coloniale alla violenza dei colonizzati. Anche se accettiamo, per amor di discussione, che un gruppo armato di combattimento prenda in ostaggio una popolazione e la usi come scudo, questo non dà a nessuno il diritto di ignorare quella stessa popolazione e di trattarla oggettivamente come un complice o come qualcuno la cui morte è solo un effetto secondario. Fino a nuovo ordine, il diritto al massacro non è ancora stato inventato.
Permettetemi inoltre di insistere su un punto durante questo dibattito. La storia dello Stato di Israele ci dimostra che uno Stato nazionale non può essere costruito come custode della memoria di un trauma collettivo senza poi deteriorarsi. Sappiamo che l’intero processo di creazione di Israele, un processo unico e singolare, è stato fondato sulla memoria del trauma della catastrofe dell’Olocausto e sulla consapevolezza globale che nulla di simile sarebbe dovuto accadere di nuovo. Sappiamo anche che il trauma può creare legami sociali. La condivisione della violenza subita, il ricordo dell’inganno e della perdita sono elementi forti nella creazione di legami di ogni tipo.
L’identificazione con il trauma collettivo consolida le identità e sottrae i soggetti alla vulnerabilità, perché la comunità creatasi dalla condivisione del trauma ha il potere di consolidare le memorie e di fornire la base per le lotte. Ma i momenti di attaccamento sociale al trauma collettivo sono due e questo è solo il primo. C’è un secondo momento nel legame sociale prodotto dalla condivisione del trauma, che va evitato. Gestito dallo Stato-nazione, il dovere di ricordare il trauma finisce necessariamente per aprire la strada all’autorizzazione della violenza contro tutto ciò che è associato al trauma, sia all’interno che all’esterno della nazione. Non è lo Stato nazionale che può essere il custode del trauma sociale, ma deve essere la comunità.
Infatti spetta alla comunità impedire che lo Stato si appropri del trauma, affinché l’esperienza del trauma non perda il suo potere sociale di creare legami che ancora non esistono, comunità senza limiti né confini. Una forza che nasce dalla certezza che il trauma non deve ripetersi mai più, in nessun luogo, e soprattutto in territori occupati illegalmente.
De-storicizzazione e vuoto giuridico
Ma c’è qualcos’altro che colpisce nel testo firmato da Habermas e altri. È la loro de-storicizzazione e la loro indifferenza per il vuoto giuridico a cui sono sottoposti i palestinesi. Alcuni vorrebbero iniziare questa discussione con i terribili attacchi perpetrati da Hamas il 7 ottobre. Le mie critiche ad Hamas sono state ripetute più volte negli ultimi anni e il mio rifiuto assoluto delle azioni indiscriminate contro i civili è incondizionato [6]. Ma la pratica della desensibilizzazione consiste nel privare le persone della storia delle loro lotte.
I palestinesi stanno lottando da decenni contro i massacri periodici e indiscriminati, contro una situazione sociale di popolo apolide, senza Stato né territorio, costantemente sottoposto a una vita precaria e a una morte senza lutto. La caratteristica fondamentale della vita a Gaza è la brutale ripetizione dei massacri. Operazione Pioggia d’Estate nel 2006; Operazione Nuvole d’Autunno nel 2006; Operazione Piombo Fuso nel 2008; Operazione Colonna di Nuvole nel 2012; Operazione Margine di Protezione nel 2014; Conflitto Armato nel 2021. Questi sono solo gli ultimi atti di violenza contro i palestinesi che vivono a Gaza, ripetuti all’infinito e soggetti alla stessa indifferenza.
Si potrebbe dire che tutte queste operazioni sono un esercizio del diritto dello Stato di Israele a difendersi da un gruppo che vuole eliminarlo. Ma questa forma di difesa non è una difesa. Facciamo un esercizio di proiezione di base. Cosa succederà dopo la cosiddetta “azione militare” di Israele a Gaza? Hamas sarà distrutto? Ma cosa significa esattamente “distruzione”? Al contrario, non è proprio così che Hamas si è sviluppato, cioè dopo le inaccettabili azioni di punizione collettiva e l’indifferenza internazionale? E anche se i leader di Hamas vengono uccisi, non emergeranno altri gruppi, alimentati dalla spirale di violenza sempre più brutale?
Sarebbe importante partire dal fatto storico che tutti i tentativi di annientare militarmente Hamas non hanno fatto altro che accrescere la sua forza, perché queste azioni militari hanno creato la cornice narrativa ideale per farlo apparire, agli occhi di una larga parte dei palestinesi, come il legittimo rappresentante della resistenza all’occupazione.
E come se non bastasse, non si può rivendicare il diritto all’autodifesa di fronte alle reazioni di un territorio che si occupa illegalmente. Contrariamente a quanto alcuni credono, il diritto internazionale esiste e stabilisce chiaramente cosa si deve fare. Il diritto internazionale riconosce lo status giuridico della Palestina come “territorio occupato”, un’occupazione considerata totalmente illegale dalle risoluzioni 242 e 338 delle Nazioni Unite, approvate oltre cinquant’anni fa. In altre parole, la migliore difesa è rispettare il diritto internazionale e restituire i territori occupati. A Gaza, tuttavia, il diritto non ha più forza di legge.
In realtà, lasciare un popolo senza legge, senza Stato, senza cittadinanza, è una pratica di costruzione di vuoti giuridici che ci riporta al cuore dell’insormontabile colonialismo delle nostre società moderne. Le nostre società rimangono coloniali. La domanda centrale è “contro chi?” Possiamo parlare di permanenza del colonialismo perché siamo di fronte a un potere sovrano che decide quando la legge è in vigore e quando è sospesa, su quale territorio si applica e su quale territorio è impotente. Qualcuno la chiama “democrazia”. Ma è semplicemente la condivisione di una geografia del diritto tipica delle relazioni coloniali.
Per questo vorrei concludere deplorando energicamente quegli accademici che si dichiarano custodi del pensiero postcoloniale ma che sono rimasti vergognosamente in silenzio di fronte a una tipica catastrofe coloniale, che si sono limitati a dichiarazioni formali, che sembrano più indignati per i problemi di pronomi che per i corpi sepolti sotto le macerie delle bombe. Chiunque voglia pensare in modo critico deve essere disposto a non anteporre gli interessi personali agli impegni necessari.
Ho veramente il sospetto che il post-colonialismo di alcune persone si fermi ai confini del comitato per la diversità del Magazine Luiza [una catena di supermercati brasiliana]. E vorrei cogliere l’occasione per salutare la profonda coerenza e l’onestà intellettuale di alcuni accademici, come Judith Butler, Nancy Fraser e Angela Davis, che hanno subito le peggiori rappresaglie e stigmatizzazioni per aver mostrato solidarietà con la condizione dei palestinesi in un momento in cui la solidarietà è diventata una delle armi più rare.
A mio avviso, alcune di queste persone hanno capito che la filosofia deve fungere da freno d’emergenza in momenti come questi. Forse conoscete questo passaggio di Walter Benjamin: “Marx dice che le rivoluzioni sono la locomotiva della storia universale. Ma forse le cose stanno in modo del tutto diverso. Forse le rivoluzioni sono il ricorso al freno d’emergenza da parte del genere umano in viaggio su questo treno” [7]. In un momento in cui diventa sempre più evidente il rapporto organico tra gli ultimi muri della civiltà occidentale e lo sterminio, tra gli ultimi argini della democrazia e la catastrofe, diventa sempre più evidente, vale la pena ricordare che i veri gesti rivoluzionari sono quelli che decidono di attivare il freno d’emergenza.
Ecco perché vorrei concludere questa conferenza inaugurale facendo appello alla lingua parlata dalla gente di Gaza. La lingua che era la lingua dei miei antenati, ma che non veniva mai parlata nelle nostre case, la lingua che non ho mai sentito perché il suo silenzio rappresentava la convinzione di una perfetta integrazione con l’Occidente.
In un momento di disgregazione, voglio concludere con questa lingua messa a tacere dalla convinzione di un’integrazione che non è mai avvenuta come promesso, come se si trattasse di salvare dalle rovine ciò che è stato escluso dalla nostra voce, in modo che questa lingua, uccisa, potesse rivelare il dolore delle promesse non mantenute e la continuità delle lotte. Con la lingua del popolo di Gaza, vorrei ricordarvi che non c’è libertà senza terra e che “non c’è vita senza libertà”: ل حياة بدون حرية
Intervento tradotto in francese e pubblicato il 19 giugno 2024 da contretemps
*Vladimir Safatle è professore presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di São Paulo. Ha insegnato anche nelle università di Parigi I, Parigi VII, Parigi VIII, Parigi X, Tolosa, Lovanio ed Essex. È responsabile dell’edizione delle opere complete di Theodor Adorno in portoghese. È anche un intellettuale pubblico molto attivo nella politica brasiliana, con una presenza costante sulla stampa nazionale e internazionale. Il suo libro Il circuito degli affetti. Corpi politici, abbandono e il fine dell’individuo è disponibile in traduzione italiana (Roma, Aracne Editrice, 2021).
Note
[1] Michel Foucault, Dits et écrits, livre 1: 1954-1975, Paris, Gallimard-Quarto, p. 1152.
[2] Georges Canguilhem, Il normale e il patologico, Roma, Einaudi Editori, 1998.
[3] Luis Eduardo Soares, “As palavras apodrecem”, A Terra é Redonda, 21 febbraio 2024.
[4] Berenice Bento, “Defensores de Israel usam antisemitismo como instrumento de chantagem”, Folha de São Paulo, 18 gennaio 2024.
[5] Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, La dialettica dell’illuminismo, Roma, Einaudi, 2010.
[6] Si veda, ad esempio, Vladimir Safatle, “O suicídio de uma nação e o extermínio de um povo”,
Revista Cult, 23 ottobre 2023.
[7] Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Francoforte, Suhrkamp, 1977, vol. I, 3, p. 1232. Si
tratta di una delle note preparatorie per le Tesi sul concetto di storia, che non compare nelle versioni
finali del documento.