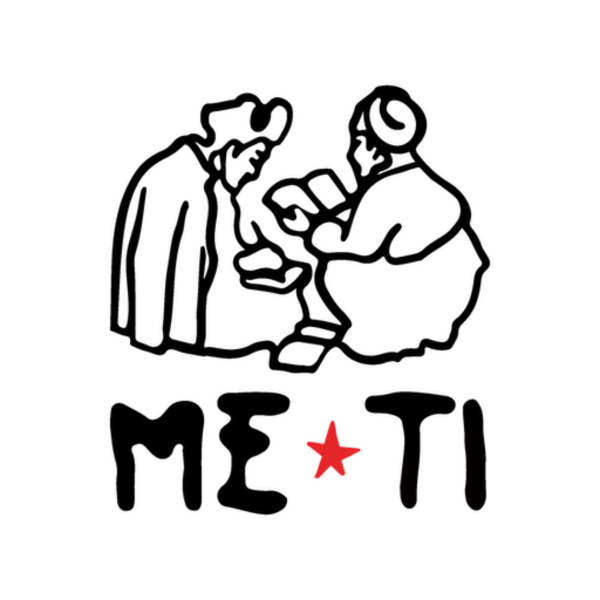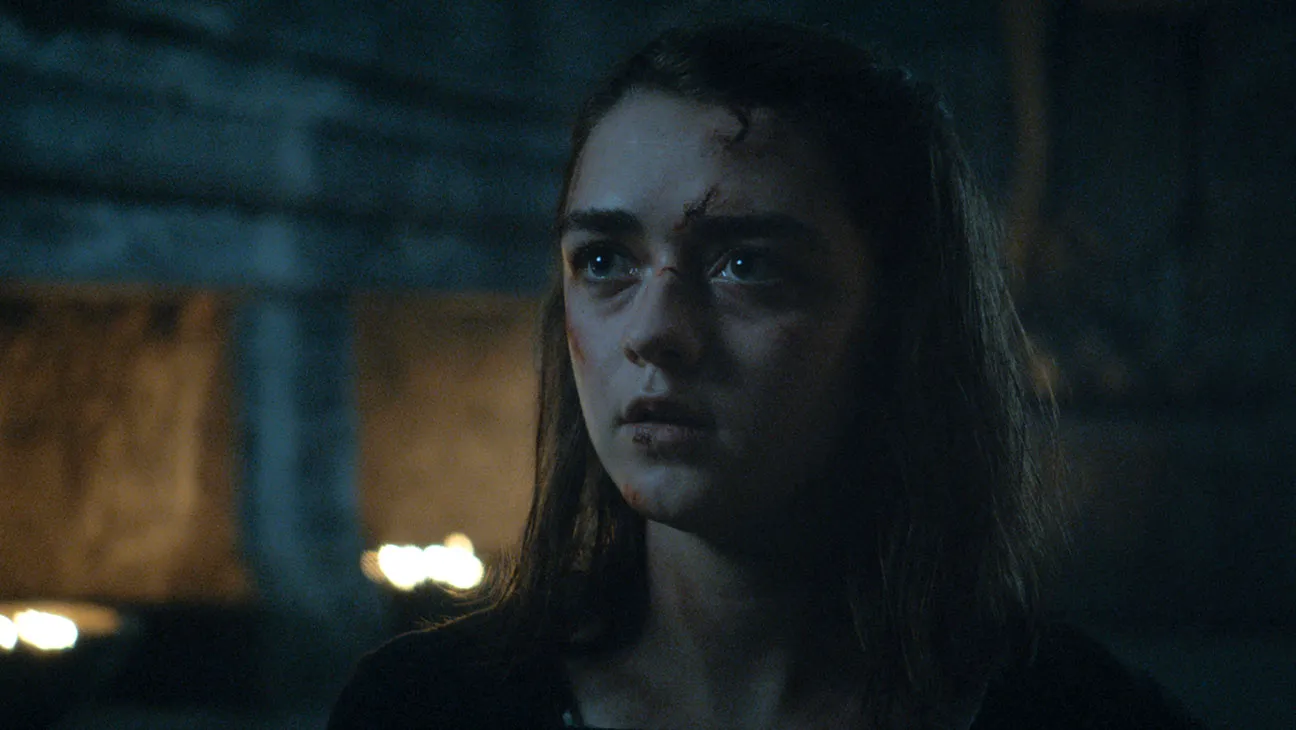Ogni sera Arya Stark, come una ninna nanna, elencava i suoi nemici: “Cersei Lannister, Il Mastino, Meryn Trant…”, immaginava di ucciderli addormentandosi con i loro nomi sulle labbra. Şeyda Kurt autrice di Odio. Il potere della resistenza (Minimum Fax, 2023) racconta di aver avuto, da bambina, un rituale notturno non molto diverso da quello dell’eroina di Game of Thrones: “Avevo sette o otto anni quando ogni sera, prima di addormentarmi, visualizzavo la scena che segue: un giorno sarei stat* molto potente (…). E tutt* coloro che mi avevano fatto del male si sarebbero messi in fila. E io li avrei giudicati. (…) Tutt* quelli che mi hanno sgridato e umiliato. Io pronunciavo un giudizio. E spesso il giudizio che avevo in mente era la pena di morte. Giudicavo e giustiziavo. Era uno dei miei sogni preferiti” (p. 119).
In questi giorni siamo arrabbiate, siamo furiose: odiamo. E ne abbiamo tutte le ragioni. Per questo forse non c’è un momento più adatto per riflettere su questo sentimento e sul suo senso politico. Questa riflessione può essere accompagnata da Şeyda Kurt, nata a Colonia da una famiglia turco-tedesca, che ci propone di analizzare in chiave politica quello che sembra il più pericoloso dei sentimenti, il più viscerale e irrazionale. Intanto mostrandoci che l’odio è una possibilità che non è data a tutte le persone, che l’odio dei subalterni è ben diverso da quello dei dominanti.
Riprendendo la lezione di Fanon sulla violenza, Kurt mostra come accanto all’odio nei confronti di chi ci domina esiste un odio contro noi stessi – per non riuscire ad aderire ai modelli considerati socialmente accettati, un odio che assomiglia all’autocolonizzazione, che si nutre dell’universo simbolico dell’avversario (pp. 25 e ss). Che i modi di odiare delle persone marginalizzate, subalterne, sono spesso puramente reattivi, finiscono per individuare bersagli sbagliati, per metterle le une contro le altre, per non generare riconoscimento ma divisione.
Ma c’è di più. Per le persone razzializzate, per le donne, per chi vive ai margini, mostrare rabbia e odio finisce per rappresentare la prova definitiva della loro inferiorità, della loro incapacità a gestire razionalmente le controversie, del loro essere animaleschi. Diventa la conferma che “questi soggetti” non possono e non debbono avere autonomia, che devono essere repressi, governati, controllati a vista, “la rabbia degli oppressi non può venir contemplata (…) se non sotto forma di vergognosa escrescenza, di eccesso da sedare in modo immediato e se necessario violento”1.
Che le persone oppresse provino odio o siano arrabbiate non diviene così sintomo della condizione iniqua nella quale sono costrette, ma anzi è segno che quella è l’unica posizione nella quale possono e devono effettivamente stare, pena il disordine sociale. Odio, reazione, violenza, rabbia, autodifesa sono appannaggio esclusivo di chi domina – di chi ha il diritto di definire il senso ultimo di queste espressioni e di stabilire cosa sia lecito fare e, addirittura, sentire2 – così, per le persone dominate “mostrarsi gentili o premuros* può (…) diventare una strategia di sopravvivenza” (p. 32).
“Chi ha il diritto di difendersi? Chi secondo le convenzioni sociali perpetra una violenza che viene considerata legittima? (…) Anche l’odio e la violenza seguono l’economia del dominio” (pp. 38-39). Quando si parla di odio è necessario porsi la domanda non solo sulle ragioni di questo sentimento ma anche sui rapporti di potere ad esso sottesi.
Nel dire che le persone oppresse devono (ri)trovare la possibilità e il modo di odiare, Kurt non intende sostenere che bisogna dare spazio all’“assurda idea di un ritorno a uno stato di natura dell’odio, in cui ci liberiamo dai vincoli sociali e possiamo sfogare liberamente la nostra rabbia”, le “interessa invece cercare un altro potenziale dell’odio, un potenziale di resistenza” (p. 45). Dunque questo libro non è solo un libro sul diritto all’odio e alla rabbia, ma sul loro senso politico e il loro potenziale strategico, Kurt parla infatti di “un odio che sia ponderato, tattico e prudente” (p. 92). Sono molti anni che durante le riunioni dello spazio sociale in cui faccio attivismo usiamo ripeterci una frase “la politica è una guerra di pazienza” (la traduco dal mio dialetto), che non significa che dobbiamo subire passivamente, né rassegnarci, ma che l’odio e la rabbia sono potenti solo se uniti alla capacità di attendere, di utilizzarli nel modo e nel momento giusto. L’odio e la pazienza non sono opposti ma, paradossalmente, complementari3: “abbiamo perso la pazienza. E allo stesso tempo abbiamo ancora bisogno della pazienza, di avere una pazienza che non sia alimentata dalla tolleranza, ma dalla perseveranza” (p. 43). Un modo per fare buon uso dell’odio, un uso politico, è utilizzarlo come sprone e come collante, per tenerci insieme, per riconoscerci nell’individuazione di un comune avversario, non per ripiegarsi nel risentimento e nella frustrazione. Bisogna seguire l’insegnamento delle donne resistenti curde che ci dicono che “la rabbia e l’odio contro il nemico devono essere trasformati per diventare fonte di forza e determinazione” (p. 166).
Kurt mette in guardia dall’odio individuale che, come per Fanon, è sentimento legittimo, ma non attivante, che anzi rischia di replicare o di lasciare immutati gli schemi e i meccanismi che vorremmo distruggere. In riferimento al film del 2020 Una donna promettente (del quale vorrei parlare per 3 giorni di fila, ma vi risparmierò, almeno in questa occasione), l’autrice sottolinea come la protagonista rivendichi sì “il proprio ruolo”, ma che “allo stesso tempo (…) il percorso di vendetta di giustizia personale di Cassie viene ridotto a una lotta individuale. E in questo modo anche la sfera comunitaria e politica vengono eliminate” (p. 125). La protagonista del film di Emerald Fennell è una combattente solitaria, il suo odio è pure giusto, ma non è politico. Kurt rivede la stessa attitudine nella “maggior parte degli approcci femministi o antirazzisti (…). Empowerment può significare scoprire il proprio diritto all’autodeterminazione e all’emancipazione (…) ma l’impoteramento individuale non deve essere l’obiettivo finale, perché non sarebbe altro che un ‘neoliberalismo soft’” (p. 126). L’odio da collante e spinta può allora trasformarsi in limite e fattore disgregante e depotenziante quando si mescola a logiche identitarie – e più o meno consapevolmente neoliberali4.
Esempio di questa deformazione dell’uso (im)politico dell’odio è il libro della scrittrice francese Pauline Harmange, Odio gli uomini (2020, in fr. Moi les hommes, je les déteste). Kurt sottolinea che il principale obiettivo di questa dichiarazione d’odio è quello di distruggere un’immagine del femminile come incarnazione della gentilezza, della passività e dell’accondiscendenza, e, giustamente, di rivendicare la possibilità per le donne – e per le persone oppresse in genere – di essere arrabbiate, violente, di poter odiare. Eppure, c’è qualcosa che non va in questo progetto. “L’odio condiviso dovrebbe offrire alle donne una via d’uscita dall’isolamento patriarcale. Dopotutto non si può fare una festa da sole! E per quanto voglia augurare ha Pauline Harmange tutti i festeggiamenti possibili e litri di cocktail (…) leggo le sue battute con un certo disagio” (p. 129).
Con quale diritto, sottolinea Kurt, una donna bianca francese dovrebbe poter dichiarare di odiare un uomo razzializzato che nella Nuova Caledonia sta combattendo per l’indipendenza del suo paese dalla Francia? Di quali uomini stiamo parlando? Solo degli uomini bianchi cis e privilegiati, o anche di quelli poveri, sfruttati, razzializzati? Anche degli “uomini femministi” e di quelli che combattono fianco a fianco con noi? (cfr. p. 129). “Il problema sta proprio nel nucleo basilare dell’organizzazione della festa, cioè nella caratteristica che permette alle persone di accedervi: la loro identità di genere” (p. 130). Una “festa”, una battaglia che si costruisce attorno a un noi così delimitato e definito denota ben poca lungimiranza politica. “Per partecipare alla festa le persone non devono soddisfare alcun requisito relativo al loro modo di agire. Devono solo essere (state). Essere colpite direttamente” (p. 131): questo il limite politico dell’odio proposto da Harmange. La solidarietà tra donne, in questo caso, e in generale tra simili, “non è solo ingannevole: non è neppure desiderabile. Non tutte le donne condividono la mia visione politica di un mondo senza sfruttamento. Anche le donne possono essere di destra, fasciste, sfruttatrici” (p. 131).
Allora perché l’odio sia davvero politico, trasformativo, o addirittura riumanizzante, dobbiamo imparare a odiare, imparare a indirizzare la nostra rabbia e finalizzarla al cambiamento, altrimenti corriamo due rischi:
- quello di odiare le persone e non i sistemi, di odiarle per ciò che sono e non per ciò che fanno: “Chi o cosa vogliamo odiare? A) L* capitalist* o il capitalismo? B) Le persone bianche o il razzismo? C) Gli uomini cis o il patriarcato?” (p. 123).
- di dare spazio al poliziotto che abita nelle nostre teste e che costantemente ci suggerisce con la sua voce insistente: “punizione punizione punizione”. Come facciamo a metterlo a tacere? Praticando l’abolizionismo, distinguendo l’odio (politico) dal desiderio di castigare.
L’abolizionismo prevede due processi che avvengono in contemporanea: la distruzione e sovversione completa dei sistemi di oppressione e la costruzione di reti solidali, di sostegno, di alleanze fattive5. Una ricostruzione che faccia sì che tutte le istituzioni che oggi non hanno da offrire che punizione possano offrire supporto, che ci metta in condizione di mettere in piedi “una società in cui le condizioni abitative, lavorative di comune convivenza sono strutturate in modo da evitare che le persone diventino violente” (p. 152).
La domanda alla quale dobbiamo rispondere non riguarda allora tanto la legittimità del nostro odio e della nostra rabbia – molto probabilmente sono perfettamente leciti e comprensibili soprattutto se abbiamo subito violenza, soprattutto quando questa violenza è continuativa e sistematica. La nostra domanda ha a che fare col modo di non disperderli, col modo di uscire dalla condizione in cui l’odio ci è necessario perché siamo sole, “piccole”, inadeguate ed entrare in quella in cui siamo insieme, siamo grandi, siamo capaci di usarlo come strumento politico: “Non ho più otto anni e non desidero compensare la mia sensazione di impotenza con fantasia di onnipotenza. Non siedo su nessun trono; anzi sono contro ogni trono” (p. 139).
- F. Palazzi, La politica della rabbia. Per una balistica filosofica, Nottetempo, Roma 2021, p. 21. ↩︎
- Cfr. J. Butler, La forza della nonviolenza, Nottetempo, Roma 2020. In particolare sulla messa al bando della rabbia manifestata dalle donne e dalle persone colonizzate si veda anche https://www.progettometi.org/analisi/rage-sense-and-sensibility/ ↩︎
- Cfr. S. Prinzi, Sul buon uso dell’impazienza: Crisi, movimenti, organizzazione, Liguori, Napoli 2012. ↩︎
- Su questo vi invitiamo a leggere Alleanze ribelli. Per un femminismo oltre l’identità (in uscita a maggio 2025) pubblicato da Progetto Me-Ti. ↩︎
- A. Davis, G, Dent, E. R. Meiners, Abolizionismo. Femminismo. Adesso, Alegre, Roma 2023. Sulla capacità di distinguere giustizia e punizione cfr. https://www.progettometi.org/analisi/faire-justice-giustizia-transfemminista-e-moralismo-progressista/ ↩︎